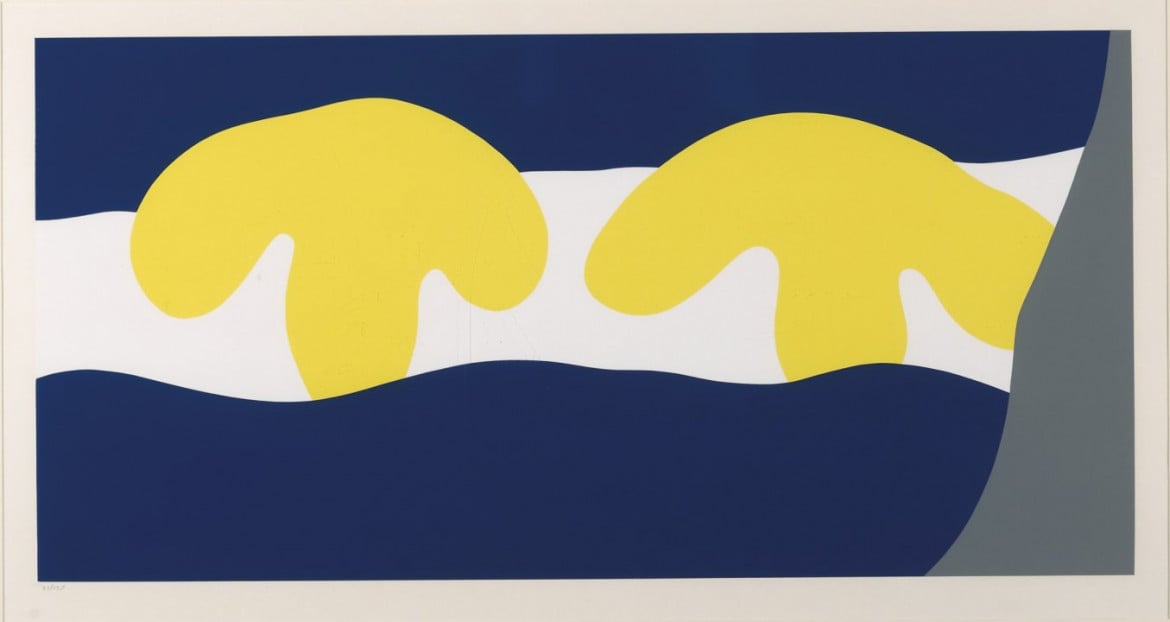Intervistato da Gilles Lapouge nella tarda primavera del 1968, pochi giorni prima della morte improvvisa, Alexandre Kojève rispondeva così alla domanda sulla propria formazione filosofica a Heidelberg e Berlino: «Quanto a Hegel, lessi quattro volte per intero la Fenomenologia dello Spirito. Mi accanivo. Non ne capii una parola. Poi ci fu Parigi. Un giorno del 1933 Koyré, che teneva corsi su Hegel, dovette interromperli, e mi proposero di prendere il suo posto. Accettai Non preparavo nulla, leggevo e commentavo, ma tutto quello che scriveva Hegel mi sembrava luminoso».
Seguite da Queneau, Lacan, Bataille, Caillos, Leiris, Klossowski, Léon Poliakov, Raymond Aron, Merleau-Ponty, Raymond Polin, da André Breton e a volte da Hannah Arendt, quelle celebri lezioni all’École Pratique des Hautes Études, bruscamente interrotte nel settembre 1939 dalla mobilitazione generale, segneranno come uno spartiacque la scena culturale del dopoguerra, guidando la forte corrente del neo-hegelismo francese che, già nutrita dal precursore Jean Wahl, poi da Eric Weil e Jean Hyppolite, ridurrà ai margini il bergsonismo, almeno fino alla sua rinascita in Deleuze.
All’evidente successo e alla grande diffusione di quei corsi, curati da Queneau per Gallimard nel 1948 – e parzialmente tradotti lo stesso anno da Einaudi (la versione integrale uscirà da Adelphi nel 1996) – doveva rispondere però un cambiamento sconcertante nella vita di Kojève. Nel 1945, infatti, il filosofo tanto giovane quanto autorevole, abbandonerà ufficialmente le sue ricerche per intraprendere la carriera di alto funzionario diplomatico. Ovvero, per farsi «philosophe du dimanche», secondo l’appellativo coniato dallo stesso Queneau, il quale lamentava: «le attuali occupazioni di Kojève non gli hanno permesso di scrivere l’Introduction à la lecture de Hegel che ci aspettiamo da lui» (e che ci resta appunto come trascrizione di quattro conferenze).
La fonte luminosa d’ispirazione si era di colpo offuscata? Certo aveva continuato a brillare in tutta la sua intensità nel periodo che Kojève trascorse, sotto Petain, nel sud della Francia, dedicandosi a due lavori di primaria importanza come La notion de l’autorité (terminato nel maggio del ’42 e pubblicato solo nel 2004) e la monumentale Esquisse d’une phénoménologie du Droit (ultimata nel dicembre ’43 ma poi lasciata nel cassetto e uscita nel 1981). Ed è proprio quest’opera poderosa, scritta con stupefacente rapidità in circa sei mesi, che appare oggi, per le ottime cure di Marco Filoni e Luigi Garofalo, col titolo Lineamenti di una fenomenologia del diritto Esposizione provvisoria (traduzione di Alberto Folin, Marsilio, collana Firmamenti, pp. 739, € 55,00).
Che cos’è dunque il diritto, secondo Kojève? La definizione è cristallina: una relazione che esiste solo in presenza di tre persone, cioè di due soggetti che interagiscono (l’uno per diritto positivo, di azione, l’altro per quello negativo o dovere di non opporsi) di fronte a un terzo disinteressato, sia legislatore che crea la norma, giudice che la applica o funzionario di polizia che la esegue.
Ora, se un rapporto a due non è ancora sociale, tre persone distinte e interagenti costituiscono una Società: non vi è dunque diritto se non in Società, come non c’è Società senza diritto. Si tratterà tuttavia di un diritto solo potenziale, se la coercizione statuale non conferisce forza di legge all’arbitraggio del terzo. La formula (doppia e reversibile) sarà quindi: non c’è società senza diritto in potenza, né diritto in atto senza Stato. Nella stessa prospettiva, le diversità, il contenuto, la complessità dell’universo giuridico dipenderanno sia dalla ricchezza delle interazioni sia dalla persona disinteressata che, variando il contesto sociale, potrà intervenire o meno di fronte alla medesima situazione.
È così proprio il terzo soggetto – e soprattutto nella figura del giudice – a incarnare l’essenza di un fenomeno che risale al desiderio umano di giustizia e al piacere di realizzarla. E questo interesse per il giusto è tanto peculiare, spiega Kojève, da caratterizzare di per sé la sfera autonoma del diritto, distinguendola da quelle dell’economica, della politica, dalla religione o dalla morale.
L’economia, infatti, si basa sul lavoro e sullo scambio; ma il lavoro oppone l’uomo alla natura, che non può chiedere giustizia di fronte a nessuno, e lo scambio corrisponde a delle leggi economiche che sono ben diverse da quelle giuridiche dalle quali è regolato. Quanto alla politica, lo scontro fra due veri nemici, cioè – insegna Carl Schmitt – fra due stati, non ha certo bisogno di un arbitro. Né la religione è un rapporto fra tre ma fra due sole parti, una delle quali è trascendente. Se poi la trascendenza viene meno e la religione diventa morale, non sarà certo un «terzo» il soggetto etico che si giudica interiormente in base ai propri valori.
È quindi il puro desiderio di giustizia a fondare e distinguere il diritto. Ma non basta. Poiché è il desiderio come tale la vera fonte della stessa idea di Giustizia. Per l’hegeliano Kojève si tratta in effetti del desiderio antropogenico, che muove la storia e fa pervenire il soggetto a sé attraverso la Lotta.
La teoria è la più nota: l’essere umano desidera il riconoscimento dei propri simili, ma questo suo «desiderio di desiderio» è solo ancora una potenzialità. E il passaggio all’atto significa qui lotta, o rischio estremo: solo lottando, ed esponendosi al pericolo mortale per puro prestigio, l’uomo si dimostra in effetti tale, cioè emancipato dal vincolo dell’autoconservazione o dalla condizione animale. E così viene realmente riconosciuto, come Signore, dal contendente che al suo cospetto trema e, rinunciando alla lotta, si sottopone al dominio dell’altro per realizzare la propria umanità nel lavoro.
Non sarà però il Signore del tutto figé nella sua posa padronale, ad apparire allo sguardo del dialettico come l’uomo propriamente detto, bensì il Servo, che trasformando il mondo con il lavoro trasformerà se stesso per farsi, in un rivolgimento ulteriore, libero Cittadino. Il vero nucleo teorico dei Lineamenti è perciò lo stesso delle lezioni parigine, cioè una ripresa della dialettica Servo-Padrone, che generando la storia umana universale genera le forme di interazione giuridica.
All’inizio, secondo Kojève, vi sarebbero infatti due diversi diritti: quello reale e attuale del Signore, cioè il diritto aristocratico dei pari, informato all’idea di Giustizia egualitaria, e quello del Servo, cioè il diritto in potenza (lo schiavo non detta legge) basato sul principio di equivalenza (gli schiavi non sono «uguali», hanno soltanto valori comparabili) ovvero sulla Giustizia dell’equità.
Come ogni potenza, anche il diritto servile però si attualizzerà, e per farlo dovrà mutare, cioè sintetizzarsi con quello aristocratico. Così con una ripresa della lotta, e nell’accettazione del rischio, il diritto del Servo, o diritto borghese, diventerà un giorno Diritto Cittadino. Quale sintesi armonica delle giustizie di equità e di equivalenza, dell’universalismo aristocratico e dell’individualismo della borghesia, sarà questo il vero, ultimo diritto, finalmente compiuto o affrancato da ogni divenire: il diritto vigente alla «fine della storia» in uno stato universale omogeneo e pacificato. Si capisce che una simile teoria, nella temperie 1943, dovesse chiamarsi provisoire, e tale restare, in un cassetto, per l’intera vita del suo autore. Suonerà perciò ironica e inquietante, nell’uso del tempo passato, l’ultima battuta rivolta a Lapouge: «A quell’epoca avevo letto Hegel, però non avevo capito ancora che la storia era finita».