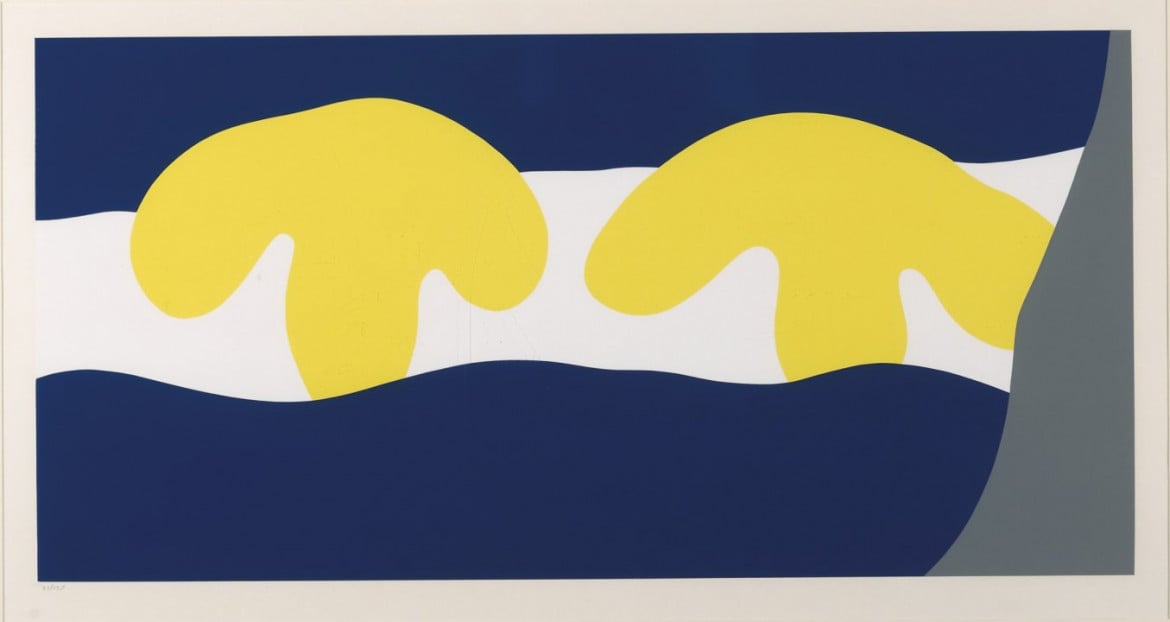In un testo da poco apparso in italiano (e tratto da una non meno recente raccolta di scritti inediti, pubblicata a Vienna nel 2018), Adolf Loos, fra i grandi padri del «discorso moderno», s’interroga su un tema d’inedita attualità per l’aria del tempo – il contributo, forse il brogliaccio d’una conferenza, data al 1923 – e cioè la diffusa tolleranza che, al termine dell’esperienza festiva e fuggevole coincidente con la Belle Époque, veniva ormai attribuita dalle società borghesi (ma soprattutto intellettuali) all’esposizione di ogni nudità.
La riflessione dell’architetto inanella una sapida sequenza di provocazioni, lasciando ampio spazio a un qual certo feticismo dello sguardo, dall’immagine dei piedi danzanti, liberi, d’estate sull’erba di un prato, a quella, altrettanto vacanziera, d’un turista americano colto, le gambe distese, a occupare coi talloni impolverati la seduta opposta alla propria nel vagone affollato di un treno, traboccante di turisti e pendolari schizzinosi.
Lo sforzo maggiore di Loos, nel tono conversevole dell’intervento, è però quello di tessere il mito di fondazione per un’abitudine a tal punto libertaria, rivendicando alla propria patria, il «mondo di ieri» di zweighiana memoria, la primazia indiscutibile rispetto a una tanto audace mancanza di pudore.
La signorina Else avrebbe intonato un controcanto, appena un anno dopo, col corpo scandaloso e assertivo della sua protagonista: ma è nella Vienna onirica della psicoanalisi agli albori che il testo rintraccia la nascita del primo bagno misto «su un’isola di sabbia del ramo morto del Danubio, il Gänsehäufel», quando costumi in tricot attillati, complici le tinte scolorite dall’acqua torbida, lasciavano trasparire curve indubbie agli occhi rapaci dei clienti meno educati.

Sarebbe poi arrivata la prima tournée austriaca di Isadora Duncan, ospite alla Secessione nel 1902 fra i rossori del vecchio ministro Whilelm von Hartel, a raffinare sensibilità sfrontatamente noncuranti: nel frattempo però il nudo s’era fatto metafora per la spessa evidenza di qualsivoglia volontarismo progettuale, in contrasto con le profondità sondabili di un inconscio corsivo, ridotto a banalità salottiera. Soggetto ideale per la sarcastica sprezzatura di Loos e per il suo sciovinismo da scavezzacollo cosmopolita.
Come che sia, in qualunque humus vada riconosciuta la terra natale di una nuova frigida attenzione per il corpo reso alla luce, tali appunti servono da introibo adeguato per la mostra al Mucem di Marsiglia – Paradis naturistes, a cura di Bernard Andrieu e Amélie Lavin, fino al 9 dicembre, catalogo Éditions de la Martinière – che intende seguire proprio gli echi del naturismo germanofono nel mondo francese degli anni venti e trenta, coi suoi esiti nelle culture libertarie della seconda metà del Novecento; ma se a colpire è innanzitutto la concordanza di date e luoghi rintracciabili in lettura sinottica, è pure il taglio critico dell’argomentare loosiano a servire da efficace pietra di paragone al percorso costruito nelle sale al pian terreno dell’istituzione.
L’architetto apre infatti la sua disamina – divagante, giocosa, legata tuttavia a presupposti e conclusioni – con uno stentoreo ipse dixit: «L’uomo sano tollera la nudità. Negli uomini e negli animali. L’uomo perverso non la tollera. L’uomo sano percepisce ogni abbigliamento come oggetto erotico».
Gli intenti paradossali di queste affermazioni aiutano in realtà a riconoscere uno dei fil rouge più resistenti seguiti nell’allestire gli spazi del Mucem: perché se certo i curatori hanno voluto segnalare la continua presa in conto dello sguardo esterno (pure nella declinazione di cieche censure), è soprattutto in una coriacea idea di «salute» che si rintraccia il comun denominatore dei case-studies significativi affrontati sia al museo, sia nel ricco catalogo.
Anche in questo senso i «modelli» vengono dal Nord, nell’elioterapia immaginata come soluzione necessaria per la stagionale mancanza di tepore che – lontani gli effetti del surriscaldamento globale – incantava, di brina e ghiacci, le regioni baltiche, da Rügen alla Svezia, o, progressivamente scendendo verso il Meridione, le domestiche correnti di fiumi o ruscelli alpini, fra Ascona e i boschi popolati dai partigiani della Lebensreform.
Tuttavia, nella Francia del primo dopoguerra e poi negli esiti della Terza Repubblica, trascorsa dall’«Unità nazionale» alle politiche sociali del Front Populaire, proposte sul tipo della Physiopolis comunitaria fondata dai fratelli Durville sull’île du Palatais, a pochi passi da Parigi, o dello Sparta Club aperto invece in pieno centro da Marcel Kienné de Mongeot (poi prontamente ripreso in provincia, fra Gaillon e le Yvelines) non si sarebbero risolti negli sbocchi settari, fra dottrine nazionaliste e fantasiose divagazioni sulla razza, destinati a inquinare la parabola del naturismo primo-novecentesco dalla Germania all’Austria.
Nutritisi dell’avanguardia coreutica d’inizio secolo – oltre alla Duncan, la rivoluzione della Ritmica col fiorire di palestre e compagnie, da Émile Jaques-Dalcroze a Jean d’Udine – questi circoli svilupparono al contrario una durevole utopia riformatrice, imponendo ai propri membri, assieme a nudità più o meno integrali, l’ambizione conseguente di un’esistenza intatta, fitta di abitudini probe e di integre intenzioni. Non a caso – la mostra lo mette ben in chiaro nel volume di commento al percorso – si moltiplicheranno negli anni progetti radicali come il Club du soleil di Carrières-sur-Seine, aperto per vocazione alle classi popolari, o i camping poveristici di Cap D’Agde, debitori di una certa leggenda scapigliata del litorale mediterraneo franco-spagnolo, dalla Costa Brava all’Escalet.
Tuttavia, è nella fede in una rappresentazione luminosa di sanità che, per l’appunto, sembra risiedere il dispositivo – certo ideologico, ma in fondo anche moralistico – destinato, nel tempo, a regolare simili esperienze, riflettendosi in un’iconografia che il comité curatoriale si è sforzato di ricostruire in modo critico, attraverso un’estensiva ricerca bibliografica e una divertente raccolta di ephemera.
Pur considerando il doppio registro della «cultura» naturista e del discorso pubblicitario rivolto a propagandare un determinato stile di vita (nel renderlo profittevole sul piano dell’investimento economico e del ritorno commerciale), è indubbio quanto l’immaginario esemplato in mostra trovi i propri limiti, più che in una certa normatività delle silhouettes e delle complessioni, proprio in un’univoca valorizzazione del benessere fisico, inteso soprattutto come specchio chiaro di una precisa condotta personale.
Tale principio – radicato nella mitologia antitecnologica di un certo umanitarismo millenaristico – ha il suo riflesso in icone stereotipate, in santini senza tempo come quello che accoglie il visitatore al Mucem, e cioè il Lichtgebet di Hugo Höppener (datato al 1894 ma che potrebbe tranquillamente provenire da una delle molte pubblicazioni naturiste di mezzo secolo dopo): ed è un peccato che una tale ‘igienizzazione’ del nudo, col suo portato di pruderie ‘capovolta’, non sia stata decostruita con più forza, magari ricorrendo a certe consuetudini legate alla storia della comunità LGBTQ+, solo brevemente evocate in catalogo.
A percorrere l’esposizione, non si può infatti non pensare ai mille fantasmes sepolti sotto a un’irenica profilassi del corpo nudo, col suo portato di desideri e di fantasie; e si avverte il bisogno di una storia orale che sveli la presenza del sesso nelle comunità naturiste, così caparbiamente respinto dal racconto ufficiale delle loro storie, dall’illustrazione dei loro progetti.