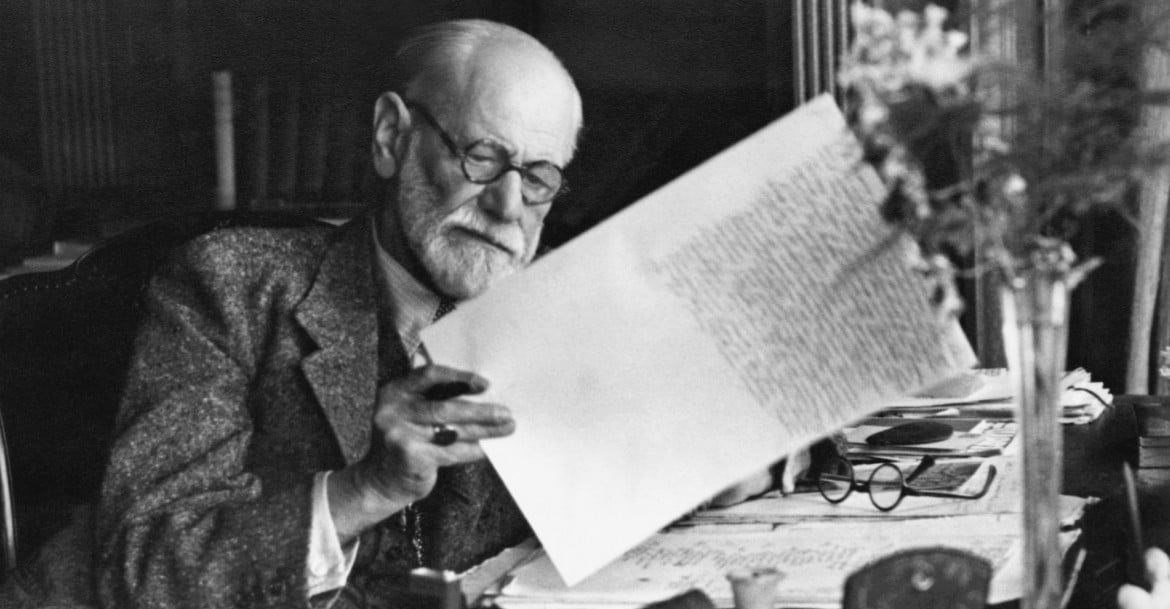A fine Ottocento, l’idea – ancora prospettata dal tardo Goethe – di alternare, con ritmica armonia, l’affermazione di sé a qualche istante di felice smarrimento nel mondo, non appare più nemmeno pensabile. Resta la scelta tra aspirazione al dominio e piacere dell’abbandono. Da un lato il tentativo di porsi al di sopra dei capricci del mondo, come fa il dandy che, osservava Baudelaire, «aspira all’impassibilità» e sembra anticipare quell’atteggiamento blasé che sarà poi, a inizio Novecento, il tratto distintivo dell’abitante della metropoli; dall’altro lato un’indiscriminata e quasi fanciullesca apertura, la capacità di disporsi a ogni sensazione, con l’inevitabile rischio del dilettantismo, quando non del perdersi in illimitate metamorfosi. È all’interno di questo moderno dilemma che si inscrive il dissidio tra Stefan George e Hugo von Hofmannsthal.
I due si erano conosciuti nel dicembre del 1891. Rientrato dalla Francia, dove per qualche tempo aveva frequentato la cerchia di Mallarmé, George si era messo alla ricerca di sodali e discepoli. Proprio perciò si era avvicinato a Hofmannsthal: gli sembrava «uno dei pochi in Europa, e l’unico in Austria che valesse la pena di conoscere», con l’obiettivo di «riunire coloro che avevano un’idea di cosa fosse la poesia». Così ricorderà, molto tempo dopo, Hofmannsthal, che all’epoca aveva appena diciassette anni: quella figura «inquietante e imperiosa», che si muoveva estranea e solitaria per i caffè viennesi, lo aveva profondamente colpito, tanto da spingerlo a tradurre le prime impressioni in forme poetiche, in versi dedicati a colui che aveva «svelato cose segrete», toccando come un vento le «corde dell’anima».
A questa prima positiva accoglienza George, che pure verrà ricondotto da Lukács alla «leggenda dell’impassibilità», reagì con toni a lui insoliti, celebrando con enfasi quella nuova conoscenza: «finalmente! Come? Davvero? Una speranza, un presagio, un guizzo, una vertigine… Oh, gemello mio!». E anche se Hofmannsthal rispose tiepidamente a tanto entusiasmo, George non si perse d’animo, e cominciò un corteggiamento insistente e un po’ maldestro: andava a prenderlo a scuola, gli faceva la posta nel caffè, e sempre più irritato dal suo carattere elusivo, arrivò a presentarsi più volte a casa sua, nel tentativo di stanarlo. Nel frattempo, Hofmannsthal registrava, in un appunto, il suo sentimento di «crescente paura» e il bisogno di «spregiare» tutta quell’insistenza. A una sua lettera – andata poi distrutta ma evidentemente meno diplomatica delle altre – George reagì infine minacciando un duello. Solo l’intervento del padre di Hofmannsthal riuscì ad appianare il conflitto.
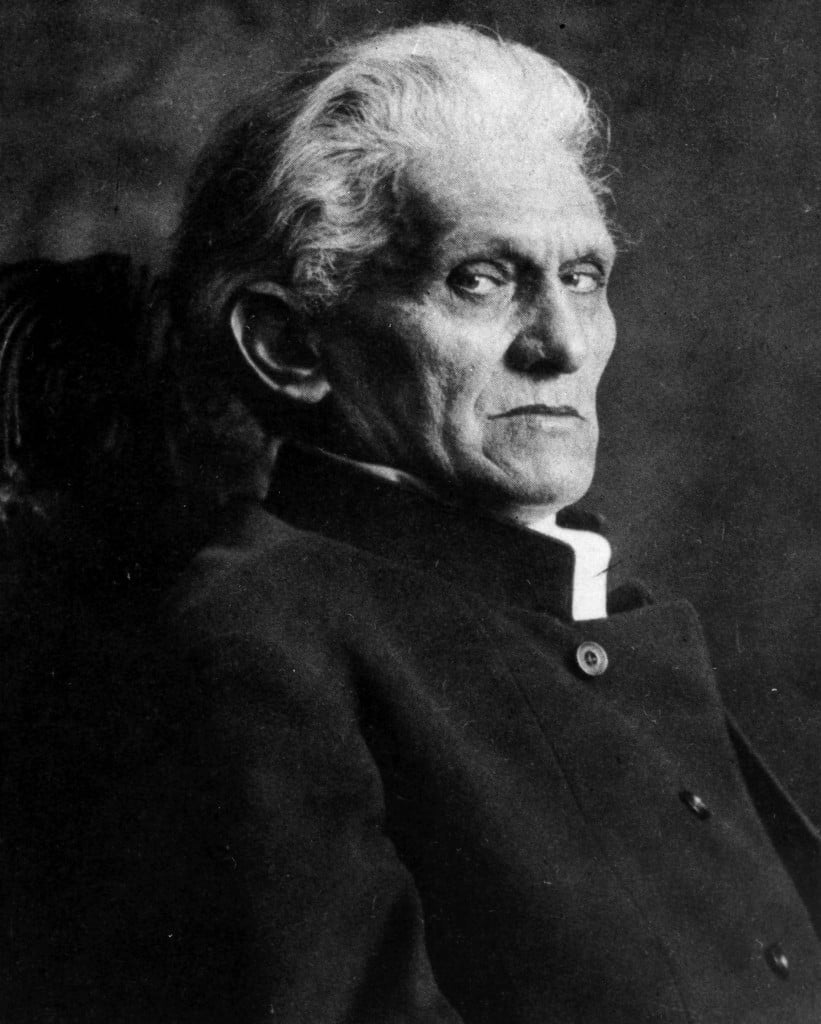
Il carteggio che si sviluppa a partire da quel burrascoso incontro può deludere, come osserva Adorno, per la «povertà di contenuto teorico». Date le premesse, è tuttavia già notevole che tra i due sia rimasto in piedi un rapporto per ben quattordici anni. E dietro alle tensioni e ai malintesi documentati dall’epistolario, nel contrasto tra i due si mostra un’antitesi poetica e umana di rado osservabile con tanto paradigmatico nitore. Le frequenti profferte di George, sempre pronte a capovolgersi in risentimenti e rimproveri, sono solo uno dei molti modi in cui si manifesta la sua aspirazione a esercitare la propria sovranità sul mondo, anche a costo di creare un mondo d’artificio. Lo rivelano tra l’altro i suoi tentativi di poetare in una lingua d’invenzione, da George stesso rievocati come un tentativo di diventare «sovrano del tutto», grazie a un «canto che nessuno poteva afferrare».
La mutevolezza di Hofmannsthal è al contrario sintomo di una sensibilità ricettiva che non può ignorare nulla di ciò che avviene all’esterno, e per esempio non può distogliere «dall’anima impaurita» neppure «gli astri che precipitano in remote lontananze», anche perché forse solo questa incondizionata apertura al mondo può dare legittimazione al poeta e sollevarlo dal sospetto di un autarchico solipsismo.
Due atteggiamenti tanto diversi non potevano non tradursi in due stili poetici opposti: dal lato di George, strutture fortemente marcate, in cui la sintassi asseconda la scansione dei versi e delle strofe, permettendo di isolare frasi e sintagmi di ieratica staticità; da quello di Hofmannsthal, un flusso di versi e parole in cui a volte è arbitrario perfino fissare un principio o una fine, come suggerisce una delle sue poesie più celebri, la Ballata della vita esteriore, che in modo programmatico all’inizio del primo verso esibisce la congiunzione «und» (Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen… E crescono bambini dai profondi occhi/ che nulla sanno, crescono e muoiono,/ e tutti gli uomini percorrono la loro via).

Nonostante le divergenze poetiche e le incomprensioni private, l’idea di un duello – pur concretamente evocata da George in quelle prime febbrili giornate – non si realizzò nemmeno in una dimensione puramente letteraria. Anche dopo la definitiva rottura, gli accenti più apertamente polemici furono demandati a qualche collaboratore. Nel cenacolo di George – organizzato secondo precise gerarchie e anche per questo tanto inviso a Hofmannsthal, che in una lettera lo definisce un circolo «esoterico» non privo di «tratti meschini e pregevoli» – spicca la voce di Friedrich Gundolf, che in spregio alla settecentesca levità del Cavaliere della rosa scrive contro le «commedie in dialetto» di Hofmannsthal, ritenendolo capace «di trasformarsi in ogni cosa», senza però «essere nulla in modo definitivo»; al contrario di George, la cui opera gli appare motivata da una «imperiosa necessità», dice che essa giunge «dalle più profonde urgenze dell’anima».
Sul fronte opposto, assai più frammentato e privo di qualsiasi organizzazione, è soprattutto Rudolf Borchardt a impegnarsi in qualche scaramuccia polemica, là dove declassa la poesia di George a «fenomeno di passaggio» entro la storia della letteratura tedesca e celebra invece quella dimensione teatrale che avrebbe educato Hofmannsthal a una «più universale umanità», allontanandolo così dalle bizzarrie tipiche della cerchia di George.
Nei toni usati invece dai due protagonisti si riverberano ancora una volta le loro radicali differenze: George affida un giudizio inappellabile ai versi di una poesia intitolata Il rinnegato, dove, pur riconoscendo a Hofmannsthal la capacità di trovare «rari e preziosi colori», condanna la curiosità che lo avrebbe portato ad abbandonare il tempio dell’arte per mettersi a origliare le voci «sulla via e al mercato», denunciando le conseguenze di una troppo agile empatia: «desideroso d’insinuarti in tutte le anime / lasciasti la tua incolta e desolata la tua». In Hofmannsthal, che ancora a distanza di anni modella su George il personaggio di Sacramozo nel romanzo Andrea, risuona invece una qualche titubanza là dove – in una lettera del 1919 – dopo essersi chiesto se George non possegga un’individualità poetica «più forte» della sua, si risponde così: «Non lo so. Ci sono troppe cose artificiose in lui e troppe sono invece escluse». E anche nelle differenze con cui i due autori descrivono il proprio conflitto con l’altro si legge la difficoltà di armonizzare il proprio Io con il mondo esterno: sembra che ancora prima di incontrare Stefan George, Hofmannsthal avesse a cuore il problema. Immaginò dunque due contrapposte figure accomunate dall’impossibilità di crescere e venire davvero a contatto con il mondo: l’una avvolta da una rigida corazza così da respingere ogni attacco, l’altra capace di assumere ogni forma così da neutralizzare ogni assalto. In queste immaginarie creature gli apparvero racchiuse le uniche due vie ancora percorribili, divergenti e disarmoniche: «l’uomo che respinge ogni cosa», o «l’uomo che raccoglie ogni cosa, senza davvero prendere nulla».