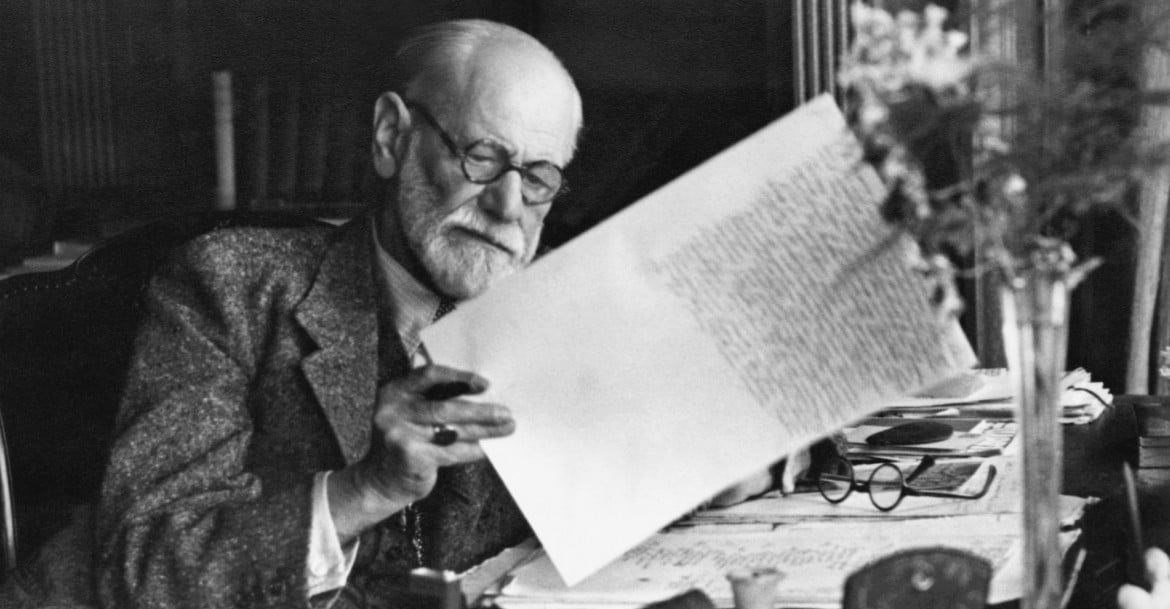Forse la penna più graffiante e istrionica della Grande Vienna fin de siècle, Karl Kraus fu avventore del Café Griensteidl, quartier generale della «gioiosa apocalisse», e insieme vertice logistico della décadence viennese dove si radunava quella composita pleiade letteraria che, senza una fisionomia precisa, passa sotto il nome di Jung-Wien (Giovane Vienna): Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hofmann, Felix Salten, il teorico Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, i nomi di maggior risalto, più altri dimenticati. Mai vero cenacolo letterario con una poetica unitaria, questi scrittori erano uniti da armonia spontanea di intenzioni, tutte contrarie al realismo, che nella Giovane Vienna convissero esibendo un Io sfrangiato in pulviscoli di relazioni psichiche, insieme alla fuga lineare delle impressioni, il riverbero dell’attimo vissuto, una raffinata malinconia presaga di morte. Enfant terrible della scena letteraria viennese, Kraus aveva iniziato molto presto a scrivere articoli e feuilleton con lo pseudonimo «Crêpe de Chine». Non si può dire con precisione quando, per la prima volta, abbia messo piede nel caffè letterario affacciato sul Michaelerplatz, forse già a ottobre del 1891, da studente di liceo.
Simpatie naturaliste
Nello stesso mese dello stesso anno, il trentenne Schnitzler, tra gli Jung Wiener il più vecchio, in una nota di diario dà per costituito il gruppo dei giovani viennesi includendo nel novero Hofmannsthal, Beer-Hofmann e Salten, oltre a se stesso. Non certo Kraus che, appena fiutata l’aria del caffè letterario e della new wave che vi circolava, si era posizionato subito fuori dal coro. Complice la prima dell’Intrusa di Maurice Maeterlinck, sui palcoscenici viennesi a maggio del 1892, Hermann Bahr dichiara, a gran voce, oltrepassato il naturalismo; e fa di questo superamento la pietra angolare del nuovo clima, elevando il simbolismo a «segreta arte dei nervi». Al contrario, la simpatia di Kraus va tutta a «quel movimento moderno che viene da nord», ai suoi occhi incarnato al meglio nel fresco e robusto naturalismo di Gerhart Hauptmann e in quei «poeti del fango» – o «dello sterco», la parola tedesca è la stessa – che del teatro di Hauptmann costituiscono il pendant lirico e dei quali organizza una lettura pubblica a Vienna nell’ottobre dello stesso anno.
Pur senza abdicare alla propria missione naturalistica e alla ferrea equivalenza di scrittura e satira, almeno nei primi anni Novanta dell’Ottocento Kraus sgomita per entrare nella cerchia dei giovani viennesi; ma, una volta lì, non perde occasione per spargere veleno, rimproverando all’accolita il sofisticato estetismo, l’atteggiamento studiato di chi civetta con la morte, il languido e sfinito struggimento, la svenevole affettazione, la posa da dandy consumati e da viveur che divorano l’esistenza con concitata bulimia. Soprattutto in Hermann Bahr, Kraus, che ha da poco passato l’esame di maturità, vede la sentina di tutte le civetterie e il ricettacolo della fama effimera, strombazzata sui giornali ma lontana anni luce dall’autentica ispirazione: «il maestro di tutti i modernismi», grande stilista del decadentismo viennese, mandarino della nuova maniera è per lui solo un anonimo «signore di Linz», un poseur dalla fama oscura che spertica lodi e fa rullare i tamburi solo quando gli torna il conto.
Neppure Schnitzler è nelle sue corde: guarda con benevolenza ad Anatol – famoso ciclo drammatico in sette episodi che dà il là al fin de siècle austriaco – definendo l’autore «uno dei talenti più significativi della Giovane Austria», ma poi non manca di metterne in evidenza la nevrotica e smorfiosa modernità da caffè in cui, a suo dire, tutte le scene si impigliano tranne una.
Schnitzler lo ricambia con la moneta della degnazione e, quando Kraus si fa beffe del timbro morboso e masturbatorio di Neurotica, scandalosa raccolta à la Baudelaire del sodale Felix Dörmann, Schnitzler gli gira le spalle con risentita freddezza al suo ingresso al Griensteidl, in una sbandierata indifferenza che spinge «il piccolo Kraus» a giustificarsi per lettera mostrando chiaro il proprio risentimento: «Odiavo e odio questa décadence falsa e menzognera che civetta perennemente con sé stessa».
Anche dalle colonne della «Fackel» – vera enciclopedia critica della vita pubblica in Europa dove, per novecentonovantadue numeri, personaggi grandi e piccoli finiscono spalle al muro – Kraus non risparmia stoccate a Schnitzler che, pur non dividendo la totale disistima toccata in sorte a Bahr non meno che a Stefan Zweig e a Hofmannsthal, figura come grande ras nel fortilizio dell’establishment letterario, a proprio agio nel giostrare temi e personaggi intorno allo spirito del tempo e al gusto insulso del pubblico: sotto la sferza di Kraus, apocalittico moralista che mal sopporta lo scandalo fine a sé, finisce il famoso Girotondo, ridda amorosa in dieci quadri con dialoghi occasionali culminanti in un amplesso lasciato all’immaginazione, forse l’opera più scabrosa di Schnitzler, che dopo la première viennese del 1921 è subito bollata come «pièce da bordello» e porta l’autore difilato a processo per pornografia.

Schnitzler ha sbagliato, sostiene Kraus, a solleticare gli appetiti del pubblico, rincorrendo uno spettatore voyeur intento a «fermare con tutte e due le mani il sipario di un teatro parigino che si va chiudendo su uno spogliarello».
Anche Felix Salten – più noto per Bambi che per il resto della sua scrittura, organico allo Jung-Wien anche se meno sinestesico e intimista, sicuramente meno assorto nell’auscultazione delle proprie oscillazioni interiori – non sfugge alla morsura di Kraus. Dapprima confidente, anche per le comuni origini, più umili rispetto ai blasonati giovanotti del Griensteidl, e compagno di scalata nei tentativi di mettere piede nel sancta sanctorum della cultura viennese, Salten diventa, complice una mormorazione di cui Kraus viene per vie traverse a conoscenza, l’arcinemico. Ufficialmente nel mirino dal 1896 (ma in privato anche da prima) a partire dal 1899, la denigrazione nei suoi confronti diventa – sulle colonne della «Fackel» – uno stillicidio, spiccando sentenze inappellabili.
Vezzi, gesti, orpelli: il ridicolo
Diversamente da Hofmannsthal, olimpico e serenamente noncurante, Salten non incassa e, già nel dicembre 1896, esacerbato dal pubblico discredito, prende a schiaffi Kraus al Griensteidl, dopo che questi aveva reso pubblica la sua liaison con Ottilie Metzl, attrice del Burgtheater che sarebbe poi divenuta sua moglie. Il fatto, che provoca il plauso aperto di Schnitzler, riempie le pagine dei giornali e causa a Salten il pagamento di un’ammenda. Attraverso le trentasette annate della «Fackel», Kraus non smette di registrare, con il fosforo della satira, i fatti di cui Salten è protagonista, dalla bancarotta del cabaret Zum lieben Augustin alle sgrammaticature affioranti nelle sue pagine al successo di Bambi, dai suoi legami con la Casa d’Austria alla vicinanza al sionismo, dal suo comportamento plaudente durante la Grande Guerra ai suoi faraonici viaggi.
Ma è nel 1897 che «il bianco arciprete della verità», secondo la felice definizione di Georg Trakl, tocca il culmine della stroncatura nel famoso saggio La letteratura demolita, a salutare la chiusura del Griensteidl, sventrato per far posto ad appartamenti, vera e propria tromba che annuncia la fine di un’epoca: in questo pamphlet, che nel giro di pochissimo tempo conosce cinque ristampe, Kraus è più sardonico e sulfureo che mai, e si produce in un gioco al massacro, senza mai chiamare per nome le sue vittime che, tuttavia, lo smaliziato pubblico dell’epoca riconosce una a una, mettendone in ridicolo manie, vezzi, gesti, orpelli, pettinature, nervi scoperti e discorsi doppi, nell’anticamera di una fine secolo ormai suona ta, dove «la vita spezzerà le grucce dell’affettazione».