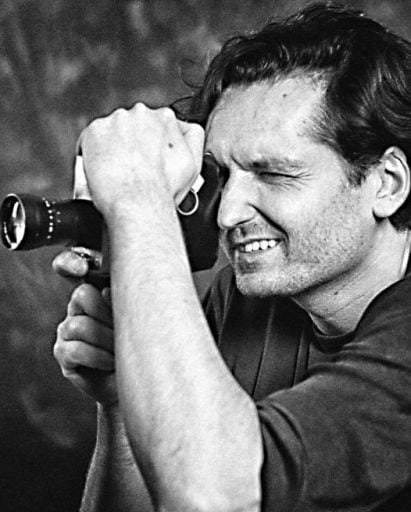
Essere o non essere? Partire o restare? Vivere o morire? Sono questi i dilemmi che affrontano i giovani protagonisti ucraini di Hamlet Syndrome, il film di Elwira Niewiera e Piotr Rosołowski proiettato al Trieste Film Festival conclusosi ieri. È uno spaccato sulla società ucraina appena prima dell’invasione russa, è infatti tra il 2020 e il 2021 che i registi hanno organizzato e filmato la realizzazione di uno spettacolo teatrale con lo scopo di fare i conti con le ferite lasciate dal conflitto in Donbass, ma anche per mostrare la complessità di un Paese che sta in parte mutando e costruendo una nuova identità. Un processo che prende la forma anche dello scontro tra i diversi partecipanti – c’è chi viene dall’ovest dell’Ucraina e chi dall’est, chi è stato al fronte e chi vive sulla propria pelle la discriminazione omofoba – in particolare sul valore da attribuire alla bandiera e alla patria. «La figura di Amleto – spiega Rosołowski – era per noi un filtro, volevamo far confrontare i giovani ucraini con il suo dilemma. Ma abbiamo anche pensato che Shakespeare potesse aiutarci a dialogare con i paesi occidentali, perché spesso sulle questioni che riguardano l’Est Europa manca la conoscenza del contesto che rende possibile la comprensione. Allora Amleto poteva diventare un ponte». Ed è proprio tra la distanza e la vicinanza che si gioca il senso del film, perché all’intervallo temporale degli eventi in Donbass, risalenti al 2014, si sovrappone la lontananza geografica e di sguardo: i due registi sono infatti polacchi. Abbiamo raggiunto Rosołowski al telefono mentre si trovava a Trieste.
Come avete avuto l’idea di affrontare le ferite della guerra attraverso uno spettacolo?
Elwira ha studiato teatro e aveva dei contatti con la regista teatrale ucraina Roza Sarkisian, che abbiamo coinvolto. Ci interessavano le giovani generazioni che hanno perso parte agli eventi di Piazza Maidan e poi alla guerra nel Donbass, si è trattato per molti di un momento di risveglio: diciottenni o ventenni che improvvisamente si interessano alla politica e iniziano a essere attivi, pagandolo anche a caro prezzo. È la prima generazione nata dopo il crollo dell’Unione sovietica ed è piuttosto diversa da quella dei genitori, assomigliano ai loro coetanei europei ma vivono tutt’altra situazione. Sapevamo che realizzare un film su eventi avvenuti a distanza di alcuni anni non sarebbe stato semplice e per questo abbiamo pensato di realizzare uno spettacolo teatrale, una sorta di psicodramma con cui incoraggiare i partecipanti ad intraprendere un viaggio nei loro ricordi.
Voi venite dalla Polonia, siete vicini all’Ucraina ma non direttamente coinvolti. Che tipo di sensazioni avete rispetto a ciò che accade lì?
Tipicamente i polacchi si identificano facilmente con i movimenti pro-Ucraina perché ci sono molte similitudini con quello che accadeva da noi durante il regime sovietico o dopo. Siamo anche piuttosto vicini da un punto di vista linguistico e culturale. Il lavoro mio e di Elwira prende sempre ispirazione dall’Est Europa, siamo affascinati dalla complessità di questa regione e sentivamo che dovevamo rivolgerci all’Ucraina perché lì stava accadendo qualcosa di importante. La parte più difficile per la realizzazione di Hamlet Syndrome è stata trovare le giuste persone che partecipassero al progetto, ne abbiamo incontrate tante, provenienti da diverse aree e con punti di vista molto diversi. Attraverso questa ricerca abbiamo capito meglio ciò che accadeva in Ucraina. È qualcosa che credo succeda spesso ai documentaristi: si parte con un’immagine in cui la scala di grigi è limitata, ma una volta che si è sul territorio tutto cambia.
Avete affrontato una doppia sfida: la realizzazione dello spettacolo e quella del film.
Abbiamo impiegato molto tempo per costruire una relazione con i partecipanti ma la cosa più importante è che loro avevano un forte bisogno di raccontare le loro storie, e forse proprio perché la società era già satura di discorsi sulla guerra e su Maidan, ancora di più sentivano l’urgenza di urlare ciò che era loro accaduto. La telecamera sembra a volte quasi invisibile, il processo era così intenso che si sono dimenticati quasi subito della nostra presenza. Abbiamo provato a non interferire nella costruzione dello spettacolo, lo abbiamo innescato ma poi abbiamo preferito fare un passo indietro e osservare ciò che accadeva nella ricostruzione di questi eventi traumatici.
Il vostro film ha acquisito un nuovo significato dopo l’invasione russa del febbraio scorso. Come avete reagito?
È stato un shock e rispetto al film non sapevamo più se fosse rilevante. Abbiamo pensato di ricontattare i protagonisti per girare nuove scene ma abbiamo capito subito che sarebbe stato impossibile perché alcuni di loro erano tornati al fronte mentre altri erano fuggiti. Credo che il significato del film sia diventato quello di testimoniare la situazione precedente all’invasione ma soprattutto l’entità del trauma che milioni di ucraini vivranno per molti anni.





