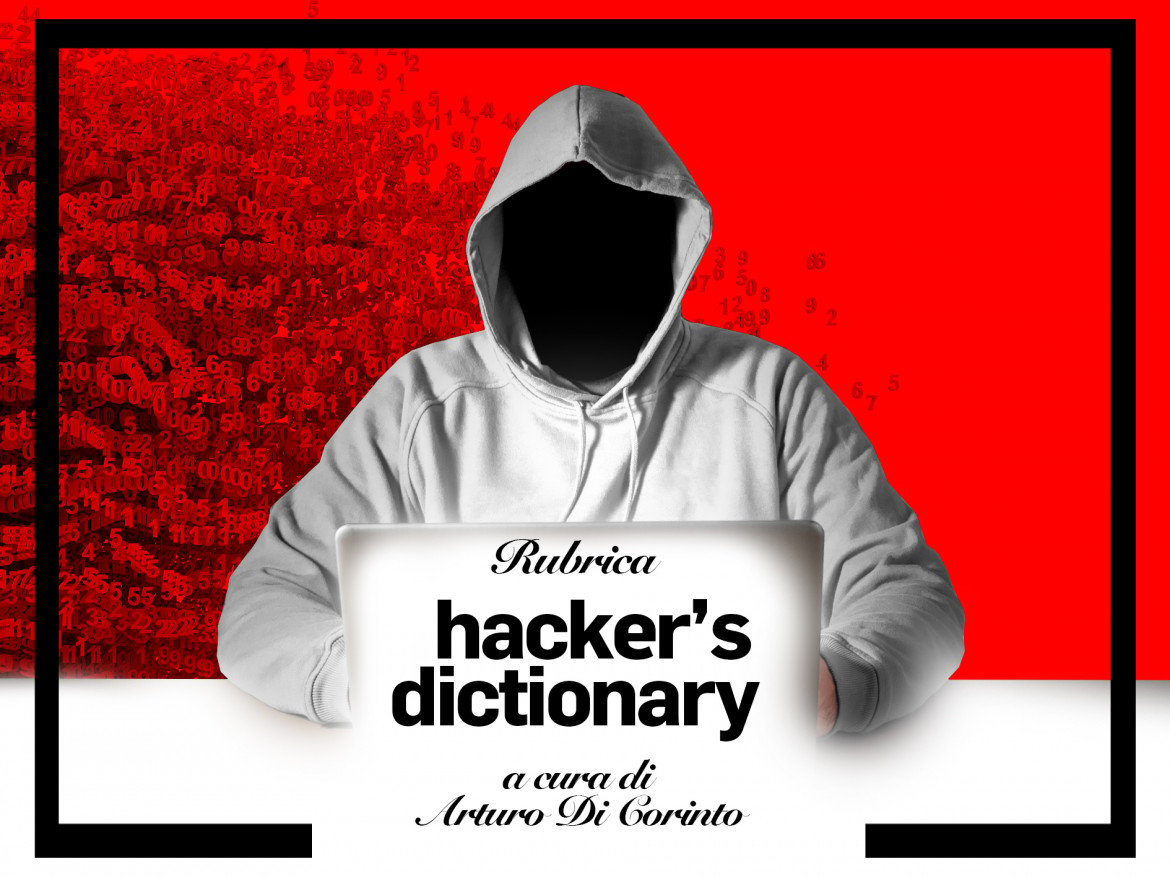Se il sito dell’Inps non funziona, è colpa degli hacker. Se quello dell’Agenzia delle Entrate non regge il flusso di contatti, è colpa degli hacker. Se l’udienza su Zoom viene interrotta, è colpa degli hacker. Se il sito noipartigiani.it va offline è colpa degli hacker. Ma anche no.
In molti casi l’«hacker» è una figura mitica ripescata nell’immaginario di chi ha fretta di dare una spiegazione seguita da roboante denuncia ma avara di dettagli tecnici, a errori che non si vogliono ammettere. Oppure è l’escamotage di chi pensa che i giornali, valutata la plausibilità della notizia e la credibilità della fonte, non indagheranno, creandogli un alibi.
La colpa è anzitutto di noi giornalisti (del caposervizio) che spesso sul web titilliamo il lettore con titoli sensazionalistici senza spiegarli.
Hacker vuol dire boscaiolo, giornalista da strapazzo, virtuoso del software, e in genere la parola è usata in quest’ultima veste. Ma quando sessant’anni fa si impose nei campus americani voleva solo indicare chi era bravo a trovare scorciatoie per fare le cose.
Fino ad allora aveva indicato i burloni delle «fraternity». In seguito fu usata per chi era capace di risolvere un problema informatico in maniera rozza ma efficiente, con un hack. «Hacking» vuole dire infatti tagliare, spezzare, sminuzzare, aprirsi un varco, con l’accetta, appunto.
Il termine «hacker» divenne l’equivalente di criminale informatico solo dopo, per indicare chi era capace di piegare strumenti tecnologici ad usi impensati o non consentiti dai contratti di licenza del copyright delle corporation. E questo accadde in un momento preciso: quando le interfacce dei computer facilitarono la «user experience» degli utenti al punto da non obbligarli a programmare per ottenere lo scopo desiderato.
Di conseguenza, chiunque fosse stato capace di scrivere software sarebbe diventato un «hacker», possessore di conoscenze esoteriche, associate a magia e segretezza. Il programmatore, l’«hacker», diventava l’uomo nero che «manomette» il software.
Gli «hacker» però erano quelli che al contrario il software lo scrivevano e ne risolvevano i malfunzionamenti. L’«hacker» è sempre stato un virtuoso della programmazione, con un’etica precisa, quella della condivisione del sapere.
In una società basata su software, dati e algoritmi, non c’è più bisogno di ricorrere agli hacker per spiegare quello che non capiamo.
Gli hacker criminali esistono al pari dei burocrati corrotti, però essere un hacker è una condizione necessaria ma non sufficiente a danneggiare reti, server e computer.
Oggi se un sito viene messo offline da un attacco informatico di tipo DoS – richieste simultanee di accesso, eccessive per un sito web che non riuscendo a soddisfarle collassa e si autospegne -, non c’è bisogno di dare la colpa agli «hacker».
Purtroppo anche su Instagram agiscono i boaters, giovanotti che affittano reti di computer infetti a chiunque voglia abbattere il sito della scuola per un’ora o più. Si parte da poche decine di euro fino a cifre a tre zeri per i target meglio difesi.
Non serve tirare in ballo gli hacker per denunciare l’irruzione di fascisti in una videochat senza password della presentazione di un libro. E non c’è bisogno di dare la colpa a loro se è stato configurato male un sito che collassa sotto il peso del suo improvviso successo. Nel caso del presunto DoS a noipartigiani.it, domenica scorsa, bisognerà aspettare per capire se è stato bersagliato da un’azione fascista che il servizio CloudFlare non è riuscito a bloccare o se invece è stato attaccato solo perché considerato una preda facile da teppisti del web.
In ogni caso, non chiamateli «hacker». Viva i Partigiani! E Buon 25 Aprile.