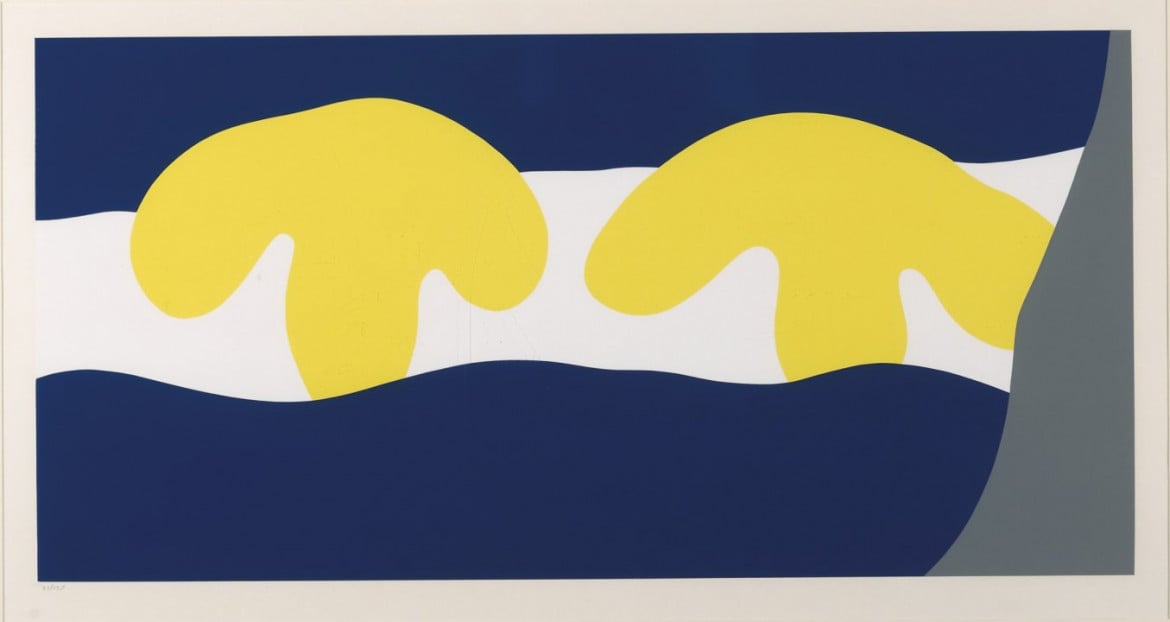Controverso protagonista del dibattito intellettuale e politico francese, dopo aver proposto, a partire da La France périphérique (Flammarion, 2015), la sua lettura della nuova geografia sociale dell’Occidente globalizzato, il sociologo Christophe Guilluy traccia in La società non esiste (Luiss University Press, pp. 184, euro 20, traduzione di Riccardo Antoniucci) genesi ed effetti di quella che presenta come «la fine della classe media occidentale». Per Guilluy, l’attuale ondata populista rappresenta in questo senso solo la punta dell’iceberg di un risentimento diffuso presso la ex classe lavoratrice, privata di ruolo e «status» e marginalizzata perfino sul piano geografico lontano dai centri delle metropoli globali.
Il populismo di destra si nutre dell’idea che l’Europa sia avviata verso un «declino» inevitabile. Ma se costoro descrivono il tramonto «identitario» del continente, lei traccia invece una radiografia sociale della crisi, parlando di «fine della classe media occidentale». Che cosa è accaduto?
Non credo nell’idea del declino. L’Europa rimane il continente più ricco del pianeta. La domanda da porsi è però un’altra e riguarda il fatto che oggi siamo di fronte ad un modello economico che non integra più le categorie modeste che formavano un tempo la base della classe media occidentale. Si tratta di lavoratori, impiegati, contadini, piccoli imprenditori che rappresentano ancora la maggioranza ma non hanno trovato il loro posto all’interno del modello neoliberista. Senza scivolare necessariamente nella povertà, queste categorie si sono indebolite socialmente e ritengono perciò che il modello economico proposto dalle classi dominanti non sia stato vantaggioso.
Perché questo declassamento si è spesso tradotto in un sentimento di rancore traducibile nello scontro tra «il basso» e «l’alto», piuttosto che nelle forme tradizionali del conflitto sociale?
Se la globalizzazione – e il suo corollario nella divisione internazionale del lavoro – ha permesso l’emergere di una classe media cinese o indiana, ha allo stesso tempo distrutto i posti di lavoro industriali delle classi lavoratrici occidentali. Ovunque in Occidente, i lavori delle classi popolari sono scomparsi o diventano precari. Allo stesso tempo, il mercato del lavoro si è polarizzato e ora è diviso tra lavori altamente qualificati e ben retribuiti e lavori precari, i «bullshit job» che imprigionano le classi popolari in una forma di instabilità permanente. Per questo parlo di un lento processo di «abbandono della classe media», iniziato con gli operai, quindi i contadini e oggi con gli impiegati e gli autonomi che sono anch’essi sempre più precari. Questa situazione spiega il ritorno di un conflitto sociale tra le classi lavoratrici occidentali precarie e le altre, quelle superiori integrate.
Il suo libro si apre con una citazione di Thatcher che nel 1987 affermava «la società non esiste». Trent’anni dopo il debutto delle politiche neoliberiste incarnate proprio dalla Lady di ferro e da Reagan, quel sinistro auspicio si è tradotto in realtà?
Il «there is no society» di Thatcher illustrava un processo globale che tendeva a ridurre lo stato sociale e i servizi pubblici. L’idea che le classi popolari non dovrebbero aspettarsi nulla dallo Stato è stata poi accompagnata da un’altra svolta fondamentale, quella «secessione delle élite» che Christopher Lash aveva individuato già negli anni Ottanta. La secessione non riguarda solo l’élite, ma l’insieme delle classi superiori, quelle che beneficiano del modello economico che si è andato imponendo e che si concentra nelle grandi metropoli globalizzate.
«La società non esiste» rappresenta il punto d’arrivo della ricerca iniziata con «La France périphérique», dove descrive l’esodo delle classi popolari verso aree sempre più marginali quanto a servizi, lavoro, opportunità. Un fenomeno in atto in tutto l’Occidente? E in che rapporto con l’esclusione sociale delle periferie?
In Francia, negli Usa come in Gran Bretagna, la creazione di posti di lavoro e di ricchezza è, in media, concentrata nelle metropoli globalizzate. Sempre più ricche e gentrificate, sono diventate le nuove cittadelle medievali del XXI secolo. Per la prima volta nella storia, la maggior parte delle classi lavoratrici non vive più dove si crea lavoro, ma in centri minori, città di medie dimensioni deindustrializzate o nelle aree rurali, là dove l’occupazione è sempre più rara e dove si assiste a un «ritiro» dei servizi pubblici. Il contesto delle periferie, ad iniziare dalle banlieue francesi, è diverso. Questi territori poveri si trovano oggi all’interno di metropoli sempre più ricche e illustrano perfettamente il funzionamento della città globalizzata dove le disuguaglianze sono in costante aumento. Infatti raccolgono una forza lavoro destinata agli impieghi scarsamente qualificati e mal retribuiti di cui la borghesia delle metropoli ha bisogno (in particolare nel settore dell’edilizia, dei servizi alla persona, della ristorazione). Si tratta di un modello potenzialmente esplosivo poiché in queste zone la divisione sociale cela anche una separazione etnica.
Qual è il rapporto tra la crisi del mondo del lavoro prima, del ceto medio poi e l’ascesa del populismo di destra? Si può tracciare una sorta di geografia sociale del fenomeno?
In tutti i paesi sviluppati, il populismo esprime la medesima sociologia (le classi popolari) e la stessa geografia (aree rurali, centri minori, piccole città deindustrializzate). L’America periferica ha eletto Trump e quella del Regno Unito ha deciso a favore della Brexit. E pur se i contesti sociali ed economici nazionali sono diversi, le dinamiche in atto sono più o meno le stesse. Nel Nord-Pas de Calais, ex roccaforte della sinistra, le classi lavoratrici e in particolare gli operai e le popolazioni rurali ora votano per il Rassemblement National di Marine Le Pen.

In tale contesto sociale, in Francia è emerso il movimento dei «gilets jaunes». A suo giudizio cosa rappresenta e che peso potrà avere nell’esito del voto europeo nel suo paese?
Credo che questo movimento rappresenti l’incarnazione concreta del concetto di «Francia periferica». La mappa dei ronds-point di novembre, da cui tutto è cominciato, corrisponde esattamente alla geografia di quella Francia popolare e dispersa nella quale ritroviamo tutte le categorie sociali più vulnerabili e rese fragili dall’attuale modello economico: operai come impiegati, rurali e urbani, giovani e pensionati. Da questo punto di vista i gilets jaunes sono un segnale positivo di una ricomposizione di classe comunque in atto. Anche se è importante notare che questo movimento non è né di destra né di sinistra, ma rappresenta la classe operaia del XXI secolo che, in maggioranza, non sembra credere più al dualismo destra/sinistra. Al di là della questione del populismo, stiamo assistendo all’uscita dalla «società liquida» dal basso, da parte delle classi popolari.
Lei parla della crescita della «paranoia identitaria» che accompagna lo sviluppo del multiculturalismo. A suo giudizio, i ceti dominanti promuoverebbero l’apertura verso i migranti perché sanno di poter mantenere inalterate le «frontiere invisibili» – sociali come urbane – con gli «stranieri», su cui non possono contare invece i ceti popolari. Quali perciò gli anticorpi al razzismo?
Ritengo che le classi dominanti e la nuova borghesia sfruttino e strumentalizzino gli immigrati. Per questo parlo dell’ipocrisia della «borghesia cool» che sostiene i temi della «società aperta» ma vive in realtà nelle sue cittadelle ben separate, non nei quartieri dove si concentra l’immigrazione. Bisogna infatti chiarire una cosa: la quota di razzisti è esattamente la stessa negli ambienti popolari come tra i borghesi. Se le categorie superiori e istruite non scivolano verso il populismo, è solo perché hanno i mezzi per erigere il loro «confine invisibile». Perciò interrogarsi davvero su questo tema è un prerequisito per ridurre le tensioni. Nei miei lavori, ho introdotto la nozione di «insicurezza culturale» per dimostrare che, soprattutto in un ambiente popolare, non è tanto la relazione con l’«altro» che pone un problema quanto l’instabilità demografica che induce la paura di diventare minoranza e di perdere un capitale sociale e culturale cui si dà molta importanza. Una paura che colpisce tutti i ceti popolari, indipendentemente dalle loro origini.
Nelle conclusioni del libro lei spiega come«la sfida non sia più «gestire il regresso sociale, ma rifare daccapo la società»…
Credo sia l’unica soluzione possibile. Però non possiamo «fare la società» senza integrare le classi popolari che rappresentano la maggioranza della popolazione. La protesta popolare non si fermerà, i gilets jaunes come i sostenitori della Brexit continueranno a esistere per i prossimi cento anni se niente cambia. Per questo motivo, le classi dominanti – come i partiti politici – devono rivedere i loro programmi. È necessario rispondere alle nuove esigenze sociali e culturali, tenendo conto che il popolo non scomparirà mai.