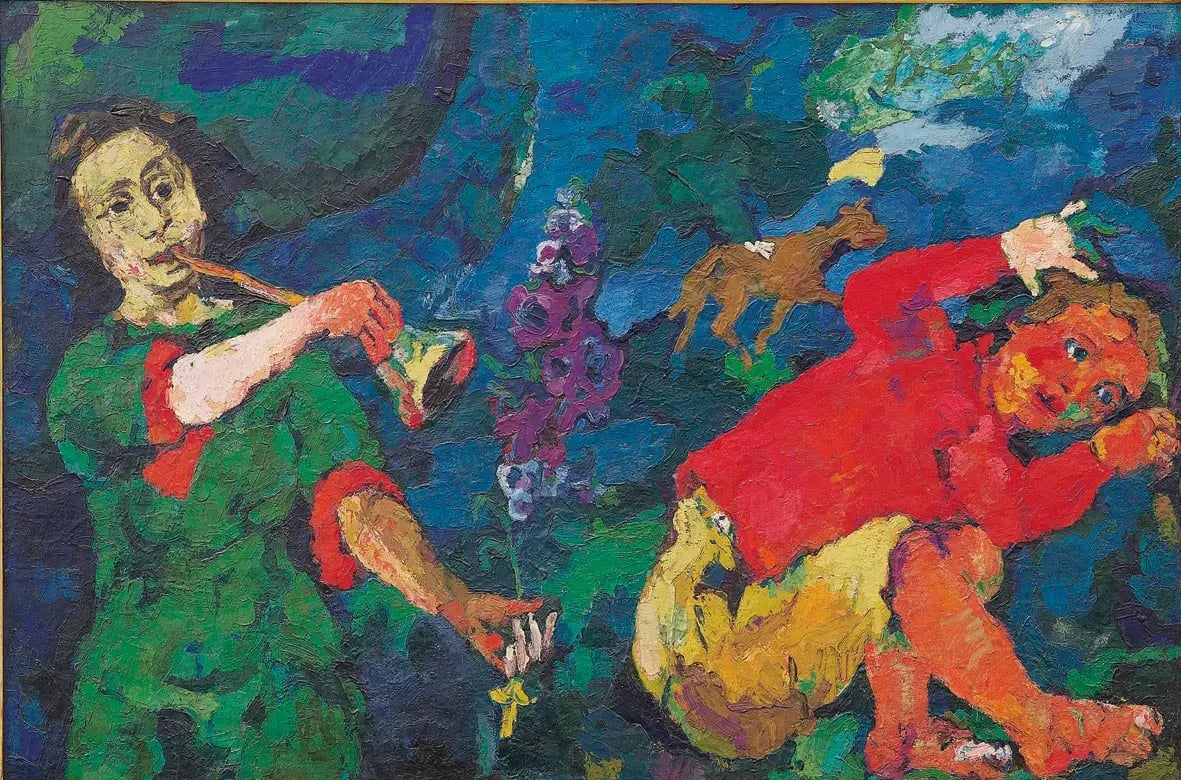Ingeborg Bachmann, fra trauma e utopia, dalla lirica alle «frasi vere»
Novecento austriaco A cura di Luigi Reitani sia le inedite note a «Invocazione all’Orsa Maggiore» sia la nuova disposizione del materiale narrativo di cui si compone «Il libro Franza»: riediti da Adelphi
 Jürgen Partenheimer, «Carmen (Sils I)», 2006
Jürgen Partenheimer, «Carmen (Sils I)», 2006Novecento austriaco A cura di Luigi Reitani sia le inedite note a «Invocazione all’Orsa Maggiore» sia la nuova disposizione del materiale narrativo di cui si compone «Il libro Franza»: riediti da Adelphi
Nel maggio del 1952, di fronte all’esigente Gruppo 47, riunito in conclave a Niendorf, in uno dei suoi celebri convegni che decretarono le fortune letterarie o, viceversa, le sventure di molti esordienti, Ingeborg Bachmann debuttò in grande stile e la sua intensa lettura poetica fu salutata come un miracolo. Tutti dissero che stava sorgendo un astro e, a un anno dall’ingresso trionfale sulla scena letteraria, l’abbrivio proseguì con la pubblicazione del Tempo dilazionato, la prima raccolta poetica: una voce inattesa, nuova, profilata, si stava imponendo nella poesia contemporanea di lingua tedesca.
La seconda raccolta fu la consacrazione definitiva: preparata nell’arco di quattro anni tra Ischia, Napoli e Roma e pubblicata nel settembre del 1956, Invocazione all’Orsa Maggiore fu un successo clamoroso: nel giro di otto settimane se ne vendettero millecinquecento copie, dopo qualche mese il libro era introvabile e l’editore Piper di Monaco dispose subito una seconda edizione. Nel cinquantenario della morte di Bachmann, alla fine del 2023, Adelphi ha riproposto Invocazione all’Orsa Maggiore (pp.333, € 24,00) con un ricco apparato iconografico, le traduzioni di Luigi Reitani, e il suo inappuntabile commento, denso di annotazioni d’autore finora sconosciute e tratto dall’edizione austriaca delle opere complete; a corredo, una breve nota di Hans Höller.
Inverno ’52 – estate ’56
Dopo l’esordio magmatico e militante del Tempo dilazionato, dove Bachmann rovesciava canoni e tropi prendendo congedo dalla tradizione e disallineandosi da ogni appartenenza, nell’Invocazione la sua poesia raggiunge un punto di cristallizzazione: vi convergono letture, esperienze, incontri, precedenti esiti letterari. I testi della raccolta, composti tra l’inverno del 1952 e l’estate del 1956, in parte inediti ma in larga misura già pubblicati su rivista, sono distribuiti in quattro sezioni, diverse per tema, per ambiente e per principio compositivo ma tenute insieme da una precisa volontà ordinatrice, che orchestra la silloge secondo una struttura organica.
Difficile individuare un tema di fondo, più sensato – invece – cercarne gli argomenti in motivi ricorrenti, diversamente modulati di testo in testo: la partenza, l’esilio, la fuga, la scoperta – quel «prendere paese» che compare in chiave programmatica a titolo di un celebre componimento – l’appropriazione di un nuovo spazio, tanto geografico quanto linguistico, le chiare topografie e l’ormeggio della lingua a paesaggi ben perimetrati, spesso più immaginari che reali, dai luoghi dell’infanzia al Meridione d’Italia, diviso tra la solarità mediterranea di Ischia, gli scorci di miseria in una Puglia ancestrale e l’idillio distrutto nei quartieri napoletani del dopoguerra. Fino al «valzer nero» di una Venezia al riparo da ogni frusto sentimentalismo e ai «blues della pioggia» a Harlem.
All’apparire della nuova raccolta, molti critici, accorsi in folla a commentarla, videro nei testi dell’Invocazione il raggiungimento di una piena maturità letteraria e il venire alla luce di un momento «classico», sancito dalla perfezione dei versi e dalla misurata regolarità del ritmo, in accordo alle cadenze del Rilke maturo e persino del classicismo goethiano, e confermato da un incontro, fertile e mai epigonale, con la tradizione letteraria. Nelle poesie dell’Invocazione è infatti visibile la ripresa e la nuova sintesi di temi pescati dal cuore del patrimonio culturale europeo: da Saffo a Lucrezio, dai siculo-toscani a Petrarca, dai Grimm a Heine, da Klopstock a Hölderlin, da Rilke a Trakl a Celan fino a T.S. Eliot. Lo stesso vale per il metro, con un rincorrersi di forme che riprendono, di volta in volta, la pentapodia giambica del classicismo di Weimar, il Lied romantico, il tono epico della ballata, le «immagini acustiche» di Eduard Mörike e di August von Platen, il cui viaggio in Italia era caro a Bachmann forse più che quello goethiano.
Ridurre le poesie dell’Invocazione – come ha fatto negli anni Sessanta e Settanta molta critica non immune da condizionamenti ideologici – a bacino dove rifluiscono, rimodellati da mani esperte, i temi della grande letteratura, o declassarne l’ardito metaforismo alla voce musicale e cristallina, quasi piovuta dal cielo, di una sibilla senza tempo, avrebbe come esito il disconoscimento del profondissimo legame (evidente a partire dagli anni Ottanta e ribadito dallo stesso Reitani nel commento critico al volume ) con la storia del dopoguerra, il pendolarismo tra trauma e utopia, il crinale sottilissimo tra speranza e sfiducia. O il doppio filo che lega la ricercatezza formale nell’Invocazione alla riflessione sul linguaggio, faccia a faccia con Musil, Weil, Bloch e soprattutto con Wittgenstein. O, ancora, il tentativo – condotto in parallelo a Paul Celan, forse l’interlocutore più importante – di rifondare la lingua oltre le distorsioni del dodicennio nero, oltre gli innumerevoli episodi di fascismo quotidiano che ancora costellano la società post-1945.
Sospettando che la via poetica, per lei da sempre sgombra, possa anestetizzare la problematizzazione del mondo, Bachmann prende commiato – dagli anni Sessanta, quasi senza ritorno – dalla lirica, mettendosi «in cerca di frasi vere» per dire la violenza di ogni giorno, chirurgica e puntiforme, compiuta senza spargimento di sangue. Nasce su questa premessa il progetto dell’incompiuta trilogia Cause di morte e si avvia nel 1966 il lavoro alla sua prima tessera, Il libro Franza, poi interrotto e pubblicato postumo nel 1978, anticipato nel 1971, vivente l’autrice, da Malina e accompagnato, sempre nel 1978, da Requiem per Fanny Goldmann.
In una nuova disposizione del materiale narrativo che ne fa risaltare il carattere frammentario, condotta da Luigi Reitani sul testo critico tedesco, con l’inclusione di alcuni scritti contigui per tema e composti nei dintorni cronologici del torso romanzesco, Il libro Franza è ora ripubblicato da Adelphi nella storica traduzione di Magda Olivetti, rivista per l’occasione (pp. 337, € 14,00).
Tra mistico e lisergico
È la storia in tre capitoli di Franziska, detta Franza, annientata nella psiche e nel corpo dal marito Jordan, psichiatra viennese, interprete perfetto di una società votata senza residuo alla violenza, che riproduce nel piccolo, forse meno magniloquenti ma identici nell’esito, i crimini del recente passato. Contrappeso all’analitica dissezione di ogni pulsionalità è il fratello geologo Martin, l’orecchio sempre teso ai ritmi della terra e partecipe con Franza dell’infanzia simbiotica in un’indistinta Carinzia, che miticamente rasenta la Galizia mitteleuropea oppure la Galilea teatro della predicazione di Gesù.
Per sfuggire alle logiche del sopruso che percorrono i nervi dell’Occidente, Franza e Martin – variazione sul tema dei fratelli incestuosi dove risuonano memorie culturali di civiltà antiche e altrettanto scoperti richiami a Musil – traversano il deserto egiziano; qui la protagonista si lascia andare a ebbrezze tra il mistico e il lisergico, ormai lontana, così le pare, dall’eros represso e dalle briglie della ragione strumentale. Salvo scoprire, alla fine del viaggio, che ogni liberazione è ingannevole e che nessuna favola resiste all’urto del logos: Il Cairo è una formicolante metropoli occidentale, incatramata nella violenza rappresa in alcune icastiche immagini che colpiscono lo sguardo di Franza, dal cammello scannato a un matrimonio, alla donna legata mani e piedi alla stazione, al demente cui i ragazzini versano Coca-Cola in bocca ridendo sguaiatamente, mentre un arabo afferma con sussiego: «he is a holy man».
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento