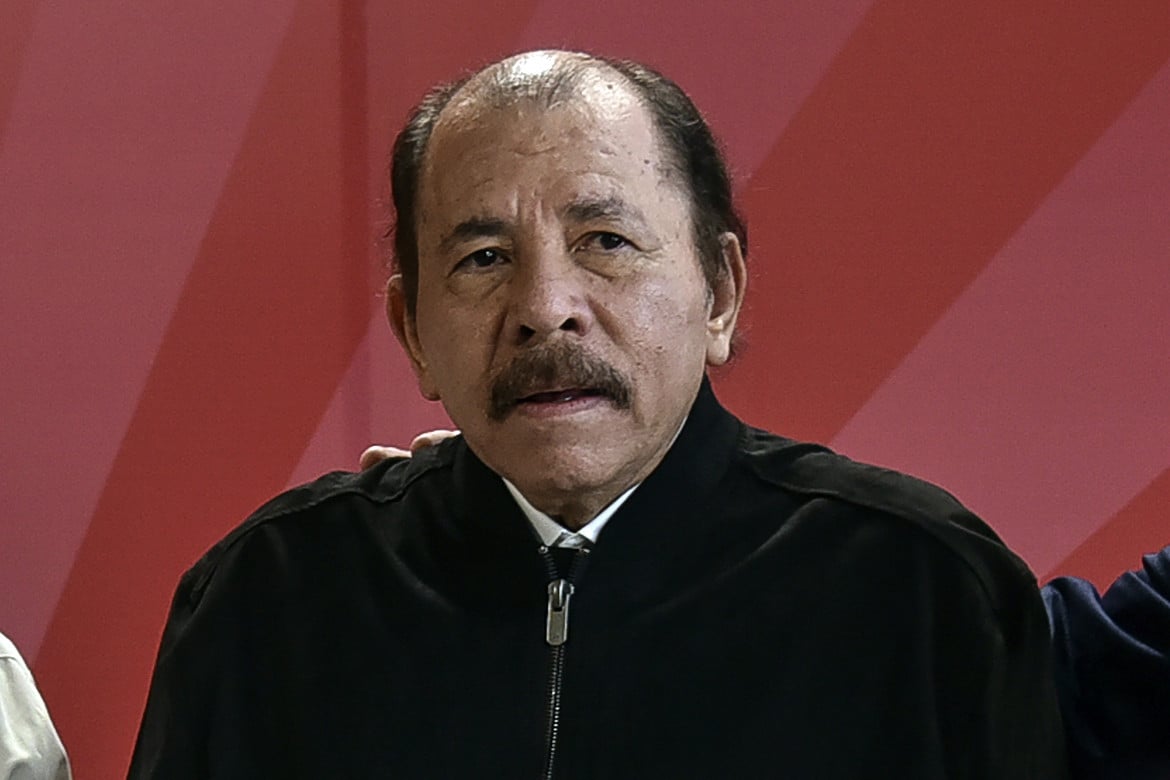Pubblicato 11 anni faEdizione del 1 giugno 2013
Valentina Veneroso, SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Case fatiscenti, taxi scassati, bambini giocolieri ai semafori, venditrici ambulanti di chicha o empanadas si alternano a centri commerciali, signore ben truccate e suv rilucenti. Siamo nel centro di Santa Cruz de la Sierra, nell’oriente boliviano. La città si sviluppa ad anelli concentrici, e non troppo lontano da qui, procedendo verso l’esterno, le strade sono sterrate e piene di enormi buche. Qui regna invece il cemento, il rumore dei clacson e sui cruscotti di tutti i mezzi intrappolati nel traffico ci sono peluche scoloriti e rosari, mentre dai finestrini abbassati escono parole d’amore intessute su un tappeto sonoro di salsa...