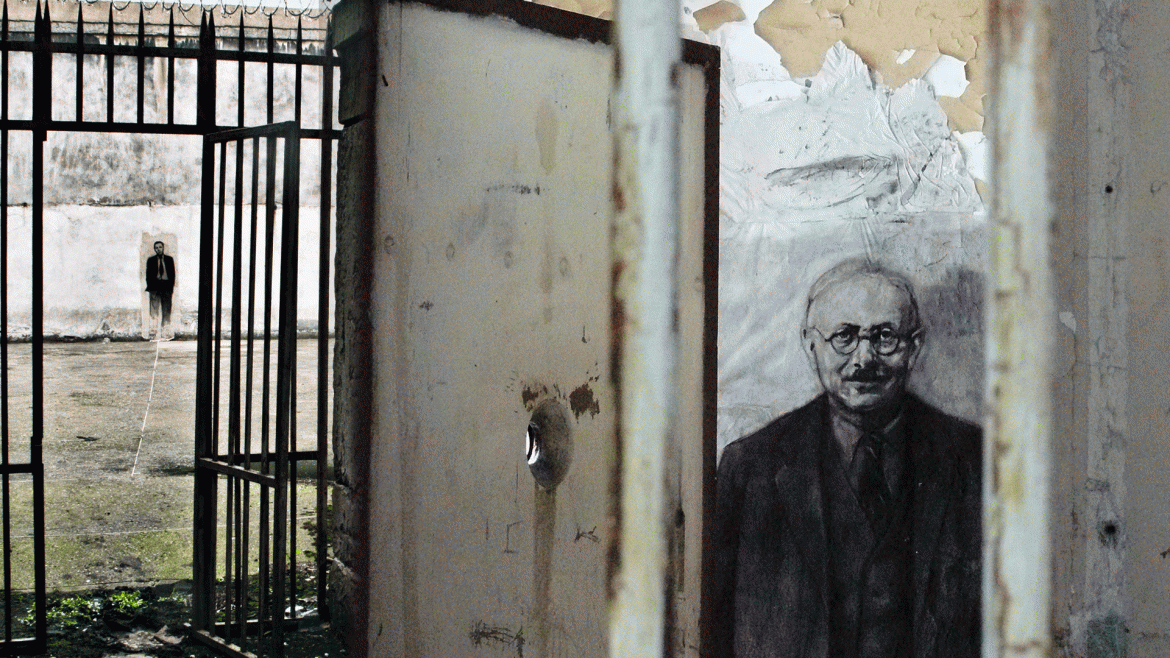Disinvolti e disinformati, alcuni commentatori continuano a discettare su nefaste conseguenze della sentenza della Corte di Strasburgo relativa all’ergastolo ostativo e sul mancato rinvio alla Grande Camera. Valutando tutto ciò come, nell’ordine: incomprensione europea delle peculiarità della criminalità organizzata in Italia, grave allentamento nella lotta per contrastarla, benefici assicurati alle organizzazioni criminali e, infine, tradimento di quanto i magistrati che hanno dato la vita per tale lotta hanno affermato con il loro sacrificio, da parte di chi obietta qualcosa o sostiene che la sentenza è in linea con il nostro testo costituzionale.
GIÀ: IL TESTO COSTITUZIONALE è invece assente nelle considerazioni di molti, troppi. La sua sintesi, per quanto riguarda le pene, sta nella loro finalità tendenziale, cioè la rieducazione. Questa, come la Corte costituzionale ha chiarito in più sentenze, ma in particolare in una famosa del 1990, non è una sorta di aggiunta inessenziale, ma un principio di orientamento delle pene stesse perché «se la finalizzazione venisse orientata verso diversi caratteri (affilittività, retributività), anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della sanzione. È per questo – aggiunge la Corte – che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena». Un principio, questo, che, come tutta la Costituzione, vale erga omnes, senza distinzione di singoli o di gravità del reato commesso.
Sul versante della Corte europea di Strasburgo – che nulla c’entra con i commenti di taluni che inseriscono il loro disappunto per la sentenza nello scarso feeling con l’Unione europea – compito centrale è stabilire se uno Stato rispetti o meno l’obbligo inderogabile a non sottoporre alcuna persona a trattamenti o pene inumani o degradanti (oltre che a tortura), così come affermato dall’art. 3 della Convenzione europea per i diritti umani.
La Corte non decide sulle conseguenze per i singoli ricorrenti, né ha il potere di modificare le leggi di uno Stato. Ma ha il dovere di stabilire se la situazione in esame rappresenta una violazione appunto di tale obbligo che non accetta eccezioni. Spetterà poi al singolo Stato ragionare e decidere come intervenire: tanto più quando una sentenza, come quella recente nel caso Viola contro Italia, individua una carenza di tipo strutturale e non soltanto una specifica e contingente lesione di un diritto. Ora, da tempo la Corte, nell’evoluzione della sua giurisprudenza, ha stabilito il principio che un ergastolo che non preveda una possibilità di revisione dopo un alto numero di anni – in linea indicativa almeno venticinque – per valutare il percorso compiuto dalla persona, la sua eventuale revisione di quanto commesso e la possibilità di un suo reinserimento nel contesto sociale, costituisce una trattamento in violazione proprio di quell’art. 3.
QUESTO PRINCIPIO è affermato per tutti gli Stati e i relativi ordinamenti, perché vuole evitare una preclusione assoluta a un’ipotesi di ritorno alla vita esterna. Il problema era stabilire se nel caso italiano e relativamente al cosiddetto ergastolo ‘ostativo’, che riguarda quasi il 70% degli ergastolani, la previsione di poter accedere a tale riconsiderazione solo nel caso che la persona, oltre ad aver aiutato a evitare ulteriori conseguenze all’attività criminosa «aiuti concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati», non finisse col rendere impossibile considerare altri fattori, che pur potrebbero caratterizzare il cambiamento della persona. Così configurando l’assenza di collaborazione come un’assoluta presunzione della sua pericolosità.
La Corte ha ritenuto che tale impossibilità di considerare un qualsiasi fattore diverso da quello unico e decisivo della collaborazione, di fatto, finisce col determinare un ergastolo «senza speranza», come tale in violazione dell’obbligo inderogabile stabilito in quell’articolo.
Spetta a ogni Stato stabilire le ‘forme’ secondo cui questa possibile riconsiderazione dopo i molti anni di esecuzione penale si realizzi: essenziale è che esso non sia un automatico criterio che finisce per non considerare il percorso compiuto dalla persona. Quindi, l’oggetto dell’analisi era strettamente limitato alla specifica legislazione dello specifico Stato, già esaminato dalla sezione della Corte. Da qui, il non rinvio che tanto ha suscitato agitati commenti.
Certamente la criminalità organizzata ha una sua specificità; certamente è difficile il venir meno di appartenenze che affondano le proprie radici in legami e culture ben profonde di adesione criminale. Ma altrettanto certamente l’impossibilità non può appartenere a una visione del diritto penale che, nel regolare conflitti e nel sanzionare chi aggredisce persone e contesti sociali, non può irrimediabilmente inchiodare la persona e il suo possibile mutamento al reato commesso, spesso molti decenni prima. Del resto, ci sarà sempre un giudice a dover valutare vari elementi e tra questi anche la volontà collaborativa, per capire se e quanto quella tendenziale finalità rieducativa che la Costituzione assegna alla pena si sia realizzata.
Tutto ciò non aggredisce la generosità e il valore di chi per tale lotta ha dato la vita. Al contrario, proprio da essi trova la capacità di affermare principi inderogabili.