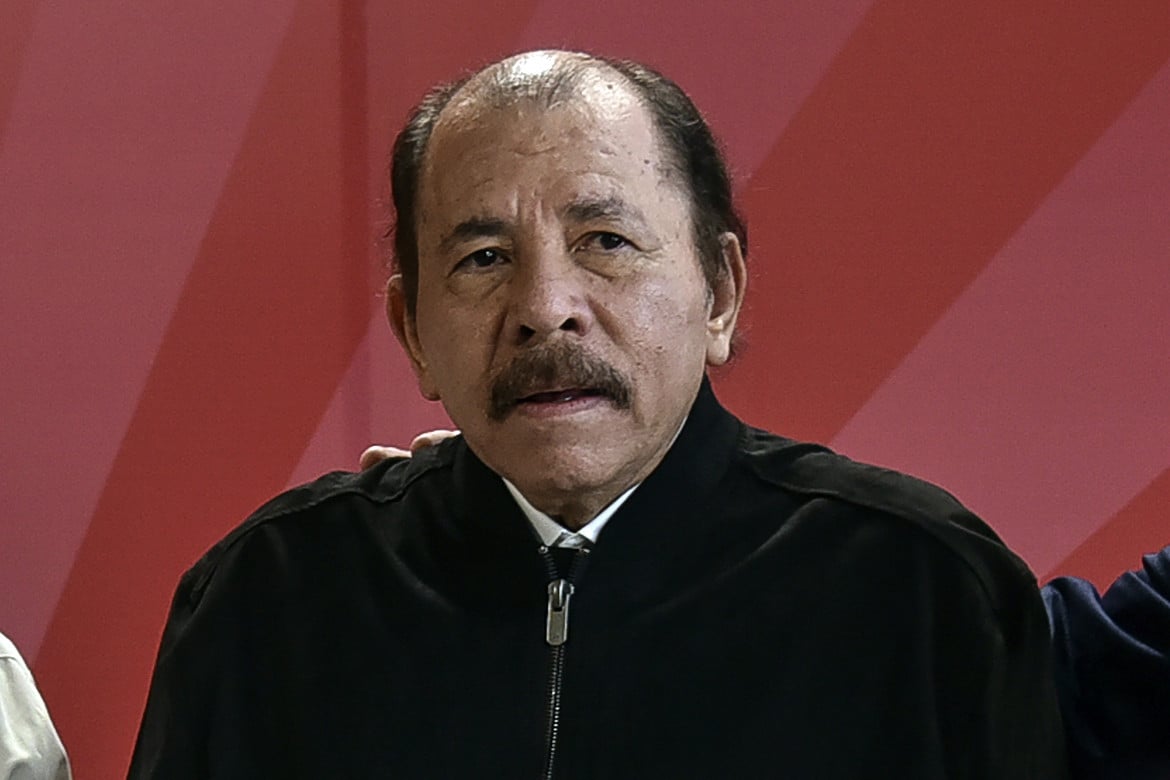Pubblicato 7 mesi faEdizione del 4 febbraio 2024
Elezioni presidenziali e parlamentari in pieno «stato di eccezione» oggi in El Salvador, con relativa sospensione delle garanzie costituzionali. E con il 42enne presidente Najib Bukele che si ripresenta violando il dettato costituzionale che ne vietava la ricandidatura. DEL RESTO QUESTO PAESE è stato da sempre assai tormentato. Dal massacro di decine di migliaia di campesinos quasi un secolo fa, alle dittature militari, fino ai dodici anni di guerra civile fra oligarchia/esercito e guerriglia culminati con gli accordi di pace del 1992 che propiziarono una fragile democratizzazione del paese. Con i sondaggi che lo danno oltre l’80% dei consensi, Bukele...