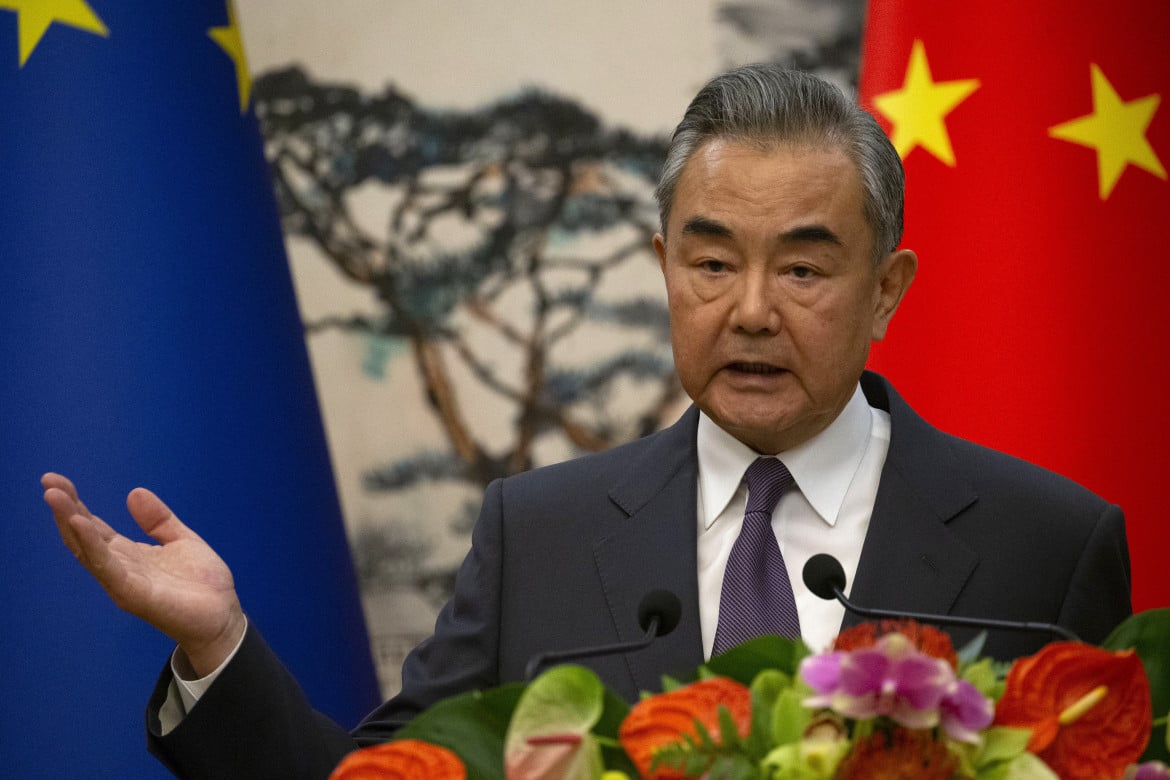«Capivo molto bene che le cose stavano andando sempre peggio, ma, fino all’ultimo, fino all’invasione dell’Ucraina pensavo che qualcosa si potesse ancora cambiare, potessimo ancora conquistare qualche libertà, malgrado la repressione, tanta gente in prigione, il clima che si faceva sempre più duro. Poi, il 24 febbraio dello scorso anno ho percepito chiaramente che l’ultima via di uscita da questa situazione si era ormai chiusa. A quel punto ho capito che io e la mia famiglia ce ne dovevamo andare. Volevo che i miei tre bambini crescessero in un mondo aperto. Sono nato nel 1969 e ricordo bene com’era chiusa la realtà nella quale sono diventato grande io».
Alla vigilia del suo arrivo nel nostro paese per partecipare al festival Libri Come all’Auditorium di Roma – l’incontro con i lettori sarà oggi alle 16 in Sala Ospiti accanto a Giorgio Zanchni -, Valerij Panjuškin risponde da Riga alle domande del manifesto. Dal quel tragico 24 febbraio ha capito che avrebbe voluto cercare di fermare la guerra di Putin all’Ucraina, o perlomeno raccontare con gli strumenti del suo lavoro di cronista la tragedia di cui è vittima la popolazione civile del paese invaso. Anche se la conseguenza sarebbe stata dover lasciare il proprio di paese, la Russia.
Giornalista, scrittore, autore radiofonico cui si devono alcune delle inchieste più significative che sono arrivate da Mosca negli ultimi anni – in Italia e/o ha già pubblicato L’Olimpo di Putin e 12 che hanno detto no -, Panjuškin dà voce in L’ora del lupo (e/o, traduzione di Claudia Zonghetti, pp. 230, euro 18) ai rifugiati ucraini e alle loro storie di dolore, di sofferenza, di resistenza, mettendo al tempo stesso in luce come in molti, anche in Russia, abbiano cercato di dare loro una mano.
C’è Alla che di lavoro faceva la scienziata a Charkiv e fino all’ultimo non ha creduto che i russi arrivassero davvero, c’è Vladimir che a Odessa vende tapparelle e il 24 febbraio incurante del pericolo esce per andare a un appuntamento di lavoro. E c’è Viktoria che il giorno dell’invasione è in ospedale a Kiev accanto alla figlia quindicenne che deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Figure che incontriamo, conosciamo nella loro normalità e poi seguiamo nel tentativo disperato di sopravvivere e portare in salvo i propri cari dopo l’arrivo dei soldati russi.
Questo, mentre a Mosca una fitta cappa di propaganda si stendeva su ogni cosa, rendendo impossibile perfino in famiglia parlare liberamente, valutare quanto stava accadendo davvero, al punto che «la lingua russa è diventata la lingua della menzogna: in Russia è vietato dire la verità e neanche la guerra può essere chiamata con il suo nome».

Il libro nasce da un’urgenza, quasi da una necessità: quando ha deciso di raccogliere le storie di questi profughi?
Fin dall’inizio dell’invasione stavo malissimo, non potevo credere a quanto accadeva. In Ucraina ho molti amici e sia la mia prima moglie che quella attuale sono ucraine, perciò mi sembrava impossibile. Allora ho cominciato a telefonare alle redazioni dei giornali per cui ho lavorato in passato per capire se potevo farmi mandare come inviato in Ucraina. Ma mi hanno risposto che sono troppo vecchio per stare in prima linea, dove si deve correre, scattare quando succede qualcosa. Eppure sentivo che non potevo assistere in modo passivo a tutto ciò: dovevo fare qualcosa per fermare questa guerra. O perlomeno per raccontare quanto avveniva. Così, parlando con un amico giornalista che ora lavora per il governo di Kiev, un ucraino di origine afghana, Mustafa Nayyem, ho capito che avrei potuto dare un contributo raccontando le storie di quanti avevano dovuto lasciare tutto e fuggire.
Come è entrato in contatto con le persone di cui racconta la storia e, malgrado siano tutte strazianti, c’è una vicenda che l’ha colpita in modo particolare?
Paradossalmente è stato abbastanza facile. Intanto leggevo quello che molte di queste persone raccontavano sui social e li ho contattati allo stesso modo. Poi ho incontrato coloro che stavano arrivando nei campi profughi in territorio russo. Almeno per le prime settimane era abbastanza facile entrare in questi campi e parlare con chi era stato costretto a fuggire dall’Ucraina. Oggi sarebbe impossibile perché l’intelligence ha preso il controllo dei centri e non farebbe mai avvicinare un giornalista. Quanto alla storia che mi ha colpito di più, non ho dubbi: è quella del bambino di Mariupol. Mentre la colonna di auto sta uscendo dalla città ci si accorge che all’.appello manca un bambino di cinque anni, ma hanno deciso di non fermarsi, perché è troppo pericoloso. Lui era spaventato e si è andato a nascondere tra i ruderi di una casa bombardata, così quando si sono messi in marcia non lo hanno trovato più.
In un centro di accoglienza della Repubblica Ceca Alla incontra una donna che è in fuga dal 1994 quando ha lasciato la Cecenia. Quanto sta accadendo in Ucraina è l’ultimo capitolo di una storia che per la Russia si è aperta nel Caucaso?
Temo che potrebbe non essere l’ultimo capitolo. E credo che questa storia non si sia aperta con la guerra in Cecenia, ma molto prima, in Afghanistan e, andando ancor più a ritroso nel tempo, a Praga e a Budapest quando sono arrivati i carri armati russi. Ancora oggi non mi so spiegare perché la Russia sia intervenuta in Afghanistan. Quanto alle guerre cecene, durante la prima ero ancora uno studente, in quel periodo studiavo a Firenze, mentre la seconda la ricordo bene e sì, assomiglia molto a quella che si sta combattendo in Ucraina. Sul fondo credo che per la Russia si tratti sempre dello stesso motivo, in particolare dagli anni ’90, dopo la fine dell’Urss, si vuole riaffermare in qualche modo la grandezza perduta del paese. A me e a molti altri russi non importa assolutamente nulla di tutto questo, ma ad esempio i militari non parlano d’altro da sempre.
A più di vent’anni dal suo arrivo al potere e dopo tutte le guerre e la repressione che imposto ai russi, a cosa si deve il consenso di cui gode ancora Putin?
Non so perché e non saprei indicarne le ragioni più profonde, ma per molti russi è quasi impossibile sentirsi indipendenti, percepirsi prima di tutto come degli individui. Hanno bisogno di sentire che fanno parte di qualcosa di più grande, importante. Penso a mio padre, di cui parlo nel libro. Lui ha bisogno di esprimere la propria fiducia in qualcosa che ritiene rilevante, significativo. Non vuole sentirsi diverso o semplicemente un individuo con un proprio percorso particolare. La Russia è enorme, da Mosca a Vladivostok ci vogliono otto ore di aereo, ma la lingua è una sola, non esistono dialetti e lo stesso o quasi si può dire per la cucina, a parte che nel Caucaso o nel Tatarstan non esistono piatti regionali, quando in Italia basta fare cento chilometri e cambia tutto. Diciamo che i russi non sanno vivere insieme essendo diversi: per vivere insieme dobbiamo essere almeno per molti aspetti uguali. Così, gli ucraini che sono diversi diventano implicitamente anche nemici. Credo che tutto ciò sia un’eredità dell’epoca dei gulag quando le persone e le comunità venivano spostate a forza o costrette a rinunciare a ogni specificità.
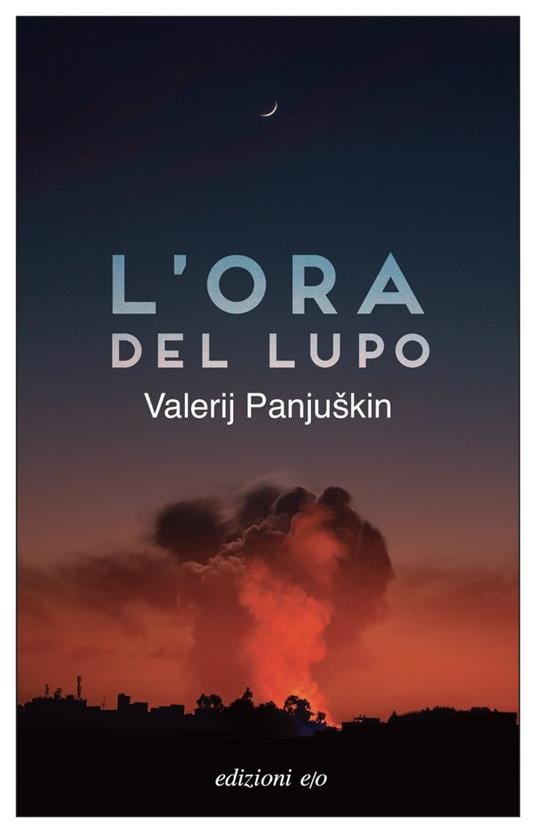
Non saprei dire cosa pensa chi vive nei piccoli centri o nelle campagne, ma a Mosca questa divisione è palpabile, attraversa le famiglie, gli affetti, ogni legame. Da noi ora c’è un nuovo modo di dire che illustra bene la situazione: «Ho chiamato la mamma, ma ho parlato con la tv». Ed è davvero così. Parlo con mio padre e lui mi risponde con le parole della propaganda, quasi non mi riconoscesse neppure. E non si tratta di un caso isolato.
Accanto al racconto del dolore e delle perdite che l’invasione russa ha inflitto alla popolazione ucraina, lei descrive molti esempi di solidarietà individuale, spontanea, ma anche organizzata verso i profughi che si sono registrati, e talvolta anche in Russia, almeno all’inizio della guerra.
Credo che tutto ciò abbia a che fare con quanto dicevo all’inizio: si tratta di persone che sentivano, come l’ho sentito anch’io, che dovevano fare qualcosa perché la sola idea di questa guerra era insopportabile. Per questo, da subito sono partite tante forme di solidarietà: c’è chi ha accolto i profughi, chi li ha ospitati, chi ha comprato loro i biglietti per raggiungere le destinazioni che avevano scelto, ad esempio i Paesi Baltici. Per le persone normali, fare tutto ciò, esprimere concretamente questa solidarietà era l’unico modo per sopravvivere in mezzo ad una società, quella russa che sembra invece essere completamente impazzita. Certo, non è pericoloso come combattere a fianco degli ucraini, ma perlomeno non ti fa sentire una merda.
Ha lasciato Mosca quando ha capito che questo libro non sarebbe potuto essere pubblicato nel suo paese. Ora come guarda al futuro della Russia?
Ritengo che Putin perderà la guerra in Ucraina e che una volta accaduto la Russia possa avviarsi verso una stagione di guerra civile. Nel paese esiste già un esercito privato, la Wagner di Prigozhin, e uno locale, quello ceceno di Kadyrov, e dopo che con la sconfitta molti in Russia capiranno che l’idea di far rinascere l’Urss non funziona, simili forze si moltiplicheranno, vedremo apparire l’armata di Gazprom e quella di Rosneft: tutti contro tutti e in più alcuni dei contendenti potranno disporre dell’arma atomica. Un vero disastro che neppure riesco ad immaginare. Però è certo che finché ci saranno Putin e il suo regime non farò ritorno nel mio paese.