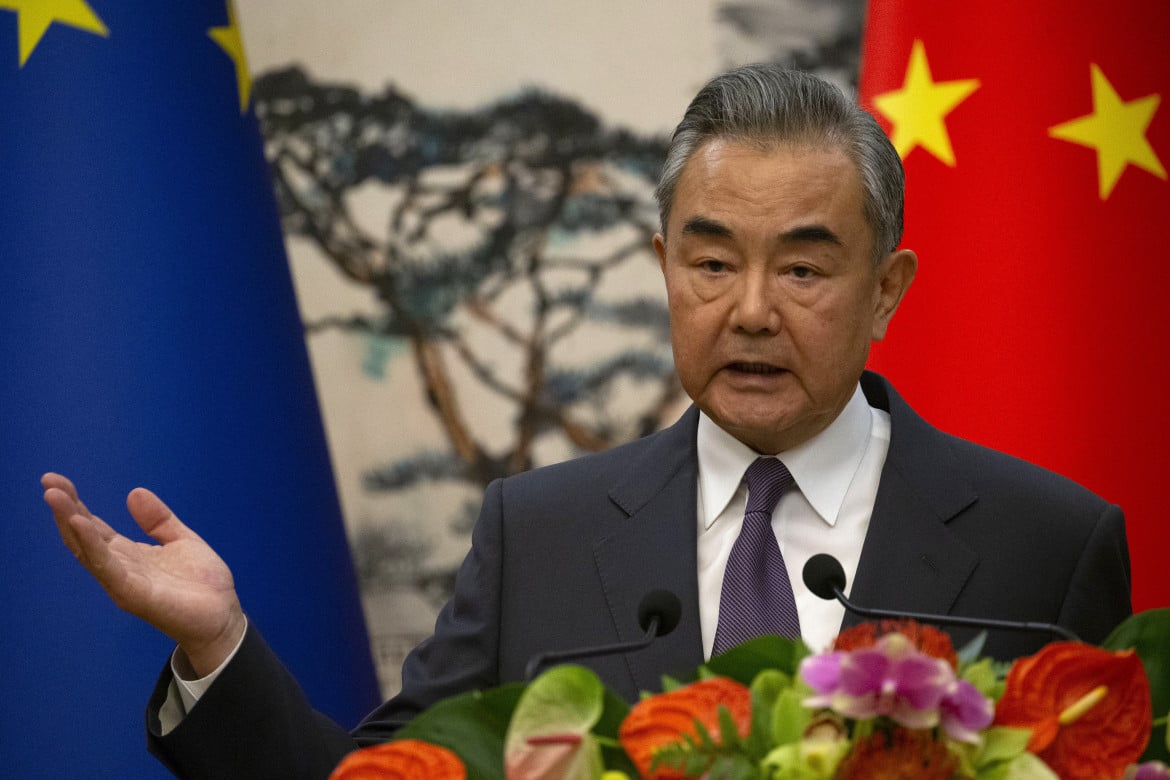La prima volta era stata nel 1985, poco dopo aver esordito alla presidenza del Nicaragua. La seconda volta è arrivata in concomitanza con il summit per la democrazia di Joe Biden. Daniel Ortega l’ha fatto di nuovo: ha rotto le relazioni diplomatiche con la Repubblica di Cina (Taiwan) e le ha avviate con la Repubblica Popolare Cinese. Eppure dal suo ritorno al potere nel 2007 aveva incontrato l’ex presidente taiwanese Ma Ying-jeou e aveva proseguito l’accordo di libero scambio riavviato nel 1990 dalla sua temporanea erede Violeta Barrios Torres de Chamorro. «La Repubblica Popolare Cinese è il solo governo legittimo che rappresenta tutta la Cina e Taiwan è una indiscutibile parte del territorio cinese», dice ora il ministero degli Esteri del Nicaragua, i cui funzionari hanno subito incontrato controparti cinesi a Tianjin.
Per la Cina si tratta di un risultato simbolico, vista l’insofferenza per l’invito di Taiwan al summit di Biden. Eppure non è stata coinvolta Tsai Ing-wen, come sperava Taipei, ma la ministra per il Digitale Audrey Tang. Negli scorsi mesi si era trattato sulla partecipazione della presidente taiwanese, ipotesi alla quale il Global Times aveva risposto invitando l’Esercito popolare di liberazione a sorvolare il territorio dell’isola.
Gli Stati Uniti hanno criticato la scelta del Nicaragua, con l’invito alle democrazie di «procedere in senso contrario e approfondire i legami con Taiwan». D’altronde, i rapporti tra Washington e Managua sono compromessi. Dopo le presidenziali del 7 novembre vinte da Ortega con diversi candidati d’opposizione in manette, la Casa Bianca ha imposto il divieto d’ingresso negli Usa a gran parte degli esponenti di governo.
L’Organizzazione degli stati americani ha avviato l’iter per l’espulsione di Managua, che ha annunciato a sua volta la fuoriuscita per le «ripetute ingerenze negli affari interni del Nicaragua» di un’organizzazione definita «ostaggio di Washington». Segnali di insofferenza diffusa in una regione, l’America centrale, dove Taiwan ha perso negli ultimi anni anche El Salvador e Panama, con l’Honduras della neo presidente Xiomara Castro che potrebbe compiere la stessa scelta. Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio di Pechino per gli Affari di Taiwan ha esortato «i pochissimi alleati diplomatici» di Taipei a «schierarsi dal lato giusto della storia il prima possibile», definendo la «completa riunificazione» una «tendenza storica inarrestabile». Il ministero degli Esteri sostiene che si tratti di una «decisione politica senza prerequisiti economici, non una merce di scambio». Tsai ha risposto che «nessuna pressione esterna può scuotere il nostro impegno per la libertà, i diritti umani e la collaborazione con la comunità democratica internazionale».
Nonostante si tratti dell’ottavo alleato perso dall’avvento di Tsai nel 2016, a Taiwan c’è anche chi si felicita per la rottura dei rapporti con Managua. Taipei propone infatti da tempo la narrativa dei cosiddetti like-minded partner, vale a dire democrazie con lo stesso approccio aperto politicamente e progressista in materia di diritti civili.
Descrizione inappropriata per il Nicaragua, dove dal 2018 le proteste sono state represse nel sangue con centinaia di morti e arresti. Nonostante questo gli investimenti taiwanesi non si erano fermati, seppure un finanziamento da 100 milioni di dollari predisposto nel 2019 non sia mai stato incassato. Non è l’unico dei 14 alleati rimasti a rappresentare motivo di imbarazzo. Non a caso il Taipei Times preferisce sottolineare il rafforzamento delle relazioni con i partner non ufficiali come Usa e Giappone.