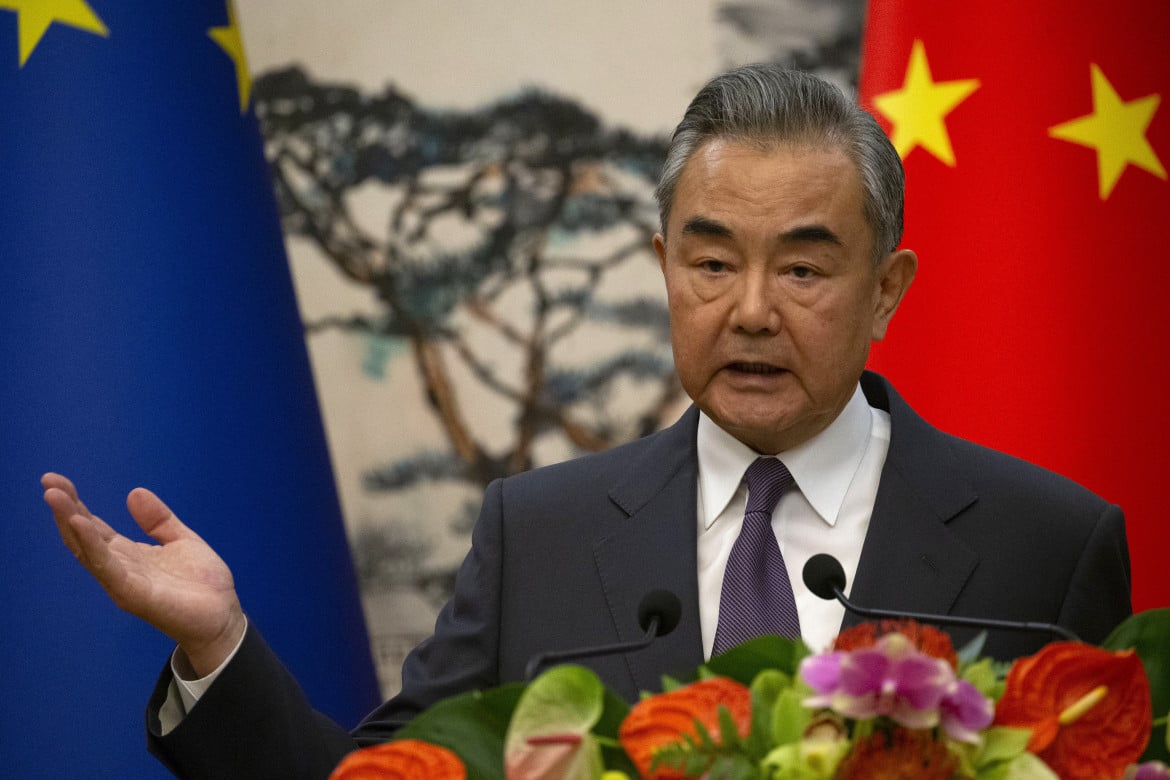Ricorre in questi giorni quasi unanime il giudizio secondo cui la guerra di Putin avrebbe ottenuto il contrario di quanto, fra altro, si prefiggeva e cioè dividere l’Europa. Mai come in questo momento l’Unione europea appare compatta nel sostegno a Kiev e nella condanna dell’invasione, tanto da sopportare i molti inconvenienti che questo schieramento comporta. Per la spesa militare, molto più che per la pandemia, non vi è frugalità che tenga e l’incubo dei debiti pubblici ha cessato di tormentare le notti dei rigoristi nordeuropei. Se la politica moscovita si prolunga ora nella guerra, la risposta non ammette timidezze né risparmi, la politica economica si prolunga nella spesa militare.
Converrebbe tuttavia prendere in esame la qualità di questa compattezza europea messa in ombra dall’emergenza bellica. Soprattutto quando, secondo uno schema riproposto in ogni occasione di conflitto, i governi occidentali evocano lo scontro tra democrazia e dittatura. Con il vantaggio, questa volta, di non trovarsi nella scomoda posizione dell’export, potendosi, al contrario, misurare con un «esportatore della non democrazia».
Pochi giorni prima che i carri armati russi varcassero le frontiere dell’Ucraina la corte di giustizia europea aveva respinto il ricorso mosso da Budapest e Varsavia contro il vincolo, voluto da gran parte degli stati membri dell’Unione e dalla Commissione, tra l’erogazione di fondi europei e il rispetto dello stato di diritto. Grazie alla guerra e alla loro posizione geografica, Polonia e Ungheria saranno ora inondati di denaro. Mentre dei tratti autoritari e razzisti del nazionalismo che si è affermato in quei paesi nessuno oserà più parlare. Tanto è vero che non vi è governo occidentale che abbia manifestato qualche indignazione di fronte alle ripetute denunce di discriminazione tra i profughi “europei” e quelli orientali e africani, per l’ennesima volta in fuga dalla guerra alla frontiera di quei paesi.
Nel nazionalismo di buona parte dell’Europa orientale il progetto europeo, quello politico s’intende, è andato a sbattere contro i suoi limiti. Quello economico, invece, attraverso quegli stessi nazionalismi, maestri nel tenere a bada i conflitti interni, garantire la docilità della forza lavoro e i profitti degli investitori, poteva appagare i suoi più smodati appetiti. Del resto non è un mistero che il nazionalismo sia tanto efficace nel soffocare le rivoluzioni democratiche e i conflitti sociali quanto incline alle avventure belliche. Anche in Europa, come le guerre balcaniche degli anni Novanta del secolo scorso e il gioco spregiudicato condotto dalle capitali europee in quel frangente, hanno chiarito una volta per tutte.
Così anche sul nazionalismo russo l’Europa ha lungamente coltivato le sue illusioni, abbagliata dagli affari che il pieno ingresso dell’ex Unione sovietica nel libero mercato avrebbe consentito. Sorvolando però sul fatto evidente che quel paese era troppo grande e segnato dalla sua storia di potere per sedersi composto alla tavola delle élites europee. Di tutti i nazionalismi quello russo si sarebbe presto rivelato il peggiore e il più pericoloso. Lo avevano ben capito le destre più o meno estreme di tutto il mondo che andavano osannando e corteggiando Vladimir Putin, lo sbirro salito dagli oscuri sotterranei del Kgb ai luminosi saloni del Cremlino. Conservatori e reazionari d’ogni risma, dall’America dei Bannon e dei fanatici evangelici all’Europa dei neonazisti e dei sovranisti, entusiasti del pugno di ferro, della disciplina sociale, della morale di stato e del bigottismo imposti dal nuovo zar. Puntualmente ricambiati dai favori occulti e palesi del Cremlino.
Se non vuole uscirne più sfigurata di quanto già non sia l’Europa dovrà respingere la tentazione di servirsi ancora una volta delle spinte nazionaliste in un gioco tutto interno agli schemi della geopolitica. La compattezza “contro” non corrisponde affatto a una condivisione “per” e l’allargamento dell’Ue ad est ha già imposto pesanti zavorre politiche. I segnali, provenienti dalle capitali europee non sono affatto rassicuranti. Con il riarmo della Germania e la destinazione di enormi risorse permanenti alla spesa militare il cancelliere Scholz demolisce uno dei principi fondativi della Germania postbellica e una delle bandiere storiche del suo stesso partito, la cui sinistra si accinge ora a dargli battaglia. Si tratta di una decisione di grandissimo valore simbolico, di un completo rovesciamento della Ostpolitik, il modello di coesistenza tra est e ovest perseguito a suo tempo da Willy Brandt, di una anticipazione unilaterale sul tema della difesa comune europea, di una concessione alla destra tedesca che da anni scalpita per il superamento dei vincoli che la Repubblica federale si era data dopo il disastro della seconda guerra mondiale.
La compattezza dell’Unione europea rischia di essere armata fino ai denti, affumicata dalle centrali a carbone riaperte per sostituire il gas russo, debole e compromissoria, in nome dell’emergenza, nei confronti delle derive autoritarie che affliggono il suo fianco orientale. Un risultato di cui Putin potrebbe essere soddisfatto. E, perché no, anche le destre di casa nostra.