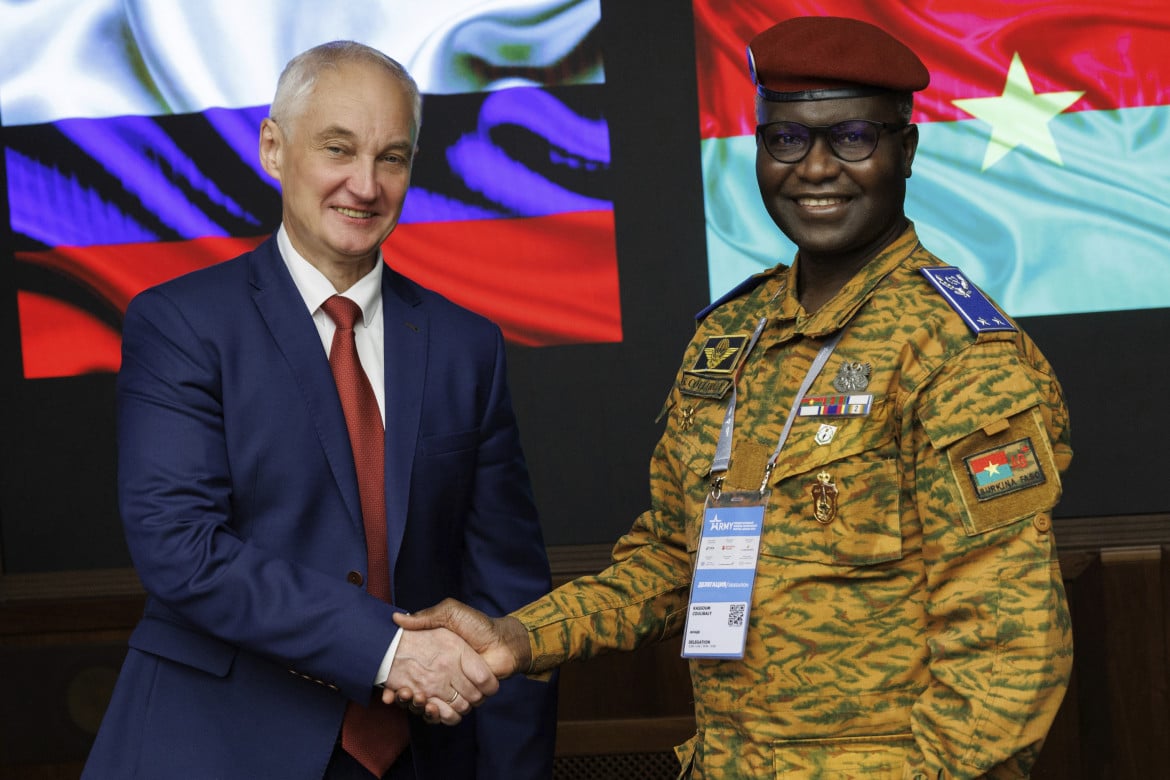Pubblicato 7 mesi faEdizione del 3 febbraio 2024
«Se sterminiamo definitivamente gli scarafaggi nessuno al mondo ci verrà a giudicare». Era la primavera di 30 anni fa quando da Kigali, capitale del Ruanda, la Radio Televisione Libera delle Mille Colline incitava al genocidio della popolazione della minoranza etnica tutsi, fomentando uno dei più impressionanti massacri che la storia ricordi. Nello stato che sorge nel cuore dell’Africa appena sotto la linea equatoriale, anni di divisioni politiche e sociali e di conflitti tra le etnie hutu e tutsi trovarono il culmine in cento giorni di follia collettiva che portò allo sterminio di centinaia di migliaia di persone: uomini, donne e...