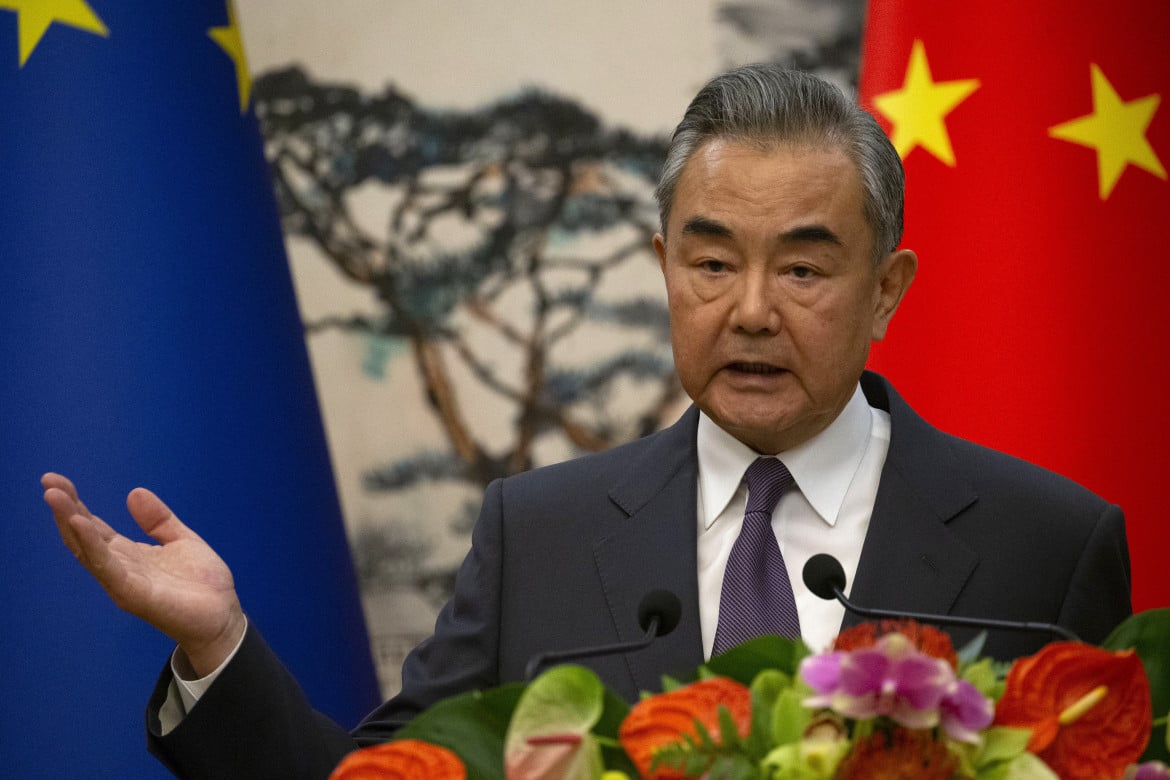Una vecchia Lada imbocca la salita d’ingresso all’obitorio troppo veloce e gratta l’asfalto con il muso, il carretto a rimorchio sobbalza.
Arrivano due militari che slegano i tiranti della tela cerata blu sul carretto, lo scoprono, parlano con il conducente, segnano qualcosa su un grosso registro e fanno cenno all’uomo di richiudere. C’è un corpo morto in quel carretto. Altri ne arrivano con delle vecchie Uaz militari e con furgoni bianchi.
IL PALAZZO dell’amministrazione regionale di Mykolayiv è stato colpito poche ore prima da un missile russo, forse un Iskander, lanciato dal Mar Nero. Passando dal centro della città, i militari di guardia ai posti di blocco non ci avevano lasciato entrare e da lontano attraverso la voragine al centro dell’imponente edificio, si intravedeva il blu del cielo dall’altro lato.
Oltre a tonnellate di macerie, vetri su tutto il manto stradale che riflettevano la luce dai marciapiedi e il braccio della ruspa in azione.
La porta della stanza al piano terra dell’obitorio si apre lentamente mentre militari, poliziotti e due medici legali sono impegnati nel riconoscimento dei corpi. L’immagine che si rivela è di quelle che restano impresse tutta la vita, mai creduto che un corpo umano potesse assumere tali colori né che gli occhi di una persona potessero diventare così.
Il medico legale uscendo si accorge che stiamo fissando e chiude la porta, forse più per delicatezza che per imporre un divieto. Ma la porta non si chiude bene e ritorna quella stanza infernale, notiamo anche alcuni pantaloni militari, una cintura e uno scarpone.
Un poliziotto interviene definitivamente e ci chiede di allontanarci oltre il cancello. Chiede, non ordina, nessuno urla e nessuno è aggressivo.
Nel piazzale del parcheggio ci sono alcune macchine ferme ma non sono le uniche, anche in strada c’è qualcuno con il motore acceso. Sono i parenti delle vittime, qui per il riconoscimento: bevono caffè, fumano, parlano a scatti, come se ogni volta riemergessero da un sogno, e aspettano.
UNA FOTOGRAFA americana si avvicina per chiedere se pensiamo che ci sia qualcosa da fotografare, poi mostra una foto scattata da lei di un obitorio a Kiev che ritrae un sacco nero su un carrello di metallo in una corsia d’ospedale. «Qualcosa del genere?», chiede. «Per niente – rispondiamo – Se vuoi avvicinati ai furgoni quando arrivano» e poi le indichiamo la porta che ora è chiusa: «Decidi tu».
Quando arriva un nuovo mezzo la vediamo che cammina verso il cortile interno e si apposta, ma da quel furgone scaricano solo barelle di metallo con il pianale ricoperto di nastro telato nero. Se ne va delusa dicendo che non può aspettare tutto il giorno lì.
Arrivano un vecchio e una bambina molto piccola, lei ha in mano un plum-cake e lo succhia più che mangiarlo, il nonno non la guarda e fuma in continuazione mentre parla con una signora parcheggiata a fianco che ogni tanto le dice qualcosa con il tono ridicolo che usano gli adulti con i bimbi.
Prima di sapere se la storia drammatica che abbiamo costruito vedendoli corrisponde alla realtà tragica di questo trentatreesimo giorno di guerra, partiamo verso nord-est con due colleghi.
Nella notte i russi sono stati respinti all’altezza di Kryvyj Rih e hanno ripiegato per circa 50 chilometri, una distanza non indifferente se si considera plausibile l’ipotesi che il conflitto tra Russia e Ucraina si stia trasformano in una guerra di posizione.
La ritirata russa si starebbe sviluppando lungo l’autostrada H23 che da Kryvyj Rih arriva a Mar’yans’ke sul fiume Dnipro, poco a nord di quella Novovorontsovka che gli ucraini hanno riconquistato due notti fa. Più o meno a metà strada tra Kherson e Dnipropetrovsk, ancora più vicino c’è Zaporizhzha con la sua centrale nucleare e lo spauracchio di una catastrofe.
EPPURE, NONOSTANTE tutto, in questa zona i russi guadagnano terreno lentamente e lo perdono in fretta, soprattutto dopo la conquista di Kherson alla quale, è evidente, hanno assegnato un ruolo strategico fondamentale.
Anche se gli abitanti della città non sembrano troppo d’accordo con la nuova gestione e hanno già organizzato due manifestazioni per ribadire che «Kherson è ucraina», proteste alle quali le forze di sicurezza russe hanno risposto sparando qualche colpo e persino una granata.
Tutto ciò non vuol dire nulla, anzi, potrebbe essere solo un ritorno di fiamma che le truppe russe hanno avuto ordine di sedare duramente ma senza fare una strage per non inimicarsi ulteriormente i cittadini del territorio occupato dove, stando a fonti locali, a breve Mosca vorrebbe organizzare un referendum per un’annessione in stile Crimea.
PIÙ A NORD, tuttavia, i russi erano già riusciti a sfondare un mese fa. Lungo l’H11 che parte da Mykolayiv e arriva proprio a Kryvyj Rih ancora si vedono resti di mezzi carbonizzati e qualche trincea lungo la strada. Una specie di motel prima di Bashtanka oggi è diventata la caserma dei militari a guardia della città da sud.
La facciata è stata bombardata e al posto dei vetri ci sono tavole di legno e teli di plastica opaca, «ma qui la notte fa freddo», ci spiega un ragazzo che fatica a sfilarsi il kalashnikov dal collo a causa dell’equipaggiamento ingombrante appeso al giubbotto antiproiettile.
Nel centro di Bashtanka il supermercato ha conservato i muri al pianterreno ma è completamente nero e distrutto al piano superiore. «Sono stati i carri armati russi la notte del primo marzo», raccontano due civili con fucili da caccia a tracolla che si erano avvicinati per controllare cosa facessimo.
Dal primo marzo a oggi è passato quasi un mese e i russi non ci sono più, neanche nei paesi vicini o in tutta la zona a ovest di qui. Anche per questo, sentire che «l’operazione speciale procede secondo i piani» dalle fonti del Cremlino sembra mera propaganda.
AL RITORNO riproviamo con il palazzo dell’amministrazione regionale. Questa volta Dmitryi, l’addetto stampa dell’esercito ci permette di passare a patto di fotografare solo l’edificio e nessuna «cosa militare», categoria sempre più alta nella quale per Dmityi ormai rientrano anche i sacchetti di sabbia, oltre ai soldati.
Visto da vicino il palazzo si presenta ancora più imponente e la parte mancante sembra asportata di netto, quasi con precisione da quel missile lanciato da centinaia di chilometri di distanza.
Le ruspe sono ancora al lavoro, così come i camion che portano via le macerie e diverse squadre di pompieri. Si cercano ancora i corpi e si lavora senza sosta per sperare di trovare i sopravvissuti in tempo. A fine giornata il bilancio si è attestato su dieci morti e venticinque feriti, di cui alcuni in condizioni critiche.
«Ma ne usciranno molti altri», dice Dmitry mentre pensiamo che se qui si continuerà a scavare nel piazzale dell’obitorio orfani, vedove e genitori continueranno ad avvicendarsi in attesa di entrare in quella stanza a guardare in faccia un cadavere per dichiarare che è proprio la persona che gli manca.