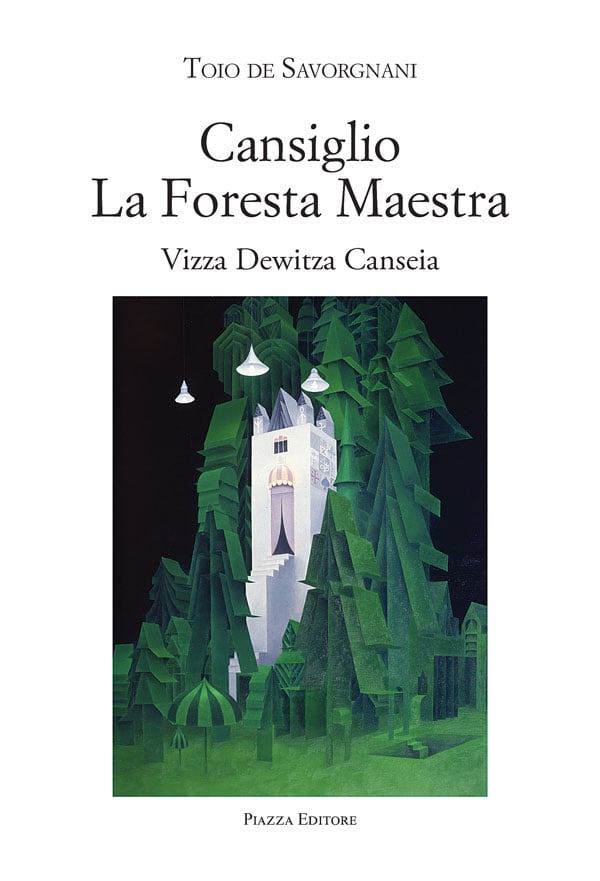Montagna, i racconti di una ossessione
Il silenzio della montagna lascia il passo alla parola e le cime diventano luogo di incontro e di confronto tra generazioni. Negli ultimi tempi il tema della montagna è stato preminente per la mancanza di neve, che significa meno acqua per la nostra vita, per le piante, per l’agricoltura. Numerose, infatti, sono state negli ultimi mesi le pubblicazioni che hanno avuto al centro la montagna nelle sue varie sfaccettature. Partiamo dal genere letterario più vicino ai giovani come il graphic novel, Jacopo Starace ha pubblicato Essere montagna, edito da Bao Publishing, (vedi Virginia Tonfoni su Alias del 22 aprile) in cui racconta di un essere formica mini, che esce dal villaggio per andare alla ricerca di un antidoto contro l’epidemia, in compagnia di un piccolissimo animale domestico. Un racconto distopico legato all’ambiente, all’interno del quale il futuro si presenta sempre più minaccioso. Il regno vegetale è identificato con il silenzio, che è un silenzio inafferrabile perché la natura è inquieta e inquietante a causa dei tanti abusi dell’uomo.
La montagna come luogo di incontro e di conflitto intergenerazionale è ben descritto nel libro di Paolo Cognetti Le otto montagne dal quale è stato tratto l’omonimo film dei registi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch circolato proprio nei mesi invernali di un anno in cui con maggiore evidenza, rispetto agli inverni precedenti, la neve non è caduta e le catene montuose si sono presentate in tutta la loro desolazione, vittime dei cambiamenti climatici.
A rinforzare il filone montagna, seppur da altri versanti, è il romanzo di Alberto Rollo Il grande cielo. Educazione sentimentale di un escursionista (Ponte alle Grazie) nelle cui pagine iniziali a proposito del rapporto intergenerazionale, parla del padre che lo portava in montagna in moto dalla cui sella non si poteva scendere per incamminarsi lungo i sentieri che si inoltravano nei boschi. Alle richieste di un bambino che con la sua fantasia immaginava di andare oltre le montagne, la risposta del padre era sempre la stessa «non ora ma dopo», oppure «occorrono gli scarponi adatti» che non comprava mai al figlio. Ecco quanto si legge nel libro di Alberto Rollo: «Forse mi sarebbe piaciuta una figura che camminasse davanti a me e che quella figura fosse lui. Ma per ragioni che fatico a chiarire non lo fece mai. La « sua» montagna restò quella indicata da lontano, non ebbi scarponi, non cercammo percorsi insieme». Quel bambino, che vedeva le montagne dalle case di via Mac Mahon, un quartiere operaio di Milano, le cui finestre guardavano la Grigna meridionale che si ergeva maestosa alle spalle di Como e Lecco, seppur amorevolmente portato in moto dal padre fino alle pendici delle Alpi, dovrà rinunciare al sogno della condivisione delle escursioni e a quei dialoghi tra padre e figlio che solo il silenzio della montagna fa transitare dal non detto del quotidiano al parlato.
Nella seconda metà del ‘900 in tanti hanno scritto della montagna: da Erri De Luca a Lalla Romano e ancor prima di loro nel secolo precedente, Arthur Rimbaud, gran camminatore fino alla cima del San Gottardo, diretto a Genova per imbarcarsi e salpare verso altri lidi.
Gli autori più recenti che hanno al centro delle loro opere letterarie la montagna, sembrano aver segnato un cambio di passo rispetto all’opera di Giovanni Testori Il gran teatro montano, i cui personaggi rappresentano una nuova via Crucis durante la salita al sacro monte di Varallo in provincia di Varese. I volti scavati dei protagonisti sono descritti con la profondità dell’antropologia montanara e portano in sé la complessità e la dolcezza della montagna.
Dalle opere dello scrittore Mario Rigoni-Stern fino ad Arthur Rimbaud, sembra ormai definitivamente chiusa l’avventura nel selvaggio, nella wilderness, che alimentata da un’ossessione fuori controllo voleva conquistare le cime a tutti i costi. Rimbaud sosteneva che l’avventura selvaggia è forse il vero destino dell’uomo occidentale che va in montagna, ma senza alimentare il mito, considerare la montagna un luogo mistico, sentirsi eroi omerici tra le vette. Nell’immediato Dopoguerra, fino agli anni ‘70 vi era un modo «popolare» di stare in montagna che a partire dal decennio successivo si è progressivamente perso.
La conquista dei record stabiliti per il numero degli ottomila scalati, iniziata negli anni ‘80 del secolo scorso, gli affronti alle comunità locali violate nei loro credo religiosi in nome di conquiste sportive e di tavolette di cibo concentrato da mettere sul mercato da parte degli innumerevoli sponsor, l’approccio individualistico che ha soppiantato le spedizioni collettive vecchio stile dei francesi, dei tedeschi e degli italiani, quest’ultima effettuata sul K2 nella seconda metà del ‘900, alla ricerca di un prestigioso posto al freddo, fanno meno mercato rispetto al passato dopo l’ondata di proteste delle nuove generazioni guidate da Greta Tumberg.
Siamo, ormai ben lontani dall’avventura magnetica di alpinisti e alpiniste che mettono a rischio la propria vita per arrivare in vetta, come ci hanno abituato le imprese nella sfida al Nanga Parbat di Albert Mummery, Elisabeth Revol, Simone Moro, Daniele Nardi, Nives Meroi, Reinhold Messner, che Orso Tosco ha ampiamente descritto nel bel libro Nanga Parbat. L’ossessione e la montagna nuda , ( 66thand2nd, euro 15). Lontani dalla retorica che aleggia intorno alle cime montuose, fatta di panini imbottiti, belle vedute e logica performativa, la montagna è stata in passato ed è ancora oggi formazione di uomini e donne, rappresenta una sfida positiva, perché lungo i sentieri montuosi diventiamo corpo. È quanto accaduto anche ottanta anni fa, quando la montagna divenne luogo di incontro per organizzare la lotta al fascismo. In tanti, giovani e adulti conobbero la montagna nelle sue forme più acute e nella sua dolcezza, in quegli anni in tanti divennero partigiani, profondi conoscitori della montagna fino a sconfiggere il fascismo. Molti persero la vita per la nostra libertà.