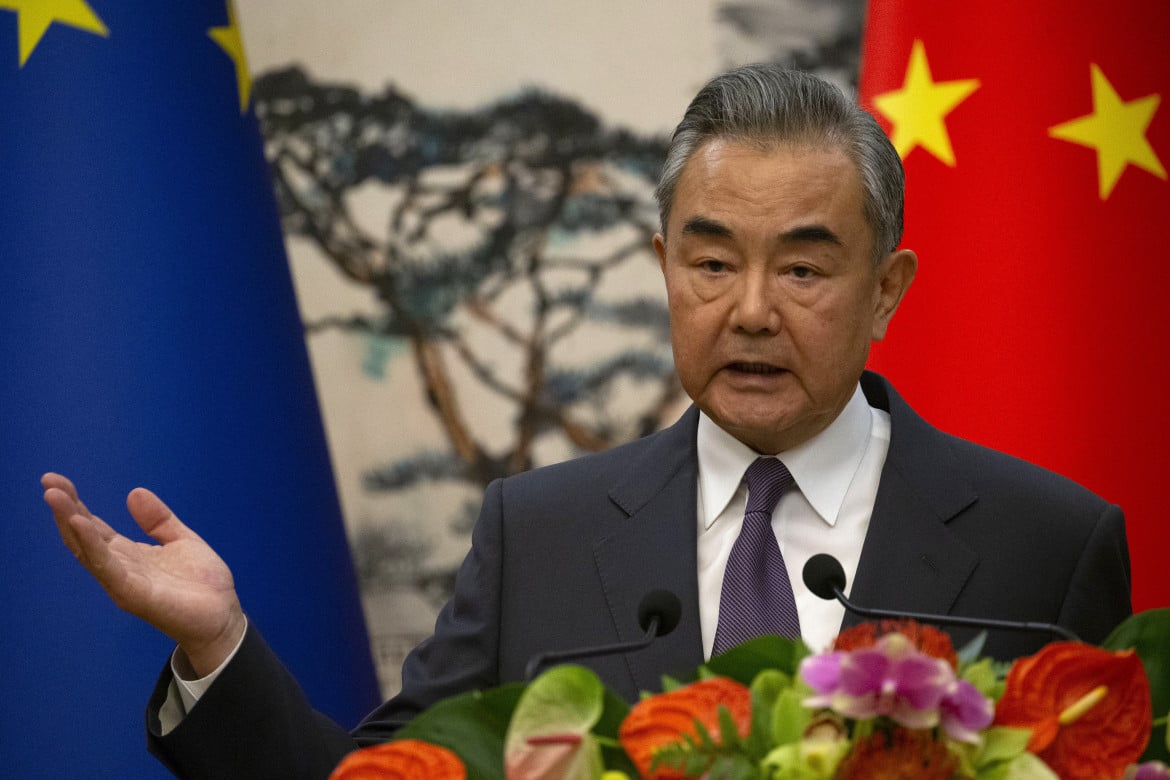«Gloria all’Ucraina», dice con ostentata naturalezza l’autista al militare di guardia. Non bastano i suoi modi affabili per farci proseguire spediti verso Mariupol. Prima dell’ingresso in città, in pieno territorio ucraino, c’è un check-point armato, con automezzi, sacchetti di sabbia e barriere di cemento, in cui controllano uno per uno i documenti e i cellulari di chi transita.
Per i giornalisti, il permesso per corrispondere dalla Joint Operational Force zone (la regione delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk) ora vale anche qui e il piantone mi ammonisce su tutto ciò che non potrò fare.
Mi chiede per chi lavoro e poi si rivolge indispettito ai miei compagni di viaggio occasionali lamentando che «i giornalisti sono tutti uguali, vengono qui per qualche ora e poi se ne vanno per il mondo a dire che siamo tutti fascisti».
LA PRIMA IMPRESSIONE di Mariupol è spettrale. Le strade sono deserte e nella nebbia i neon delle insegne appesantiscono l’atmosfera. «La nebbia è frequente», racconta Maxim, un medico di un paese vicino nell’entroterra, «dipende dal mare»; ma sui vialoni senza traffico alle dieci di sera non invita a camminare. I bar e i ristoranti chiudono presto e, in generale, manca la vitalità che abbiamo trovato in molte altre città ucraine.
Probabilmente le notizie del pomeriggio, ovvero l’evacuazione di donne e bambini dalle repubbliche separatiste, il richiamo dei riservisti e l’esplosione dell’automobile del capo della milizia di Donetsk poche decine di chilometri più a nord, hanno lasciato il segno.
«No, qui è più o meno sempre così – continua Maxim – d’altronde è una città piccola». In realtà Mariupol ha mezzo milione di abitanti ma Maxim non è il primo a qualificarla così, per gli ucraini le città sono solo Kiev, Odessa, Karkhiv, Leopoli. E Donetsk, che prima del 2014 era il capoluogo di tutta la regione circostante.
AL CENTRO DEL PARCO comunale una croce di pietra ricorda i militari caduti dal 2014 a oggi e i due vialetti che ne nascono ai lati sono delimitati dal resto della vegetazione da gigantografie dei «figli della patria» morti in combattimento, molti carristi, qualche fante, nessun marinaio al contrario di quanto mi aspettavo, tutti, comunque, molto giovani.
Le pose scelte sono quasi sempre sorridenti, molti abbracci e gesti di cameratismo, i colori a tinte calde, sono simili a quelli che si trovano in molte altre località ucraine, se non fosse che qui il confine russo è dietro il promontorio alla fine della baia e la linea del fronte è, letteralmente, a un tiro di schioppo.
Ad alcuni ragazzi che ascoltano musica su una panchina chiedo se sono preoccupati, ridono e rispondono di no. «Mio padre ha detto che, comunque, anche se dovesse esserci la guerra, i russi non ce l’hanno con noi» dichiara un po’ intimidito Oleg, meno di vent’anni e la felpa di un gruppo metal. «Certo, ci diranno per favore e grazie!», lo sfotte un amico e poi iniziano a spingersi.
In basso, verso il mare, ci sono molte baracche, tetti di lamiera e muri cadenti, qualcuna è dipinta di fresco ma il quadro generale è piuttosto desolante. Alcuni palazzoni sono stati abbandonati da tempo e mai più toccati e le strade necessiterebbero di molta manutenzione.
Così come il lungomare, che concentra tutte le attrattive per la cittadinanza in un’area attrezzata con due moli speculari che compongono quasi un ferro di cavallo.
QUI È IMPOSSIBILE parlare di guerra, qualche sorriso di circostanza e poche risposte cortesi volte più che altro a proseguire nella passeggiata senza attardarsi troppo. Eppure, quasi tutti i media riportano che Mariupol è una delle città più a rischio in quanto importante porto commerciale, snodo verso la Crimea e porta del Mare d’Azov. Guardando verso l’orizzonte viene spontaneo soffermarsi a cercare il profilo di una nave da guerra.
«Ma in questa città si stava meglio durante l’Unione Sovietica?» chiedo a una coppia sulla quarantina intenta a bere un bicchiere di liquore di ciliegia caldo, famoso in tutta l’Ucraina.
«No, ovvio che no, alla gente facevano il lavaggio del cervello, ed è quello che fa tuttora la tv in Russia. I nostalgici ci sono, per carità, ma sono più che altro vecchi, cresciuti in quel mondo e abituati a quelle cose, gente che non ha mai potuto viaggiare e che non ha avuto modo di vedere altro».
FINALMENTE IGOR mi dà una risposta più articolata: «Nel 2014 vivevo in Russia, a San Pietroburgo, e quando l’esercito russo ha occupato la Crimea ho visto scene incomprensibili, gente che festeggiava come se avessero vinto la coppa del mondo, o una guerra, anche se tecnicamente noi (ucraini, ndr) non siamo stati capaci di sparare neanche un colpo», si ferma un attimo e aggiunge, come a smentire l’affermazione precedente, «anche se oggi è molto diverso, abbiamo armi, missili, mezzi… comunque ricordo che ho pensato ‘sono tutti matti’, la Crimea era già russa, tutti lì parlavano russo, erano legati alla Russia o venivano proprio da lì, che bisogno c’era di tutta quella pagliacciata?”.
Forse troppi politici ucraini, prima che tutto si deteriorasse, hanno confuso l’europeismo con le misure anti-russe: il primo governo uscito da Majdan abolì la lingua russa. E quando gli chiedo se qui replicheranno la stessa dinamica, risponde che «dal 2014 a oggi molte cose sono cambiate, prima a chi interessava se parlavi russo o ucraino? Prima potevi dire ‘però, forse, non mi piacerebbe stare dalla parte degli Stati Uniti’, oggi no; in un certo senso Putin è diventato il nostro migliore amico, come popolo intendo, è lui che ci ha spinto a unirci sempre di più minacciandoci costantemente».