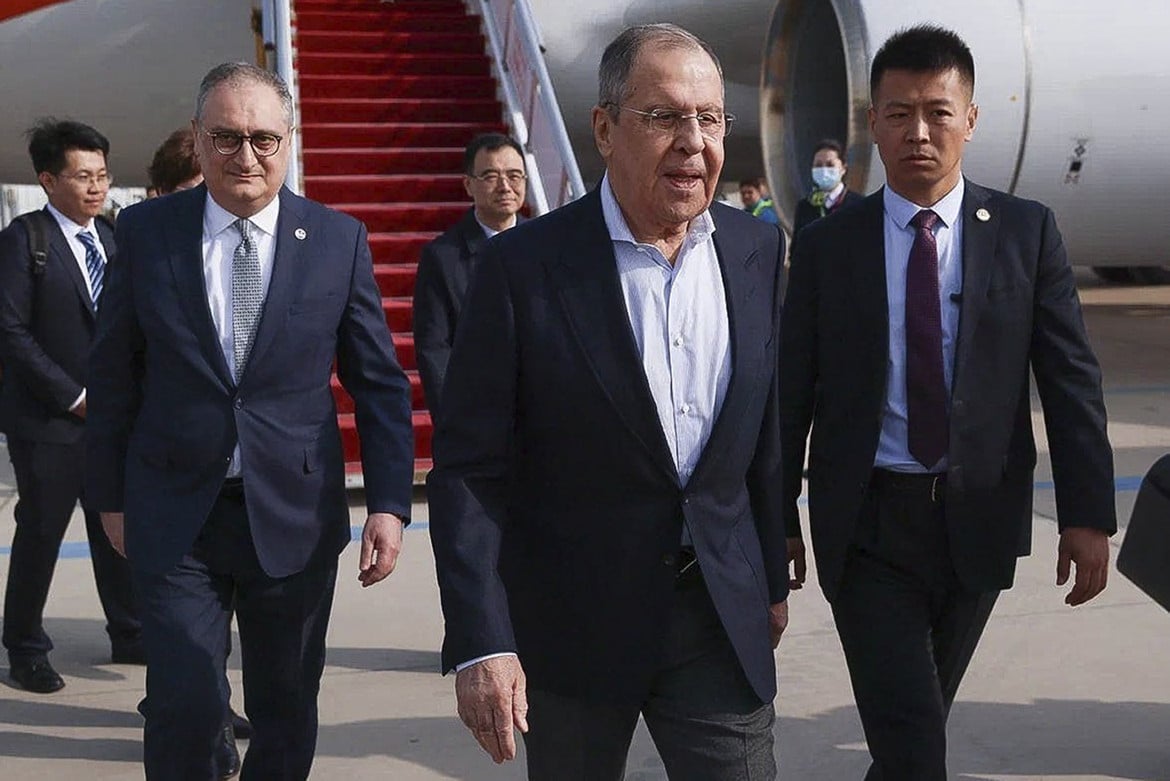Ancora tuffata nel tumulto della storia, dei fatti del suo tempo, nel giugno del 1939 Marina Cvetaeva lascia Parigi insieme al figlio Georgij e rientra a Mosca. Intende ricongiungersi al marito Sergej Efron e alla primogenita Alja. Ai guai dell’isolamento in Francia (sradicamento, indigenza, incomprensione della critica) si sostituiscono le pesanti conseguenze del rimpatrio in Urss: l’iniziale necessità dell’incognito, i continui cambi di alloggio, la diffidenza e le porte chiuse, infine l’evacuazione a Elabuga nell’agosto del 1941. Tutto il suo mondo precedente, prima lussureggiante di invenzioni sorrette da una energia spiritata, che acuiva i sensi e lasciava scorgere i legami tra le cose, cede il posto al deserto, allo scacco.
Eppure tutto riecheggia ancora – sconfitto – nei versi degli ultimi due anni, disseminati di autocitazioni (valga solo quel valet che non può non rimandare alla pièce Il Fante di Cuori, la prima del ciclo Romantika, del ’18-’19, o l’uso di rime ardue come gnëzd/zvëzd, tenute in serbo da più di un decennio, rimbalzate dall’epoca della relazione epistolare con Rilke nel 1926, dai celestiali territori del poema Novogodnee – per essere riprese adesso o mai più).
Sono componimenti ora inclusi nel volume ben curato e ben tradotto da Pina Napolitano per Voland, Ultimi versi 1938-1941 (pp. 149, € 14,00), un lavoro che restituisce la produzione lirica degli ultimi quattro anni di vita di Marina Cvetaeva. Due sono i blocchi, diseguali per mole e fattura, in cui si struttura il volumetto. Da un lato i Versi per la Boemia, scritti tra l’autunno del ’38 e la primavera del ’39, ciclo compatto – che l’autrice identificava come destinato a una pubblicazione a sé – ancora fremente delle vitalissime emozioni scaturite a ridosso dell’esperienza storica toccata in sorte all’amata Boemia: l’annessione della regione dei Sudeti prima e l’occupazione del paese poi da parte delle truppe della Germania hitleriana, eventi che si riverberano nei versi di Settembre e di Marzo, intrisi di furore e tenerezza per la patria d’elezione oltraggiata.
Dall’altro la manciata di liriche del ’40-’41 (precedute da tre poesie risalenti alla primavera del ’38) in cui di fatto si esaurisce pressoché completamente l’opus che precede la fine: uno scarno nucleo di versi mai tradotti prima – con l’eccezione di Douce France, del 1939, per mano di Remo Faccani – sfrangiati in tronconi disarticolati, percorsi dal cupo conto alla rovescia che incalza i giorni e le ore.
Il corpo delle liriche dedicate alla Boemia, già antologizzate da Pietro Zveteremich (in numero di tredici), cui si sono aggiunte neppure un lustro fa ancora due poesie, incluse da Caterina Graziadei nella sua ritraduzione del ciclo, è completato in questa sede dagli ulteriori tre componimenti: è un momento creativo cospicuo, un’ultima accensione incandescente di sdegno prima di precipitare in una voragine di buio e vuoto afasico.
Fa male vedere in che modo disperato, rarefatto al limite del mutismo, vengano al pettine tanti dei nodi che avevano angustiato il tormentato passaggio di Cvetaeva sulla terra. Dai presagi funesti non è più attraversata ma stordita, tanto a frotte si presentano: lo ha scritto, nelle lettere e nei versi, confidato a voce, dichiarato in pubblico.
Il tema del congedo definitivo, con cui flirta dall’età di diciassette anni, dai tempi di Album serale, si tinge di ineluttabile realtà. Si ribalta in una quanto mai vana evocazione della vita, che non per nulla diventa una delle parole chiave capaci di trascinarsi da una stanza all’altra dell’ormai sguarnito carniere. Come nella lirica Continuo a ripetere il primo verso, variazione sullo stesso tema toccato poco prima da Arsenij Tarkovskij (la sua poesia si intitolava La tavola preparata per sei). In questo componimento, forse il più costruito e sentito della seconda sezione della raccolta, Cvetaeva si rammarica di essere stata dimenticata perfino al convito di parvenze evocate dal trentenne poeta da cui è affascinata.
Ogni cosa giunge qui a compimento, anzitempo ma secondo un’accelerazione in qualche modo agognata: l’avversione per la modernità (sancita in modo perentorio nell’Ode all’andare a piedi, del 1933) diventa tuffo all’indietro al tempo degli zar. L’estraneazione si fa prigione, l’unilateralità degli slanci amorosi – estrema disfatta: novella Psiche, Marina contempla qui l’oggetto dormiente della sua infatuazione, il critico Evgenij Tager, ma la vecchiaia che incombe genera in lei sconcerto (eppure ha solo 48 anni), e la partenza del giovane si traduce in capitolazione («Era pane per me,/ era neve./ Nera la neve,/ inviso il pane»).
Il tema del mancato riconoscimento della sua grandezza come poeta si priva ormai anche della proiezione nel risarcimento futuro, e genera un manipolo di versi che palesano la resa assoluta, qualcosa che sempre più da vicino incenerisce l’anima («Nulla dunque mi è stato dato/ per la festa da me donata./ Così il melo – fino all’ultimo/ regala via i suoi fiori a maggio!»). Nell’estremo congedo anche dalle sue stesse poesie, ultimo anello di quel dialogo iniziato nel 1913 (ricordiamo Ai miei versi, scritti così presto/ che nemmeno sapevo d’esser poeta), la dizione si sgrana non più ad arte ma giocoforza, le elisioni non sono scelte ma rinunce, mentre a tutti gli altri spettri consueti che la visitano si aggiunge quello della reclusione, un’eventualità difficile da ignorare, nella Russia in cui ha fatto ritorno.
Questi filari di versi smozzicati, sfuggiti all’afasia, attestano un orizzonte interiore fattosi opaco, non più cangiante come quell’ambra che – unico, austero vezzo sopravvissuto a mille vicissitudini – lei sente ormai di dover dismettere. Senza più appigli nel mondo delle cose, eccezion fatta per il gancio con cui pone fine alla sua vita.