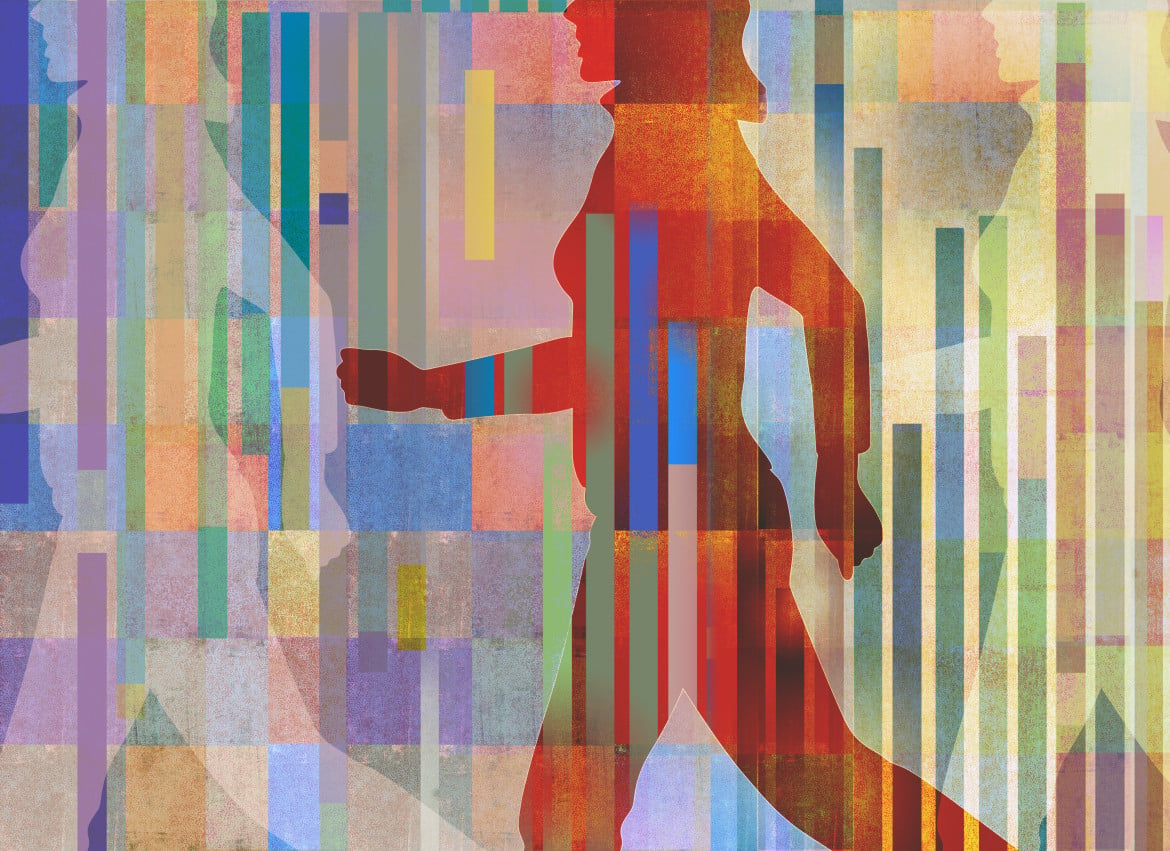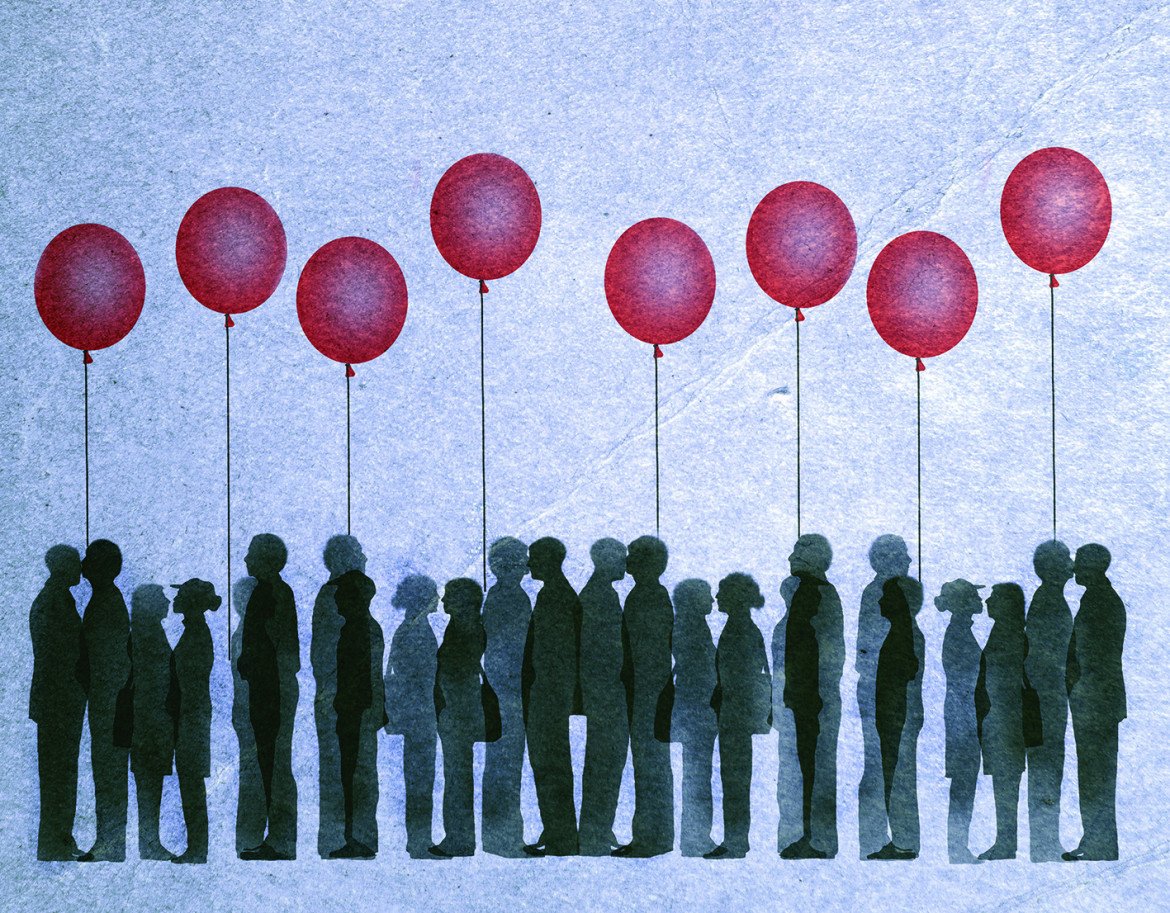Tra le idee, o parole-talismano, da cui è cosa buona e giusta prendere congedo, ce ne sono alcune diventate patetiche («diritti», «popolo», «rifondazione», per esempio), che meritano il sorriso riservato a vecchie cose di pessimo gusto, bottino dei rigattieri e del Pd. Ma ce ne sono altre, di parole-talismano, tenaci come gramigna, boriose e petulanti, in grado di intralciare a lungo la ripresa della lotta di classe in seno a un capitalismo che ha spazzato via le officine di Ford e Taylor. In questo secondo gruppo di concetti, non soltanto vacui ma anche nocivi, spicca quello di «sinistra».
Eredità della rivoluzione francese, la nozione di sinistra si attaglia alla plebe, non al lavoro salariato; riguarda gli esclusi e i reietti, non gli operai di fabbrica. Lo schieramento politico, ma anche e soprattutto sentimentale, chiamato «sinistra» si è battuto sempre di nuovo per lo «sviluppo delle forze produttive», ignorando con animo sereno la guerra civile latente che cova all’interno di tale sviluppo (basti pensare al mors tua vita mea a proposito di straordinari e ritmi lavorativi). Ha invocato, la cultura di sinistra, l’«unità nazionale» e il rispetto delle prerogative dello Stato sovrano, anche se quell’unità non ha escluso un voto a favore della guerra mondiale (voto accordato nel 1914 da tutte le socialdemocrazie europee) e questo rispetto può implicare l’assenso a leggi speciali e carceri di massima sicurezza (come accadde negli anni del «compromesso storico»).
LA NECESSITÀ di abbandonare senza esitazioni il territorio desolato segnato sulle mappe con il nome di sinistra si avverte gettando l’occhio agli anni Settanta del secolo scorso. Furono gli anni in cui ebbe luogo il primo e unico tentativo di rivoluzione comunista in seno al capitalismo maturo. Nessuna traccia di lotta all’arretratezza; nessuna «questione contadina» da dirimere contrastando la fame e la pellagra; rapido abbandono dell’amore stucchevole per gli ultimi e gli emarginati, così caro ai primi e ai ben inseriti (tutti di sinistra, of course). Il catalogo fu questo: rallentare i ritmi di produzione, ridurre al deliquio chi si arrogava il diritto di stabilirli, falciare gli straordinari, strappare aumenti uguali per tutti sulla paga base, mettere nell’angolo le direzioni aziendali, discernere in tutte le articolazioni della vita associata (scuola, trasporti, apparati comunicativi, organizzazione dei luoghi di residenza ecc.) due interessi contrapposti, tra i quali un compromesso è probabile quanto la conversione dei passeri alla castità. Nessuna voce di questo catalogo gode di simpatia presso il progressismo infatuato dei diritti civili; tutte, anzi, suscitano la sua ripugnanza.
Mal visto dalla sinistra fu, allora, lo scortesissimo potere operaio affermatosi all’interno delle officine e poi anche nella sfera pubblica metropolitana. Mentre i riformatori contagiati da Pasolini esecravano i «bisogni indotti» dalla società dei consumi in popolani fin lì votati a una ammirevole sobrietà, gli operai di fabbrica, desiderosi di consumare in fretta i beni di questo mondo, fecero il possibile (un possibile reso tale, cioè possibile, soltanto dal fatto di essere spesso illegale) per scrollarsi di dosso quell’orrido bisogno indotto che è il lavoro salariato. Per niente di sinistra, il desiderio di godere fino in fondo il proprio qui e il proprio ora rimandava semmai a un ragionevole significato della paroletta «comunismo».
L’ESODO da quel luogo insalubre in cui si officia il culto del progresso, cominciato nel corso degli anni Settanta grazie al tentativo di rivoluzione comunista che allora andò in scena, è ormai un fatto compiuto, una realtà empirica in alto rilievo nonostante il clamoroso fallimento di quella rivoluzione. La moltitudine che produce con il linguaggio e con brandelli di sapere, per la quale non sussiste un confine attendibile tra tempo di lavoro e tempo della vita, ha metabolizzato una rottura irreversibile con la sinistra, con la sua claudicante dottrina e la sua prassi benefica quanto un gas urticante. Nulla ha da spartire con l’adorazione dello Stato, l’esaltazione della piena occupazione, l’idea di cittadinanza che il progressismo riformatore ha sfoggiato a mo’ di carta di identità lungo un intero secolo.
TRE mi sembrano i principi costituzionali che potrebbero ispirare, oggi più che mai, una prassi politica lontana dalla sinistra, ma senz’altro comunista (comunisti, quindi non di sinistra: ecco una inconfutabile inferenza, da tenere sempre a mente). Il primo principio è la piena attualità dell’abolizione del lavoro salariato. Scrive Marx che esso non va liberato, dato che in tutti i paesi moderni è già libero, ma soppresso come una disgrazia intollerabile. Oltre a costituire fin dal principio una calamità, negli ultimi decenni il lavoro salariato è diventato anche un costo sociale eccessivo. Vi è qualcosa di superfluo, anzi di parassitario, nella prestazione sotto padrone allorché il pensiero e il linguaggio mostrano di essere la pubblica risorsa, ossia il bene comune, che più concorre a soddisfare bisogni e desideri. Per chi fosse a rota di frasette marxiane: vi è qualcosa di parassitario nel lavoro salariato allorché il processo di riproduzione della vita è affidato al general intellect, all’intelletto generale di una moltitudine.
Il secondo principio costituzionale che sancisce il definitivo congedo dai difensori dei diritti di cittadinanza è la distruzione della sovranità statale. A patto di adottare per un momento almeno la definizione che di quest’ultima ha proposto un giurista nazista, vezzeggiato senza ritegno dai filosofi di sinistra negli ultimi trent’anni. Secondo Carl Schmitt, la sovranità statale consiste per intero nel «monopolio della decisione politica». Ebbene, evadono dalla gabbietta del riformismo progressista coloro che, lungi dal progettare il suo trasferimento a un diverso soggetto sociale, intendono minare ed estinguere un monopolio siffatto. Rifuggendo la «presa del potere», l’antimonopolismo dei giovanissimi e dei declinanti che detestano il socialismo perché comunisti si avvale di ogni genere di tattiche: oculati compromessi e invenzione di istituzioni autorevoli proprio perché illegali, secessione e partecipazione. La parola-chiave cui ricorrere dopo l’epoca del riformismo statale, cioè l’esodo, indica innanzitutto l’insieme assai variegato di decisioni politiche che consentono di lasciarsi alle spalle l’Egitto in cui vige il monopolio della decisione politica.
Il terzo principio di una politica non più di sinistra è la meticolosa valorizzazione di tutto ciò che di unico e irripetibile è racchiuso nell’esistenza di ogni membro della nostra specie. Si potrebbe dire che si assapora, nell’epoca nostra, la possibilità di un individualismo finalmente non caricaturale. Di un individualismo, dunque, in cui la singolarità del singolo sia il risultato complesso della relazione con quanto è massimamente comune, condiviso, impersonale. Il pronome «io» discende dal famigerato e però degnissimo «si» (si parla, si gioca, si ama ecc.). A questa discendenza ha alluso Marx con il sintagma «individuo sociale». È la trama collettiva dell’esperienza («sociale») a far balenare infine una incomparabile variazione («individuo»).
Questi principi costituzionali, lungi dall’indicare un malinconico sol dell’avvenire, sono parte della nostra esperienza immediata. Definiscono il luogo della possibile lotta anticapitalista, lo circoscrivono e lo arredano, sottraendolo con pacata risolutezza a quella storia di un pazzo narrata da un ubriaco che è diventata negli ultimi anni la sinistra politica e culturale.