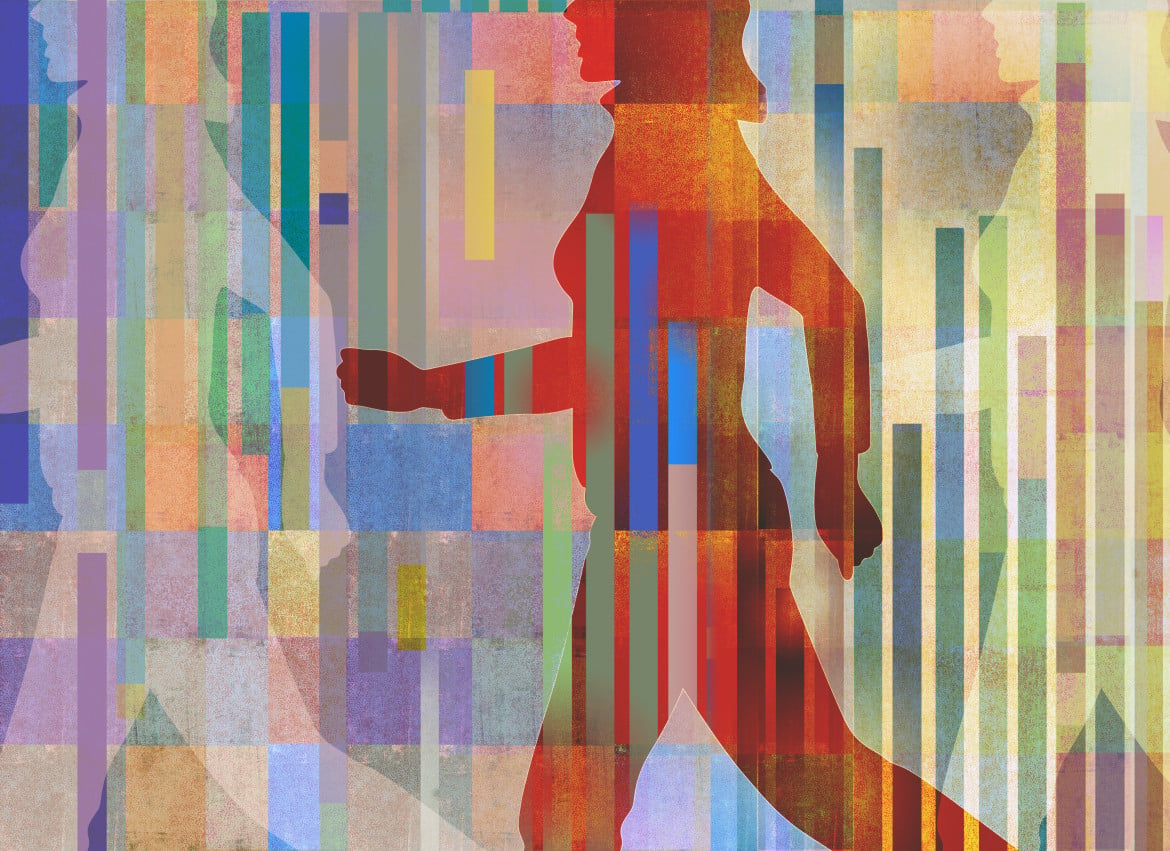Pubblicato 8 mesi faEdizione del 29 dicembre 2023
Giorgio Agamben in un testo di circa trent’anni fa uscito su Libération sosteneva che, se da un lato popolo significa classi subalterne, dall’altro il suo significato confina e spesso coincide con la comunità di razza, di sangue, sempre pronta a sterminare chi rischia di intorbidirla. Il termine popolo indica quindi «tanto il soggetto politico costitutivo quanto la classe che, di fatto se non di diritto, è esclusa dalla politica». È «un concetto polare», «una complessa relazione fra due estremi». Nei modi di acquisizione della cittadinanza e nazionalità – moderni correlati del popolo – restano le tracce del sangue (ius sanguinis)...