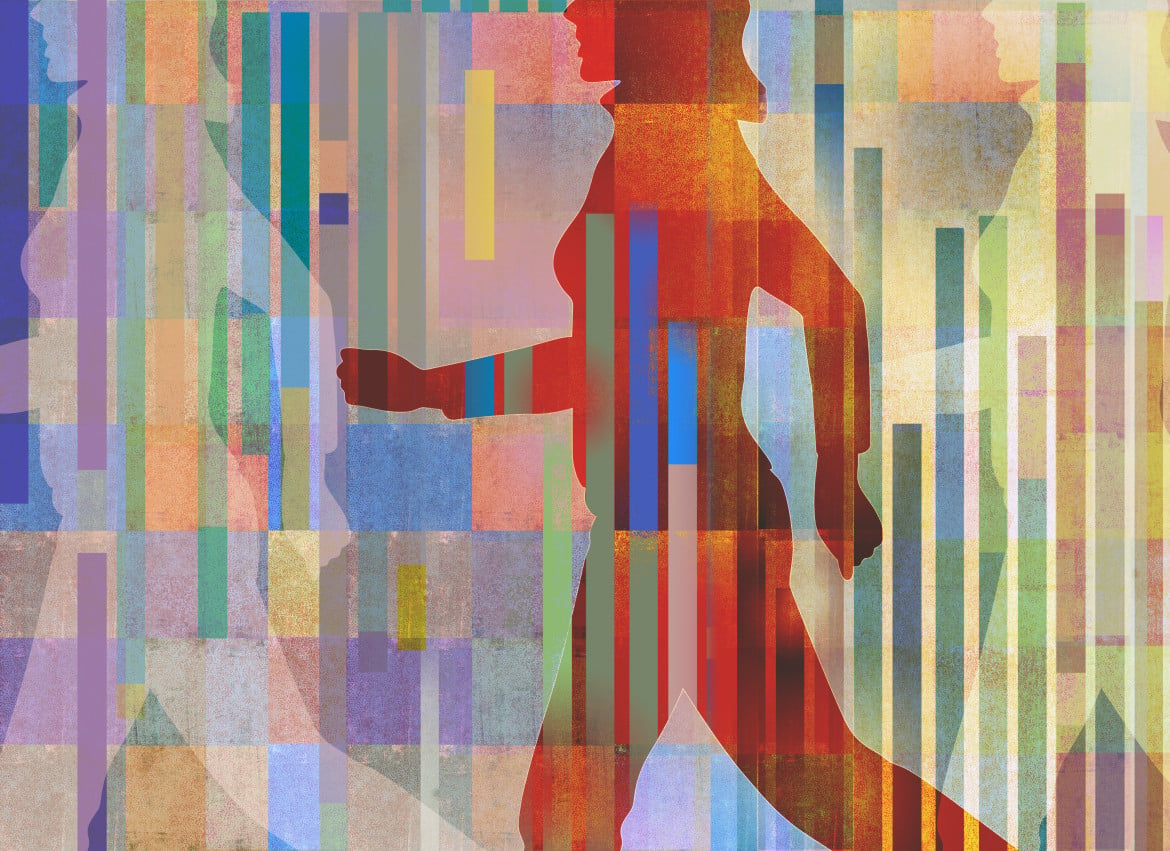Pubblicato 8 mesi faEdizione del 29 dicembre 2023
Chi ha bisogno delle differenze? La domanda può sembrare retorica, ebbene non lo è. È che le differenze sono troppo preziose per sprecarle in sinonimi di bassa qualità. «Differenze» non si equivale a diversità, non corrispondono a un dissenso, né a un disaccordo. «Differenza» significa divaricazione, divisione. Che prosegue virtualmente all’infinito, finendo a volte in dispersione e frammentazione. Non è forse questa la storia della sinistra fin dalle sue prime battute? Non ha portato a molto altro che alla sconfitta, fino ad arrivare alla scomparsa e alla confusione con l’avversario, con la destra. «Non ci sono più differenze fra destra...