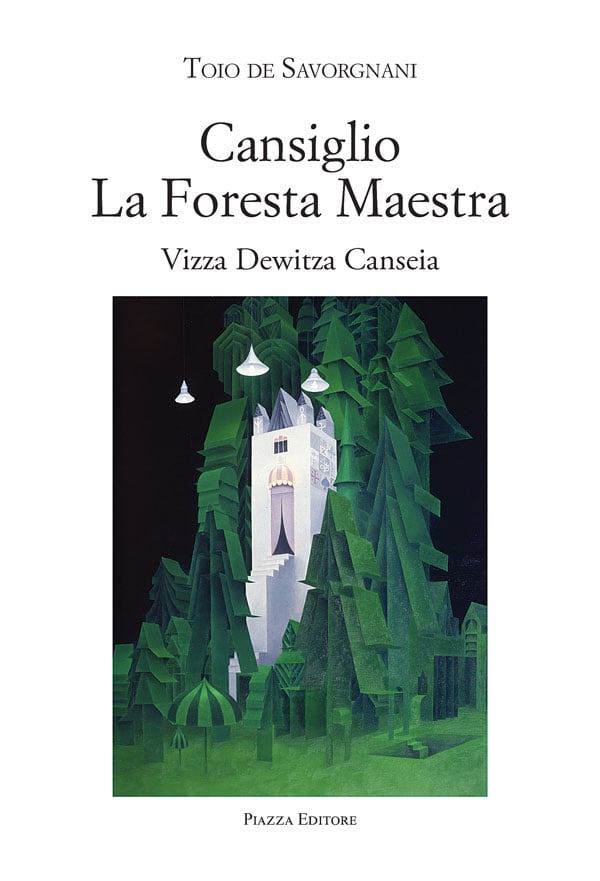Il 31 luglio scorso Gianluca Zambrotta (ex terzino della nazionale di calcio) e Filippo Facci (giornalista) hanno raggiunto la cima del Monte Bianco dalla via normale italiana. Forse per la prima volta volta nella storia un’impresa alpinistica (il termine va inteso in relazione all’esperienza specifica dei protagonisti) non è stata sbandierata e nemmeno comunicata ad amici e parenti. Per contratto.
Stiamo parlando dell’adventure-game «Monte Bianco», confezionato da Magnolia per la Rai e andato in onda in prima serata per 5 puntate dal 9 novembre al 7 dicembre. Riprese obbligate nella bella stagione e messa in onda in periodo di audience elevato.

Montagna usata e usata male, è stato sentenziato dai detrattori del programma, ancora prima che andasse in onda. Spettacolarizzazione eccessiva e, soprattutto, il cronometro a fare da padrone in tutte le prove.
Ma se facciamo un salto indietro nel tempo di un paio di secoli abbondanti, scopriamo che verso la fine del Settecento la nascita dell’alpinismo, che si fa coincidere con la prima salita del Monte Bianco nel 1786, fu sì dovuta a sete di esplorazione e scoperta, ma scatenò da subito rivalità e competizione. Con razionalismo e illuminismo le montagne vennero spogliate di tutte quelle antiche credenze che le facevano dimora di mostri e demoni per ricoprire un semplice ruolo geografico e paesaggistico.
Restarono però a lungo ostacoli da evitare, da aggirare, e salire le cime era considerata attività inutile e priva di senso. Ci volle la sensibilità romantica per spingere i primi scienziati-alpinisti a cercare risposte fin sulle cime. La montagna cominciò a essere usata e non solo temuta o contemplata. Usata per proprio diletto, per autorealizzazione, per affermazione sociale.
Emblematica fu la conquista del Cervino nel 1865, un’impresa alpinistica in qualche modo estranea ai canoni dell’epoca. Un’impresa strana per il reclutamento (casting?) dei partecipanti, per la competizione diretta, per il seguito mediatico, per le polemiche. Forse il primo «adventure game» della storia dell’alpinismo. Un gioco però tragico. Le cordate del valdostano Jean-Antoine Carrel e dell’inglese Edward Whymper si affrontarono su versanti opposti, con l’intento di raggiungere per primi la vetta. Nonostante fossero partiti quasi due giorni dopo, Whymper e i suoi vinsero la sfida, salendo da quella che è oggi la normale svizzera. Quando Carrel se ne accorse, deluso, tornò indietro. La cordata di Whymper affrontò la discesa forse troppo euforica, forse stanca per la salita troppo veloce. Uno di loro scivolò e trascinò nel baratro altri tre dei sette componenti. Si salvarono Whymper e i due Taugwalder (padre e figlio), grazie alla corda che si spezzò per l’attrito sulla roccia, come dovette provare lo stesso Whymper accusato di averla tagliata. Un evento che fu vissuto in diretta, da Zermatt e da Valtournenche, e non solo.
Era il 14 luglio, esattamente 150 anni prima che Zambrotta arrivasse «per primo» sul Monte Bianco, anche lui accompagnato dalle guide valdostane, anche lui col fiato corto, anche lui spinto da quell’inversione della forza di gravità che si accende nella testa e nelle gambe degli alpinisti.
Monte Bianco è stato un tentativo di portare l’avventura dell’alpinismo nelle case di quegli italiani poco avvezzi all’alta quota, prigionieri dello stereotipo mediatico della «montagna assassina», l’unica che fa parlare di sé in televisione e sui giornali.
Un tentativo di parlare di montagna in un modo diverso, come lo fu, per tornare ai tempi di Whymper, il diorama di Albert Smith, che a metà Ottocento, con duemila repliche, portò nei teatri inglesi lo spettacolo visivo, e non solo, proprio del Monte Bianco.
Il nuovo format televisivo è una mediazione, è vero, un compromesso, si è costruito qualcosa che fosse montano ma anche mondano, in parte una finzione scenica.
Ma anche di ciò ci sono famosi e riusciti esempi nel passato, come le avventure di Tartarino sulle Alpi, di Alphonse Daudet, dove il protagonista vive la montagna come fosse artificiale, costruita appositamente per i turisti. Un Truman Show al contrario. Monte Bianco pare attingere da entrambi: concorrenti immersi in una realtà in parte edulcorata e percepita sicura grazie alle guide alpine e nello stesso tempo talmente coinvolti dallo sforzo fisico e psichico da dimenticarsi di essere in televisione.
Per certi versi è un esperimento riuscito: professionalità delle guide, immagini spettacolari girate da grandi cameramen-alpinisti, coordinamento e regia di altissima qualità, un montaggio all’altezza (in tutti i sensi). Tuttavia i risultati in termini di audience non sono stati dei migliori: share dal 6% al 4%, in calando, che in quella fascia oraria significa poco più di un milione di spettatori.

Cosa viene criticato? Perché questa sensazione di montagna usata e banalizzata?
Difficile sostenere la tesi che la velocità e il cronometro non abbiano a che fare con l’alpinismo. Lo dimostra prima di tutto la vicenda del Cervino. Lo dimostrano le gare di corsa in montagna o di scialpinismo, sempre più seguite e partecipate. Lo dimostra Ueli Steck, il più forte alpinista del momento, unanimemente osannato, capace nel 2013 di salire e scendere in solitaria una nuova via sulla parete Sud dell’Annapurna in 28 ore, o di scalare un mese fa la Nord dell’Eiger in 2 ore e 22 minuti. La velocità in alpinismo è spesso sinonimo di sicurezza, perché riduce l’esposizione ai pericoli oggettivi, ai cambiamenti del tempo. A patto di potersela permettere, sia fisicamente che tecnicamente.
Ecco, i concorrenti di Monte Bianco probabilmente quella velocità non se la potevano permettere. Li si è visti spesso trascinati dalle guide, dalla corda, specialmente nelle arrampicate su roccia. Una sensazione di didattica e apprendimento indispensabili che vanno a farsi benedire a favore di un dubbio spettacolo. La stessa velocità era poi controllata più dalle guide che dai concorrenti, come nelle calate, dove lo scorrere della corda lo regola chi manovra, e dovrebbe farlo lentamente, per non surriscaldare la catena di sicurezza, per evitare che si vada più veloci del pensiero e della capacità di valutazione. Velocità che gioca anche brutti scherzi, visto che una delle guide ha sbagliato linea di discesa da una cima e ha dovuto essere assistita dai colleghi.
Infine, la velocità in alpinismo non è mai un valore assoluto ed è difficile confrontare e far competere due cordate quando una si muove un componente alla volta, in totale sicurezza, e l’altra viaggia «in conserva».
La sensazione di distacco dalla montagna reale è stata probabilmente amplificata dall’assenza quasi totale, salvo l’ultima puntata, della parte sociale dell’avventura, delle confidenze in tenda, dei racconti delle guide alpine condivisi nei momenti di relax.
Il racconto in prima persona tiene insieme l’alpinismo, da sempre, è la memoria storica di uno sport che non è uno sport e che comunque non ha testimoni, se non gli stessi attori. A Monte Bianco invece avveniva tutto «in diretta», tutti testimoni di tutto.
Ma quello che più ha fatto insorgere i puristi della montagna è stato sicuramente il piegare le dinamiche dell’alpinismo a un format ludico, uno «Giochi senza Frontiere» d’alta quota, con moschettoni da raccogliere e ramponi da cercare sotto la neve. Un’arma a doppio taglio per gli stessi autori, perché ad esempio i criteri dei premi e delle penalizzazioni hanno funzionato male. Si sono percepite dinamiche autoriali che certamente hanno dovuto accontentare, all’interno della produzione, spiriti, professionalità e ruoli diversi. In primis la spaccatura tra chi la montagna la conosce e la frequenta e quelli che la «maneggiavano» per la prima volta. Spaccatura che però, di nuovo, fa parte del mondo dell’alpinismo, di come viene raccontato, e che sicuramente si è riprodotta nel pubblico televisivo.
E se vogliamo tornare al concetto di montagna usata, senza scadere nella retorica dell’Alpe, quello che non è piaciuto a chi per i monti vive una vera e propria passione è stato forse il voler adattare in qualche modo la montagna agli uomini e non viceversa.
Viviamo ormai per il 90% in un universo controllato da noi stessi, dove spostando una leva succede qualcosa, dove a ogni azione corrisponde una reazione.
La montagna e gli spazi selvaggi in genere fanno da contrappunto, ne sono testimonianza, ci aiutano a rendercene conto. Non reagiscono alle nostre azioni, ci obbligano ad adattarci, a semplificare, a renderci simbiotici, a trovare il miglior modo per fare quella cosa in quel momento, per il nostro piacere o per la sopravvivenza. Invadere quel mondo e quel modo è controproducente e pericoloso.
La cementificazione, la costruzione di nuovi impianti di sci, le nuove strade, l’acqua rubata ai torrenti di montagna sono un capitolo a sé. Ma sono in parte la conseguenza di una sorta di colonizzazione culturale: il voler portare la città in montagna, le dinamiche della civiltà, qualunque essa sia, trasportate nei luoghi della libertà assoluta.
Le trasmissioni televisive per fortuna non colonizzano nessuno, non lasciano tracce materiali, bisogna dargliene atto.
Per tutti, anzi, lasciano la grande libertà di guardarle o di cambiare canale.