Lo spaesaemento salutare dell’orizzonte etnoclinico
Chi è l’altro? Se guardiamo il mondo con gli occhi di chi, da uno studio televisivo, ben vestito e rilassato, commenta gli arrivi via mare in Italia dalle sponde meridionali del Mediterraneo, l’altro è un povero, una minaccia, un indesiderato, al massimo un oggetto di compassione. Se cambiamo prospettiva e, dunque, punto di vista, tutto cambia. Questo mutamento radicale può avvenire in diversi modi: ad esempio, nell’esperienza di una lotta fatta insieme, nel divenire amici, nei percorsi di cura.
È in questo ultimo ambito di vita che il libro Esperienze di cura in migrazione, forme dell’invisibile e narrazioni possibili: l’orizzonte etnoclinico (ombre corte, pp. 200, euro 17), curato da Rita Finco, responsabile del centro di formazione, ricerca e mediazione (Fo.R.Me.) della Cooperativa Ruah di Bergamo, si concentra. E lo fa presentando i contenuti e le pratiche dell’etnoclinica, il cui obiettivo, come chiarisce la curatrice nel primo capitolo, è quello di «avvicinarsi ai differenti saperi disciplinari per creare sentieri in grado di (dis)orientare quelle pratiche oppressive, autoritarie e violente ancora presenti nei contesti istituzionali».
L’ETNOCLINICA va oltre l’etnopsichiatria, da cui deriva, cercando di attraversare le logiche istituzionali e culturali di chi si rivolge ai servizi di cura e di chi vi lavora, affermando la simmetria tra queste due figure, sapendo che viviamo un’epoca storica di violenza diffusa, in cui l’equilibrio psichico è sempre più difficile da costruire e, pertanto, sono necessari strumenti capaci di confrontarsi con un mondo in movimento. Per questo, l’etnoclinica invita a spostare completamente lo sguardo verso l’altro, accettando che questo impegno richieda passione per lo scambio e la scoperta e la disponibilità verso la meraviglia, l’apertura e la curiosità: uno sguardo non predeterminato.
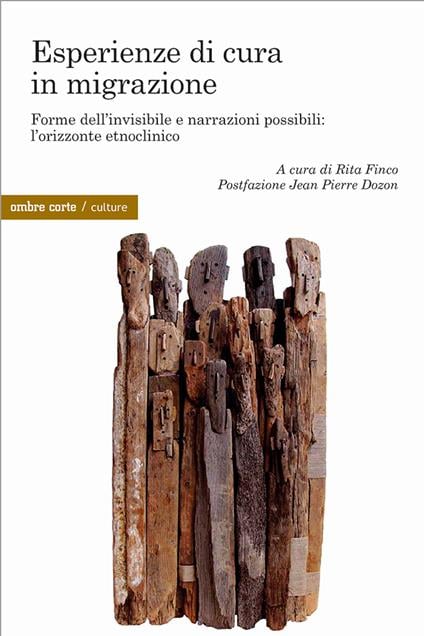
L’etnoclinica, al contrario, si posiziona proprio nell’indeterminazione, nel fatto che niente è predefinito, tanto meno i mondi visibili e invisibili delle persone che si incontrano. Di conseguenza, «in etnoclinica, il disagio non viene mai racchiuso in una classificazione, e nemmeno viene identificata la sofferenza all’interno di un quadro psicopatologico», perché questo approccio vuole lavorare con le matrici culturali del malessere. Seguendo questo orientamento, che dà centralità alle esperienze culturali – dunque. storiche e di potere – dei percorsi di vita, gli operatori dell’etnoclinica hanno compreso che questa metodologia può applicarsi in qualunque relazione di accompagnamento e non limitarsi ai rapporti di cura con le persone immigrate.
CHIARAMENTE, l’innovazione e la necessaria sperimentazione richieste dall’etnoclinica non sono possibili, o lo sono con grande difficoltà, in un contesto di servizi pubblici sempre più impoverito, specialmente per quanto riguarda la cura e il benessere psichico. Il testo non si concentra su questo aspetto strutturale – non è il suo obiettivo – anche se a tratti lo richiama. Questi limiti istituzionali, che sono finanziari ma anche di visione politica, sono ancora più problematici per un approccio, come quello etnoclinico, che richiede un lavoro collettivo, non limitato al rapporto utente-terapeuta, in quanto «nessuna ferita piò rimarginarsi senza l’azione curativa del gruppo». La rimozione di questi limiti è uno dei punti da cui partire per ricostruire servizi di cura fondati su rapporti democratici.



