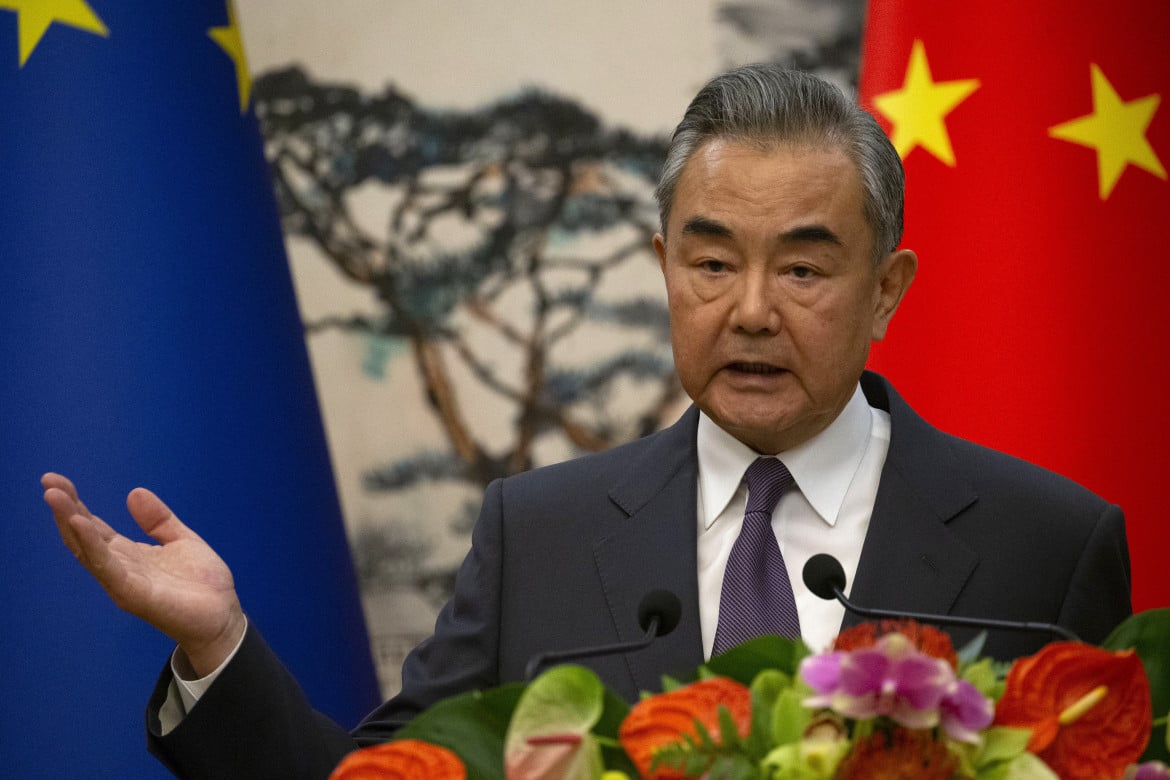«La Palisiada», l’Ucraina nei ricordi d’infanzia della mia generazione
Philip Sotnychenko è nato nel 1989 a Kyiv, negli anni Novanta in cui si svolge il suo primo lungometraggio, La Palisiada, era appena un bambino: «Mi piaceva l’idea di lavorare nel tempo di una memoria infantile che appare sfumata e insieme molto netta, alla quale si sono poi unite le mie esperienze di oggi» spiega.
Siamo nel 1996, l’Ucraina ha dichiarato la propria indipendenza dall’Unione sovietica pochi anni prima ma in questo post-sovietico il passato brucia continuando a condizionare la vita quotidiana. A distanza di molti anni un ex-poliziotto e uno psichiatra forense, indagano sulla morte di un loro amico avvenuta prpprio allora, cinque mesi prima della moratoria che cancellò la pena di morte.
Oggi questa storia che Sotnychenko ha cominciato a immaginare cinque anni fa assume una diversa prospettiva: «Me ne sono accorto sin dalla prima proiezione, al festival di Rotterdam, lo scorso gennaio . Il pubblico vede nel film il riflesso dell’invasione russa, e invece quando è iniziata la guerra eravamo già in post-produzione. Però è molto interessante questo processo, mostra come ciascuno tende a interpretare le cose connettendole alla propria esperienza che oggi a livello mondiale per l’Ucraina è quella del conflitto».
Lui invece aveva in mente soprattutto una crime story esistenziale, un po’ ispirato alle sue passioni cinefile coltivate guardando i Vhs casalinghi. Il padre che lavorava nel cinema aveva comprato un videoregistratore, a ogni buon voto a scuola gli regalava un film. E la grana di una nostalgia per qualcosa di appena sfiorato attraversa l’immagine di La Palisiada girato con un formato che ripropone quello dell’epoca (sembra che la macchina il regista l’abbia comprata su e-Bay).

Perché hai scelto di tornare agli anni Novanta con una narrazione che oscilla però tra presente e passato?
Ho cambiato la struttura del film diverse volte, all’inizio era più lineare, eravamo subito negli anni Novanta e il racconto procedeva cronologicamente. Poi ho capito che partire dal contemporaneo mi permetteva di restituire poco a poco il contesto storico da cui il nostro Paese arriva, e di far comprendere meglio il background di chi si è formato in quegli anni. L’indipendenza è stato un processo difficile, mi sono reso conto che incrociare dei vissuti mi aiutava a metterne in luce i lati più oscuri. Sono partito dalla scoperta che nel 1996 in Ucraina esisteva ancora la pena di morte. Da lì ho iniziato a ricordare la mia infanzia, e il tema della pena di morte è passato un po’ in secondo piano. Più che sull’ultima esecuzione il film prova a riflettere su quel periodo, sulle persone che lo hanno vissuto, sulle diverse generazioni di padri e di figli. Ho pensato per la struttura ai film di Kiarostami, un regista che amo moltissimo, come Il sapore della ciliegia (1997), dove si procede per incastri temporali e narrativi. Mi piaceva l’idea che lo spettatore si trovasse davanti dei momenti inaspettati.
Dicevi che il pubblico tende a vedere nel film un legame con la guerra. Forse al di là delle connessioni più immediate c’è qualcosa che suggerisce una origine lontana di quanto accade ora.
La guerra non ci ha sorpresi, molti di noi lo sapevano già prima di Biden o del Pentagono che la Russia ci stava invadendo. È almeno dal 2014 che si combatte, per chi vive nella capitale la percezione è forse diversa ma chi abita nelle regioni coinvolte lo sa bene. Poi la Russia nega come ha sempre fatto su tutto. Anche per questo ho voluto lavorare sulle relazioni tra le persone, credo che è dove si concentrano maggiormente i rimossi di questi anni. Risolvere il mistero dell’indagine non è così importante, conta l’investigazione delle anime e le domande che ogni fatto accaduto pone.
Stai filmando la guerra? Raccogliendo materiali di documentazione?
In realtà no, ci sono già altri registi ucraini a filmare e senz’altro lo fanno molto meglio di me. Il mio operatore per esempio lavora a un documentario che racconta questi mesi di conflitto. Ci sono anche molti registi che hanno deciso di arruolarsi, tanti amici e colleghi sono morti al fronte in questi mesi. E non erano militari ma persone come me, come te,; però non c’è altro da fare perché non ci sono eserciti di altri paesi a aiutarci. Io preferisco combattere sul fronte culturale facendo quello che posso in ogni altro settore, e non smettere di parlare perché è importante tenere l’attenzione viva su di noi. Fare film in Ucraina adesso non è semplice, ci sono gli allarmi aerei continui, esi deve correre nei rifugi, anche a Kyiv manca spesso la luce, non si sono più soldi con cui produrre il cinema ,e per trovarli possiamo solo rivolgerci ai fondi di coproduzione. Però andiamo avanti, la guerra non ci ha fermati, penso che anche questo è un modo di resistere, rinunciare a tutto sarebbe dichiararsi sconfitti. Io sto lavorando a due progetti.
Quali?
Uno è un documentario di osservazione sui miei genitori che stanno invecchiando, sono un figlio arrivato tardi. Li sto filmando da tre anni, sono in pensione, escono poco, la guerra è una realtà che ha modificato solo il contesto della loro esistenza quotidiana. L’altro è invece un lungo con protagonista una coppia che si è sposata appena prima l’invasione russa. Lo scrivo insieme a Zhanna Ozima, il titolo per ora è Honeymoon. Non voglio parlare direttamente della guerra, non mi piace l’idea che in quanto regista di un Paese in guerra sono obbligato a confrontarmi soltanto con questo.