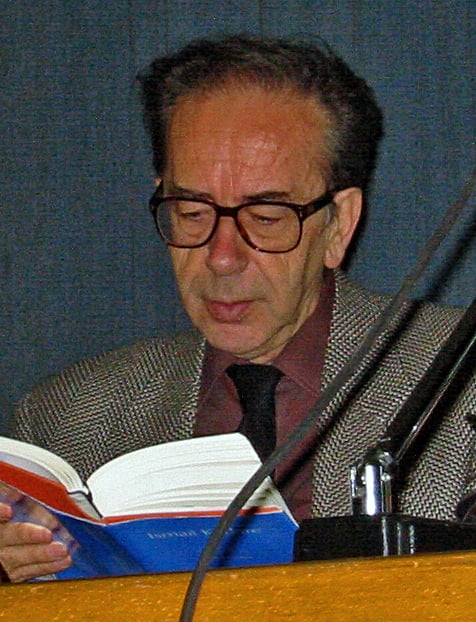È un’afosa giornata di giugno quando a Skopje arriva la notizia del via libera anche del Bundestag all’adesione della Macedonia del nord alla Nato. Rinviato a settembre invece il voto sull’avvio dei negoziati di adesione con l’Ue. Una doccia gelata per il piccolo Stato balcanico che dall’anno scorso ha avviato un complesso processo per cambiare il nome, Macedonia, contestato per decenni dalla Grecia. Il veto di Atene era l’ostacolo maggiore all’ingresso del Paese nel club euro-atlantico.
Tra i titoli dei notiziari scorre anche quello sull’esercitazione «Decisive Strike» (attacco decisivo) la più grande sinora organizzata qui. Oltre 2700 militari provenienti da cinque Paesi della Nato, Stati Uniti in testa, e dalla Macedonia del nord che si appresta a essere entro la fine dell’anno il 30° membro dell’Alleanza atlantica. Ed è proprio alla base militare di Krivolak luogo dell’esercitazione congiunta, che punta Washington. L’obiettivo è trasformarla nel centro regionale delle esercitazioni Nato.
Lette insieme queste due notizie restituiscono il senso della posta in gioco del cambio del nome. Non l’Europa, ma la Nato è il vero obiettivo dell’intera operazione. E Bruxelles ha semplicemente mentito. Dall’anno scorso il fronte degli Stati membri dell’Ue contrari all’allargamento è aumentato. Non solo Francia e Olanda, ma ora anche Germania, Lussemburgo, forse Spagna si aggiungono al coro dei no all’avvio del negoziato.
C’è tensione tra le fila del governo guidato dal socialdemocratico Zoran Zaev. Il premier vola a Berlino, il neopresidente Stevo Pendarovski a Bruxelles. In discussione non c’è solo il loro futuro politico, ma soprattutto la stabilità del Paese e dell’intera regione. Il prezzo da pagare per Skopje è stato salatissimo. Un rinvio, l’ennesimo, rischia ora di far emergere tutte le contraddizioni del percorso intrapreso.
A Tetovo quelle contraddizioni sono già tutte lì, presenti e ben visibili. Si respira un’aria di diffidenza in quella che è considerata la capitale della minoranza albanese in Macedonia del nord e che al tempo stesso è stata la culla dell’irredentismo albanese nell’area durante le guerre nei Balcani; qui è nato l’Uck, quello della lotta armata in Kosovo, (l’acronimo albanese vuol dire Esercito di liberazione nazionale); e poi l’Uck-M, il braccio macedone dell’esercito di liberazione nazionale albanese. Da qui partì l’offensiva dei ribelli albanesi che nel 2001 spinse la Macedonia sull’orlo del conflitto. A Tetovo oggi albanesi e slavo-macedoni vivono ancora da separati in casa. Ognuno con le proprie chiese, la propria lingua, le proprie tradizioni. Superare quella linea rossa era l’obiettivo del premier Zaev. «Una società per tutti» è lo slogan con cui si è presentato al Paese alle elezioni politiche del 2016. In un mondo che erige muri stringendosi nell’abbraccio mortale del nazionalismo, la Macedonia del nord pareva percorrere la strada al contrario dopo anni di ubriacatura nazionalista e di ridicola grandeur.
«La tattica di Zaev, commenta Seladin Xhezairi, caporedattore di Tv Klan Macedonia, è quella classica del divide et impera. Le concessioni fatte alla minoranza albanese non sono altro che un modo per frammentarne la rappresentanza e far convergere su di sé il voto albanese. Di fatto l’Sdms sta vampirizzando il Dui (alleato di governo e braccio politico dell’Uck-M) e spaccando i partiti albanesi d’opposizione». Di concessioni Zaev ne ha fatte tante in questi anni al governo. Prima fra tutte, il riconoscimento dell’albanese come lingua ufficiale dello Stato, poi la nomina del primo albanese, Erol Musliu, alla direzione dell’intelligence macedone. In questi anni la Procura speciale istituita per fare chiarezza sullo scandalo delle intercettazioni che ha portato alla caduta del governo nazionalista di Nikola Gruevski, ha poi riaperto alcuni casi giudiziari che avevano avvelenato le relazioni inter-etniche.
In questo clima i socialdemocratici hanno bilanciato la perdita dei voti tra gli slavo-macedoni, delusi dal cambio del nome, con l’aumento dei consensi tra gli albanesi. Una manovra che ha riacceso gli spiriti nazionalisti tra gli slavo-macedoni.
«Quale sarà il prossimo passo?», si chiede Aleksandar mentre sorseggia un caffé in un quartiere di Tetovo abitato da macedoni. Per Aleksandar la legge sulla lingua albanese è solo uno specchietto per le allodole. «La Macedonia del nord ha una delle legislazioni più avanzate in tema di minoranze. Quella legge non aggiunge nulla in termini di diritti. La verità è che qui gli albanesi godono di un forte sostegno da parte della comunità internazionale. Non mi sorprenderei se la prossima mossa sarebbe l’autonomia territoriale e poi magari chissà, la Grande Albania…».
Dall’altra parte della città Isak, albanese, smentisce. La Grande Albania è un sogno, certo, e come tutti i sogni non ha nulla a che fare con la realtà. «Siamo nati in Macedonia del nord, è questo il nostro Paese. Quello che vogliamo è avere più diritti, non essere considerati dei cittadini di serie b». Per Isak i diritti negoziati sul lago Ohrid che posero fine alla crisi del 2001, rimangono in larga parte ancora sulla carta. La minoranza albanese è tanto numerosa quanto marginalizzata. Un quarto della popolazione e una valanga di stereotipi che considera gli albanesi i terroni della Macedonia: primitivi, evasori, dannatamente prolifici.
«Un albanese morto è un buon albanese». «Camere a gas per gli albanesi». Si è sentito anche questo tra i cori dei migliaia di tifosi accorsi all’aeroporto di Skopje per accogliere il Vardar, vincitore del campionato europeo di pallamano. Un momento di unità nazionale durato l’arco di poche ore, il tempo necessario a che scoppiasse la polemica sugli slogan razzisti.
«È questo che odio, sono dei fascisti» attacca Ame, ultras dell’FC Shkupi, il club di calcio albanese della capitale legato ufficiosamente ad Artan Grubi, parlamentare del Dui. Si fanno chiamare Shvercerat, trafficanti, e loro sono i rivali storici dell’Fc Vardar, la squadra macedone di Skopje. Ame è abituato a sentirli quegli slogan durante le partite di calcio. «Vomitano il loro odio negli stadi. Qualche volta sono arrivati ad aggredire albanesi che non avevano nulla a che fare con gli ultras, spiega Ame. Nessuna giustizia per noi e così siamo obbligati a difendere noi stessi e a rispondere usando i nostri metodi». Degli ultras macedoni quello dei Shvercerat è uno dei più violenti. «Ci sono stati molti scontri, è vero, ma solo con gli ultras. Siamo orgogliosi di ciò che siamo, prosegue Ame, continueremo a proteggere il nostro popolo, la nostra identità, il nostro onore». La conversazione vira poi sulla politica che nei Balcani ha connessioni profonde e oscure con le tifoserie. «Gli ultras slavo-macedoni godono del sostegno dei loro politici. È sempre stato così, però – ammette -, negli ultimi anni qualcosa è cambiato».
Un cambiamento ancora molto fragile, esposto com’è ai tentennamenti di un’Europa che rischia di vanificare gli sforzi compiuti se continua a tenere chiusa la porta dei negoziati. Un cambiamento reso ancora più fragile dall’eco lontana del possibile accordo di scambio tra Kosovo e Serbia. Uno scenario che solletica gli appetiti dei nazionalisti albanesi in Macedonia. Segno evidente che la strada verso la riconciliazione tra le due comunità è lunga e che far risuonare le sirene del nazionalismo etnico è considerata ancora l’opzione più conveniente da parte della politica.