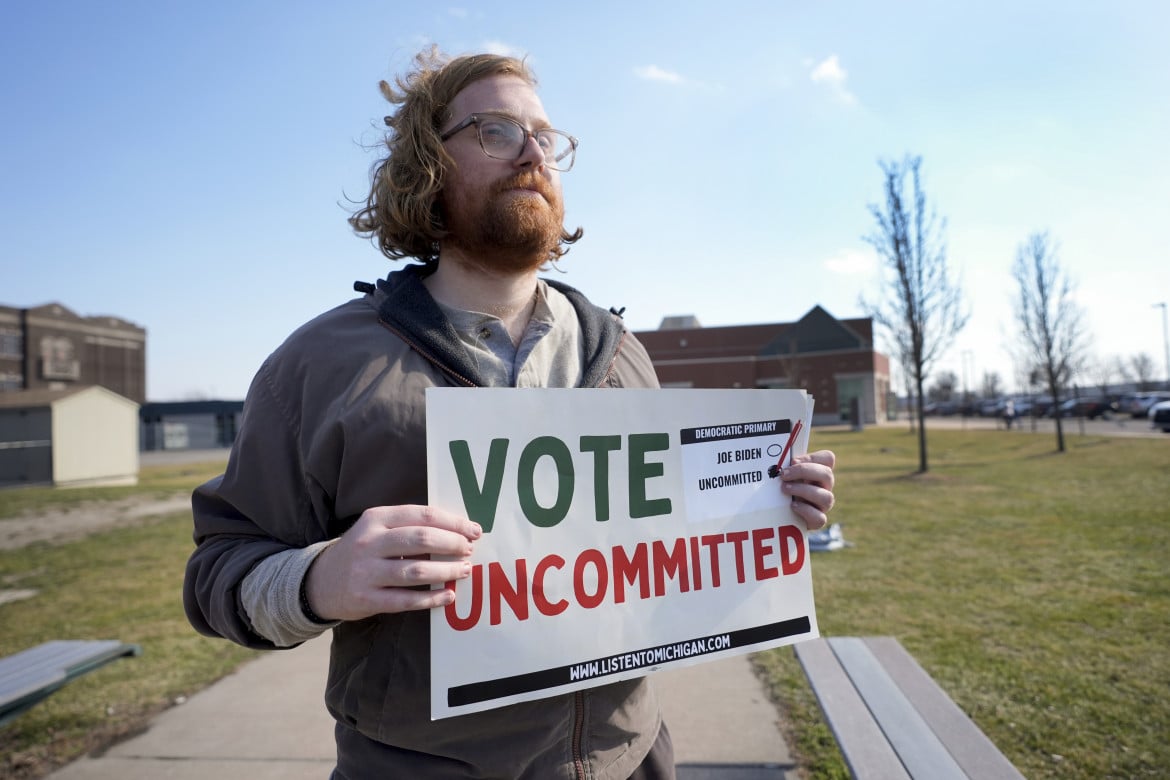Il cosiddetto «rimbalzo», il bounce, c’è stato. La convention repubblicana regala a Donald J. Trump una manciata di punti nei sondaggi, quanto basta, secondo Reuters-Ipsos, per quasi appaiarsi a Hillary, finora sempre in testa con un certo distacco rispetto al rivale repubblicano.
L’attenzione dei media, nei giorni scorsi, era tutta concentrata nel catino della Quicken Loans Arena di Cleveland e, come avviene a ogni convention, essa è rimbalzata nei giorni successivi traducendosi in un avanzamento nei sondaggi per il candidato sotto i riflettori. Nel 2012, nella convention di fine agosto a Tampa, Mitt Romney fece un salto di cinque punti, tanto da far pensare che avrebbe potuto farcela contro Obama. Ma non andò così.
Una domanda legittima
Chissà questa volta. Già, ma, innanzitutto, quanto si può dare retta ai sondaggi? La solita domanda. Ancor più legittima dopo una convention, che, appunto, in qualche modo “droga” i numeri.
Cifre a parte, però, quel che accade in una convention va preso molto sul serio, anche quando lo spettacolo prevale decisamente sulla sostanza politica, intesa come piattaforma programmatica e conseguimento, dopo il feroce scontro interno nelle primarie, della necessaria coesione nei ranghi del partito in vista della fatidica sfida di novembre. Dove in ballo non c’è solo la carica di presidente, ma centinaia di seggi alla camera e al senato e in numerose istituzioni locali. Il partito, è bene che ci arrivi unito all’appuntamento, dietro un candidato presidenziale che faccia da traino, in sintonia con il suo vice.
Ed è infatti nella convention che è presentato ufficialmente il ticket presidenziale, quando prende la parola di fronte ai delegati il possibile futuro vice-presidente. Carica tutt’altro che decorativa sia nello scontro con il ticket avversario nei mesi cruciali che verranno sia, poi, in caso di vittoria, nella gestione dell’amministrazione. I casi di partner sbagliati che hanno compromesso campagne presidenziali sono numerosi, così come i casi di scelte ponderate e azzeccate che hanno rafforzato candidature vulnerabili.
La convention dunque, è il punto d’arrivo di una dura, lunga battaglia interna iniziata con la neve e il freddo e finita nella calura di giugno – le primarie – ma è soprattutto il momento che “definisce” i contorni e la direzione della campagna di guerra nei quattro mesi che seguiranno fino all’8 novembre.
Inevitabile, quindi, il confronto – questa volta più che nelle precedenti – tra la convention repubblicana, che si è appena conclusa, e quella democratica, che si apre lunedì a Filadelfia.
Le defezioni di Cleveland
Le assise Cleveland hanno confermato il talento del magnate di New York nel dominare la scena, anzi nel crearla lui, e nel rovesciare a suo favore situazioni che, per qualsiasi altro, al suo posto, ne segnerebbero il disastro definitivo. La bolgia di Cleveland – tale è stata la convention del Grand Old Party – segnata dalla defezione dei pezzi grossi dell’establishment repubblicano e dalla sfida aperta e malamente perduta del numero due del GOP, Ted Cruz, nei confronti di Trump, conferma il senso più profondo della proposta politica offerta da The Donald. La sua proposta politica si condensa in due parole: io stesso. Il GOP? Se vuole, mi segua.

Bernie Sanders, replicando all’appello del nominee repubblicano rivolto ai simpatizzanti sanderistas che, a suo dire, mai voterebbero Hillary e che in lui avrebbero la risposta offerta loro nelle primarie dem da Sanders, ha tweettato seccamente: «Is this guy running for president or dictator?» (Questo tipo si candida a presidente o a dittatore?).
Una campagna dittatoriale
Estremizzando il tweet di Bernie, si può in effetti considerare la corsa di Donald Trump verso la Casa Bianca «la marcia su Washington» di una sorta di moderno Mussolini. Un candidato-duce, che – diversamente da quanto pronostica il grosso del commentariat nostrano – non ha alcuna intenzione né di spostarsi al centro e di moderare i toni, né di coinvolgere altre figure rappresentative del partito, tanto più che molte di esse o sono riluttanti, come lo stesso speaker della camera Paul Ryan, o sono decisamente a lui ostili, come i Bush, Romney, McCain e altri papaveri nazionali e locali del GOP.
Sarà una campagna solitaria tutta all’attacco, tutta assorbita dalla sua persona, con il vice Mike Pence, lui sì, alla stregua di un portaborse, figura puramente decorativa (a meno che non si riveli un handicap fatale per The Donald). Insomma, una campagna “dittatoriale”. Questa è la sceneggiatura proposta dalla convention di Cleveland, che dovrebbe fare da “registro” di quel che d’ora in poi si vedrà e sentirà nel circo trumpista. Il paradosso è che – dovesse tentare in corsa di aggiustare la linea, di ammorbidirla – finirebbe per perdere proprio la sua base, l’elettorato bianco rancoroso ed esagitato che l’ha portato dove è finora arrivato e che non capirebbe un Trump light.
Di fronte a questa prospettiva, la convention di Filadelfia offrirà uno scenario opposto. Sanders avrà un posto d’onore e le sue proposte troveranno eco sia nel discorso d’accettazione di Hillary sia nella piattaforma programmatica. Se l’inclusione di Sanders sarà reale e non solo maquillage, le previste contestazioni dei sanderistas più esigenti dovrebbero essere marginali. E si vedrà l’opposto dello scontro Cruz-Trump. Tutti i grandi nomi faranno da contorno alla nominee, dal presidente in carica alla radical Liz Warren. Il Partito democratico vuole dimostrare anche così di essere ancora – diversamente dal Gop – un partito, plurale, aperto, una forza politica che non solo si candida alla continuità nell’amministrazione presidenziale, ma anche alla riconquista della maggioranza al Congresso.

La figura complementare
La scelta di Tim Kaine va in questa direzione. Secondo Patrick Healy del New York Times, la sua designazione rispecchia un forte ottimismo nella squadra clintoniana, l’ottimismo di chi già vede Hillary seduta alla Casa Bianca. Dove la figura di un politico di lungo corso, esperto e pacato (perfino boring noioso) come il senatore della Virginia sarebbe complementare a quella di Madam President.
Non fosse così rosea l’attesa clintoniana, la scelta del vice sarebbe finita su una figura più utile nel corso della campagna elettorale, più di quanto non sia quella di Kaine, per esempio una donna o un esponente africano-americano o un ispanico o il rappresentante di uno stato in bilico.
La sfida – nel progetto dei democratici che si accingono a riunirsi per quattro giorni a Filadelfia – diventa così meno concentrata sullo scontro di personalità – anche se Trump farà il suo massimo perché sia così – ma tra due idee e due prospettive diametralmente opposte della politica e del futuro dell’America.