Tra i suoi libri preferiti ama citare Absolute beginners di Colin MacInnes – portato al cinema nel 1986 da Julien Temple – per il modo in cui ricrea l’atmosfera londinese di Soho negli anni Cinquanta. Ma se gli si chiede se il suo romanzo faccia lo stesso con la Barcellona delle sottoculture violente degli anni Novanta, Kiko Amat replica che mettere in scena la periferia operaia della metropoli catalana, i fumi delle fabbriche e il degrado dei quartieri rappresentava un passaggio ineludibile per dare corpo al mondo che popolano i personaggi che ha scelto. Più ancora di quanto l’autore sia disposto ad ammettere, Il segreto di Amador, uscito per le edizioni e/o nella smagliante traduzione di Pino Cacucci (pp. 310, euro 18, 50), fissa in immagini vivide una stagione e un volto di una città dai più probabilmente ignorato.
La storia che racconta Amat, nato a Sant Boi de Llobregat nel 1971 e già autore di alcuni romanzi che lo hanno segnalato come una delle voci più interessanti della nuova narrativa locale, ha per epicentro un gruppo di skinheads neonazisti, i Lokos, che nella Barcellona degli anni Novanta passa velocemente dalle violenze razziste e dagli scontri inscenati sulle tribune del Camp Nou, lo stadio del Barça, alla malavita. Della banda fa parte anche Amador, il protagonista, costretto a celare la propria omosessualità in un ambiente omofobo e razzista che evoca in una città meticcia i miti di morte del Terzo Reich e del suprematismo bianco.
Con estrema attenzione per i sentimenti dei personaggi, Kiko Amat guida il lettore all’interno di un mondo brutale dove dominano però solitudine e incertezza: non certo la descrizione dei «naziskin buoni», ma una riflessione narrativa di grande efficacia sulle radici dell’odio.

Devo fare necessariamente una premessa per rispondere a questa domanda. Ho fatto parte di un gruppo skinhead/mod dalla metà degli anni Ottanta fino all’inizio del decennio successivo e ho inserito le esperienze di quel periodo in un paio dei miei romanzi precedenti, a cominciare da Rompepistas (Anagrama, 2009). Ma ho tralasciato il lato neonazista e ultrà che lambiva quell’ambiente perché in quel momento volevo scrivere un poema di guerra sulla mia giovinezza, una sorta di racconto epico, non eroico, ma romantico: una lettera d’amore alle sottoculture adolescenziali della classe operaia. La bruttezza, lo squallore e l’ultraviolenza non facevano parte della storia che volevo raccontare. Ora è arrivato invece il momento in cui ho sentito che dovevo finalmente scriverne.
E quale approccio ha scelto a questo punto?
Nella Barcellona degli anni Ottanta, quando ero un ragazzino, i naziskin erano circondati da una specie di mito, erano quasi delle celebrità: anche chi non era legato ad alcuna subcultura aveva sentito parlare almeno una volta delle loro imprese. Diciamo, per capirci, che le generazioni precedenti avevano i loro folk devils: per la mia erano gli ultras e gli skinhead; erano loro i nostri Babau… A questo va aggiunto che molte di queste storie erano riportate in modo sensazionalistico dai media mainstream o circolavano per sentito dire, attraverso il passaparola che ne esagerava e amplificava molti aspetti. Perciò dico che le vite e le azioni dei naziskin di quel periodo erano più miti che realtà. In pochi li conoscevano personalmente, e quindi per ragazzini come me non restava che l’immaginazione. Così, mi interrogavo su di loro, sulle loro famiglie, i loro genitori, la loro vita privata, se ricevevano regali a Natale o amavano le loro nonne? In generale i naziskin amano le loro nonne? Ecco, Il segreto di Amador rappresenta semplicemente il mio tentativo di capire da dove provenissero quelle persone. Non ero però interessato a riferire fedelmente delle loro vicende o a scrivere della «true fiction»: volevo conservassero parte di quel mistero, della sinistra ambiguità che li circondava.
Al centro del romanzo, fin dal titolo originale (Revancha), c’è il sentimento della vendetta che assume diverse tonalità per ciascun personaggio: è la forma che assume una disperata richiesta di visibilità, e forse di amore, per chi ne è stato sempre escluso o tenuto ai margini della società?
Volevo che i lettori provassero una certa dose di empatia per la richiesta che in effetti proviene da Amador. E questo pur essendo consapevoli di cosa è stato capace di fare, del fatto che non si tratta certo di un personaggio uscito da favola, di qualcuno che ha solo incontrato le persone sbagliate. No, affatto, lui è decisamente malvagio. Ma credo che per uno scrittore sia importante rendere reali e comprensibili anche i personaggi peggiori piuttosto che dipingerli a tinte rosee. Del resto, nel romanzo, questo vale anche per Cid, il capo degli ultrà, forse una delle figure più cupe. Perciò, sì, «la vendetta» cui fa riferimento il titolo originale del libro non riguarda tanto gli scontri con le bande nemiche, quanto piuttosto un sentimento di vendetta globale contro il mondo intero. Vogliono distruggere la bellezza e la felicità perché gli sono state negate. Lo si vede chiaramente fin dalle prime pagine: quando i Lokos picchiano e torturano uno spacciatore di coca galiziano non perché si intromettesse davvero nei loro traffici, ma perché ai loro occhi aveva una vita perfetta, una moglie e due bambini. Questo è ciò che vogliono fare a pezzi.
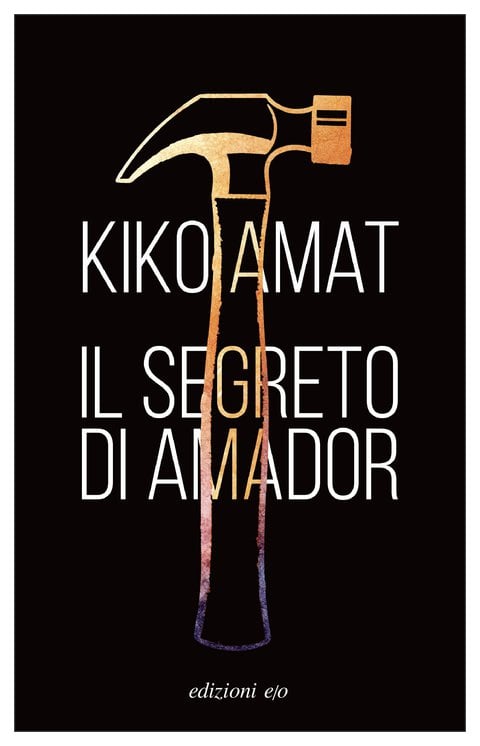
Entrambi sono nati nel posto sbagliato e scontano ancora i danni che gli ha procurato l’ambiente in cui sono cresciuti e le loro stesse famiglie, ma ciascuno di loro ha reagito a proprio modo, e hanno finito così per diventare completamente diversi. Amador ha una certa inclinazione artistica e al romanticismo, mentre César è stato un fortissimo giocatore di rugby. César porta la croce della propria bruttezza e Amador del suo orientamento sessuale in un mondo totalmente omofobo. Nessuno dei due è «nato malvagio» anche se è forse più facile essere buoni se non ti è mai successo niente di brutto. Come recita la citazione da un brano dei Beautiful South («Hooligans don’t fall in love») con cui apro il libro: «Il male è abbastanza buono quando è tutto ciò che hai mai avuto».
Quella che racconta non è solo una sottocultura urbana, ma anche una cultura orale: come è riuscito a renderla nella forma e con lo stile di un romanzo?
A rischio di farlo sembrare più eroico di quanto non sia, credo che in Spagna nessuno avesse scritto di una sottocultura in questa forma prima di me. E questo per il semplice motivo che la maggior parte degli scrittori ha un background di classe media e istruzione universitaria e non ha spesso la minima idea di come parlino e vivano le persone meno istruite, i lavoratori manuali, che partecipa ad una sottocultura nata nella working class. Molti giornalisti mi hanno chiesto se per lo slang dei Lokos mi ero ispirato ad Arancia Meccanica, cioè ad un libro. Non potevano nemmeno immaginare che ci fossero delle persone che parlano così nella vita reale. Si dà invece il caso che proprio nella banda che frequentavo da ragazzino ci fossimo dotati di uno slang particolare e inventassimo anche delle parole partendo da quello che ci accadeva per strada, un aneddoto piuttosto che altro.
Lei ha vissuto a lungo a Londra e guarda molto alle sottoculture britanniche. Il suo romanzo si può avvicinare a quelli di John King sul mondo degli hooligans – su tutti «The Football Factory», in italiano «Fedeli alla tribù» (Guanda, 1998) – come anche alle storie di Irvine Welsh?
Sono un anglofilo incallito e amo moltissimo questi autori, anche se non credo di essermi ispirato a loro. Piuttosto abbiamo un background simile, siamo nati con il punk e adottiamo un canone molto diverso da quello della «cultura seria». Trainspotting o Human Punk sono tra i miei romanzi preferiti. Nel caso di John King, in particolare, sento che quando scrive di skin o punk vuole spiegare a fondo le loro culture, la loro musica e tutto il resto. Rispetto quella visione, ma non è ciò che cerco di fare io che preferisco raccontare una storia di strada senza essere un giornalista o uno specialista di studi sociali.
La storia dei naziskin dei Lokos sembra ricordare quella dei Boixos Nois, uno dei gruppi più violenti e razzisti del Camp Nou. Le sono serviti da ispirazione?
Certamente, e non solo loro, ma anche gli skin inglesi e le firm casual (i nuovi gruppi di hooligans, nda) che si sono trasformati in malavitosi. Detto questo, il romanzo è un’opera di finzione e tutti i personaggi sono inventati. Però volevo che l’ambientazione tenesse conto anche delle gesta leggendarie o reali dei veri Boixos. Perciò l’omicidio che è al centro del libro rievoca quello di un ultras franco-spagnolo da parte dei Boixos avvenuto nel 1991. Allo stesso modo, la figura di Amador ha qualcosa a che fare con quella reale di Nicky Crane, uno skin inglese legato alla band nazi Skrewdriver e al circuito di Blood & Honour.
Blood and Honour, Base Autonoma, Cedade, Fuerza Nueva: sullo sfondo della storia che racconta emerge la geografia e le idee dei gruppi dell’estrema destra spagnola e internazionale degli anni ’90…
Non sono uno specialista in materia come Carles Viñas o Xavier Casals, e non volevo scrivere un libro sull’estrema destra, ma ho letto molto al riguardo e ho parlato con persone ben informate per rendere la mia storia credibile. E per farlo ho dovuto scrivere in modo convincente su alcuni aspetti della loro «ideologia» e su cosa significasse l’affiliazione ad alcuni repellenti partiti nazisti e così via. Inoltre dovevo comprendere appieno il perché tutto stesse accadendo proprio in quel periodo e quindi rimontare alle origini del fenomeno nel Regno Unito e al modo in cui era apparso nel mio mondo, quello del Barça e della mia città.






