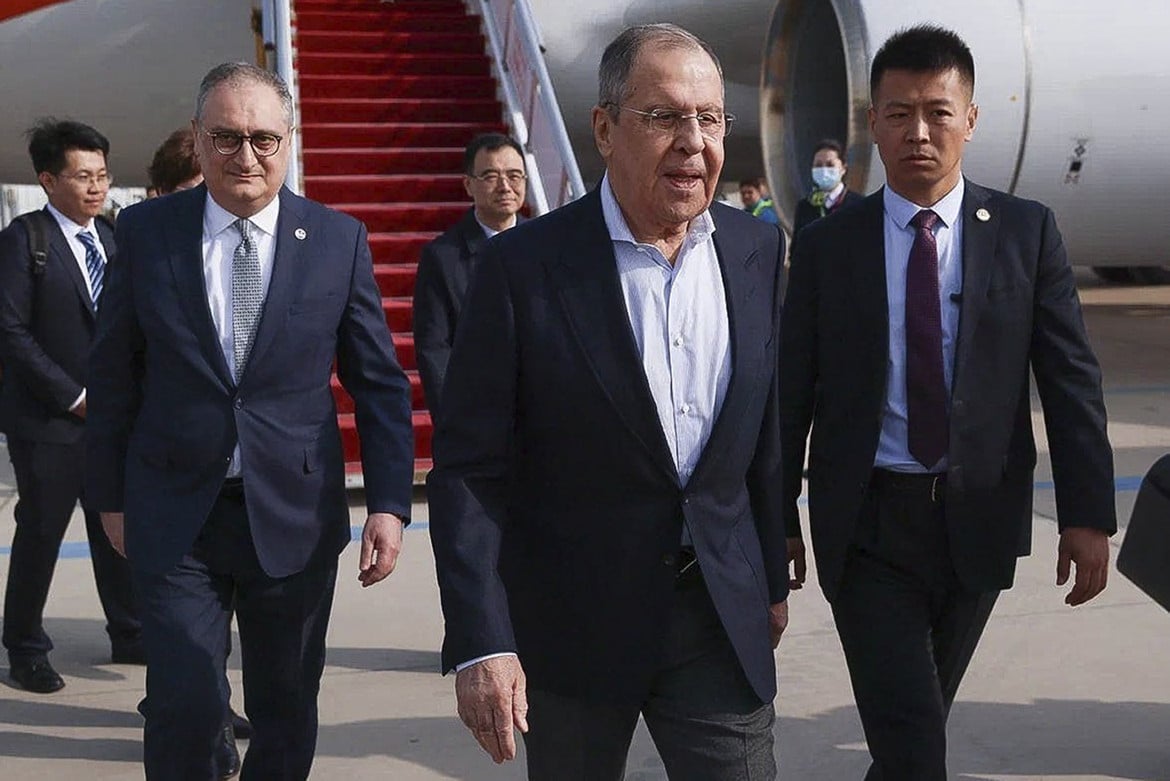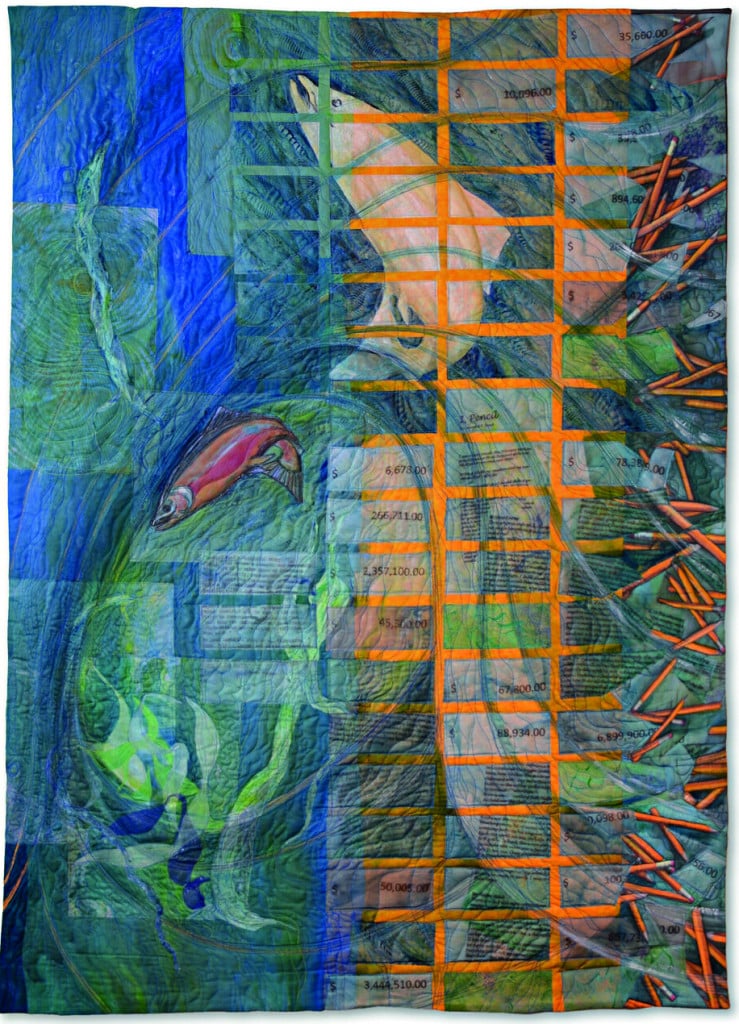Alëna e Sofija ingannano il pomeriggio in attesa del ritorno della madre spingendosi fin nel centro della città. Camminano sulle spiagge di ciottoli lambite dalle acque gelide che conducono verso il mare aperto e per quella via lontano, verso il Pacifico, lasciandosi alle spalle le coste orientali della Russia.
È AGOSTO, ma l’estate da queste parti è appena più mite dell’inverno, non c’è la neve lungo le strade ma il sole che scalda la pelle non fa davvero pensare a una «stagione balneare». Eppure, con le scuole chiuse è tanto il tempo da passare all’aperto per due bambine come loro. Alëna ha undici anni, Sofija appena otto. Mentre guardano il mare incresparsi nella baia, solcata da qualche sottomarino nucleare, navi da crociera, chiatte e pescherecci, la grande punzecchia la piccola raccontandole storielle spaventose. Ama farle paura ben sapendo che a lei basta una singola scena di un film dell’orrore per non prendere sonno per giorni. Volgendosi verso la terra ferma, di fronte allo spettacolo offerto dal profilo di Petropavlovsk-Kamchatskij, il porto, i quartieri costruiti lungo i fianchi delle colline, come fossero appesi sull’acqua, il vulcano, ancora attivo, che domina ogni cosa, Alëna racconta alla sorella della città che è stata spazzata via, travolta da un’onda «alta il doppio delle case», che «ha sollevato l’intera città e i suoi abitanti e li ha trascinati nel Pacifico. Nessuno li ha mai più rivisti».
LA MEDESIMA SORTE che attende le due bambine che, lasciata la riva, faranno perdere quello stesso pomeriggio le proprie tracce. Un’unica, possibile testimone: una donna di mezza età che mentre faceva scendere dall’auto il proprio cane in un parcheggio lì vicino per una passeggiata prima di cena, sostiene di aver visto due piccole che potrebbero assomigliare a Alëna e Sofija a bordo di una vettura nera e lucida guidata da un uomo bianco.
[do action=”citazione”]Ho scelto quella regione della Russia dove ho studiato perché è un’area grande come la California, ma perlopiù disabitata. Un luogo ideale per scomparire, dove sembra che tu possa scivolare tra le fessure della terra senza lasciare tracce[/do]

PRIMA DI TUTTO c’è però lo scenario che Phillips, titolare in passato di una borsa di studio per la Russia e che ha frequentato a lungo quei luoghi, ha scelto per il suo romanzo. Vale a dire, la regione dell’estremo oriente russo della Kamchatka, una penisola di più di 1200 chilometri rimasta chiusa per decenni, in epoca sovietica era considerata alla stregua di un gigantesco insediamento militare e che anche dopo la fine dell’Urss resta una zona particolarmente isolata, con pochi centri abitati disseminati lungo le coste meridionali, tra cui il capoluogo Petropavlovsk, e sconfinate distese di tundra che occupano gran parte del territorio. Un luogo da cui è più facile fuggire via nave o in aereo che attraversando strade spesso dal tracciato incerto e che si coprono di ghiaccio e neve per diversi mesi.

«Ho studiato e vissuto in Russia e sapevo che il mio primo romanzo sarebbe stato ambientato lì – spiega Julia Phillips -, ma cercavo un luogo lontano dalle metropoli dove il profilo della natura potesse intrecciarsi con quanto intendevo raccontare. Perciò, quando ho conosciuto la Kamchatka, ho capito che rappresentava ciò che stavo cercando. Un enorme scenario naturale dove inserire un mistero della camera chiusa. La Kamchatka è davvero chiusa sia storicamente che geograficamente. Per tutto il periodo sovietico c’erano pochissime persone e nessuno straniero che potesse entrare o uscite liberamente dalla regione. Un isolamento incredibile, allo stesso tempo affascinante e inquietante. Così, il romanzo inizia in città con la scomparsa delle bambine, ma poi ci si sposta in questo enorme spazio vuoto, spettrale. E non appena lasci i confini della città, le persone non sanno davvero cosa possa succedere. Un’area grande quanto la California, ma perlopiù disabitata: un luogo ideale per scomparire, dove sembra che tu possa scivolare tra le fessure della terra senza lasciare tracce».
LUNGO I DODICI MESI che seguono la scomparsa di Alëna e Sofija, la storia procede attraverso una serie di ritratti che finiscono però per ricondurre, in un modo o nell’altro, al dramma iniziale. Ma, come in un sistema di centri concentrici, ad ogni tappa l’orizzonte si amplia, consente di vedere qualcos’altro, senza che si perda di vista la terribile ferita del debutto. Perché le vicende descritte in La terra che scompare parlano di altre violenze, di sopraffazione, di rinunce forzate, di vincoli e coppie che soffocano, opprimono, spingono all’annichilimento.
E al centro di tutto ci sono donne, ragazze, bambine costrette a muoversi in un mondo di maschi. Si scopre così che se la scomparsa delle piccole a Petropavlovsk ha scosso almeno all’inizio la popolazione, ma loro sono «bianche» e cittadine, non è accaduto lo stesso per Lilija, una ragazzina di poco più grande , appartenente a una delle popolazioni native della regione, di cui si è persa ogni traccia a Esso, un centro dell’interno, non lontano dalla tundra. «Le bambine scomparse vivono in una città a maggioranza etnica russa. Nella mia sensibilità americana, ciò significa che sono percepite come «bianche». – sottolinea Phillips – Perciò le persone trovano naturale provare empatia per loro. Nel frattempo però ci sono altri che sono stati colpiti allo stesso modo, ma in virtù del colore della loro pelle vengono trascurati, ignorati. Il modo in cui le persone reagiscono ad un crimine e agli autori dello stesso è sempre ispirato alla razza. E non riesco a immaginare di scrivere una storia del genere senza che questa ne sia una componente importante».
[do action=”citazione”]Volevo esplorare la gamma di sopraffazioni presenti nella vita delle donne. Non solo quelle efferate di cui si parla, ma quelle quotidiane che si cerca di nascondere sotto al tappeto[/do]
Ma, come detto, nel romanzo non c’è solo l’ombra del razzismo che emerge a più riprese. Ci sono le vicende di donne negate o imprigionate nei loro affetti e legami, costrette ad inventarsi dei ruoli di facciata per sopravvivere all’interno di una società chiusa, ragazzine cui i pregiudizi e la «morale» della Russia putiniana, del resto nostalgica dell’«ordine» e dei valori di quella sovietica, precludono l’affetto e l’amore delle compagne.
«CON QUESTO LIBRO volevo esplorare la gamma di violenze presenti nella vita delle donne – spiega ancora Phillips-. La scomparsa delle bambine è un tipo di violenza ci sui si parla molto, ma poi ci sono anche quelle quotidiane di cui ci si occupa raramente, come una relazione tossica o un appuntamento dal dottore che va storto. Ognuna di queste cose non accade nel vuoto; fanno parte di una vasta gamma di ferite. Sono tutte cose che ho portato con me in Kamchatka. Temi che non riguardano solo il genere, ma le strutture di potere e il modo in cui queste strutture modellano la maniera in cui le cose vengono raccontate, cosa riceve attenzione e cosa viene semplicemente nascosto sotto al tappeto».
Un romanzo che l’autrice stessa descrive come una spirale che finisce per coinvolgere un’intera comunità attraverso il modo in cui i singoli personaggi si relazionano alla scomparsa delle ragazze, rivelando via via anche le proprie ferite, fragilità e pregiudizi. Una storia della Kamchatka dell’era Putin che si sarebbe portati a pensare assomigli davvero tanto a quella di molte parti dell’America dell’era Trump.