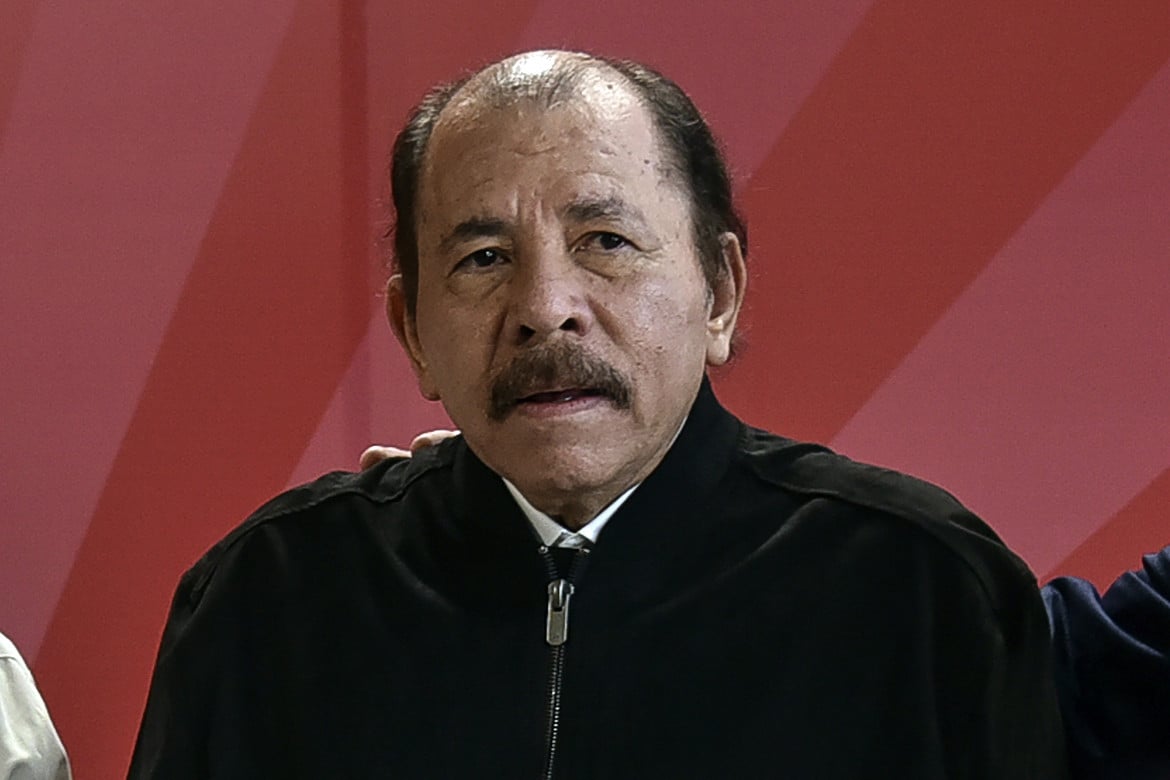Pubblicato 2 anni faEdizione del 28 gennaio 2023
Chapeo è una parola intraducibile che abita il mondo caribeño. Ha a che fare con lo strappare le erbacce, rastrellare i campi di canna da zucchero o ripulire un terreno. Ma la parola custodisce una porta girevole che apre su un altro territorio semantico, irrorandosi di seduzione, raggiro, ricatto lascivo e tutte le strategie emotive e sessuali che i corpi dei Caraibi mettono in campo di fronte a uomini e donne di quello che una volta si faceva chiamare «primo mondo». E qui entra in scena Johan Mijail. Performer, ricercatore sociale e scrittore, questo attivista queer nato a Santo Domingo...