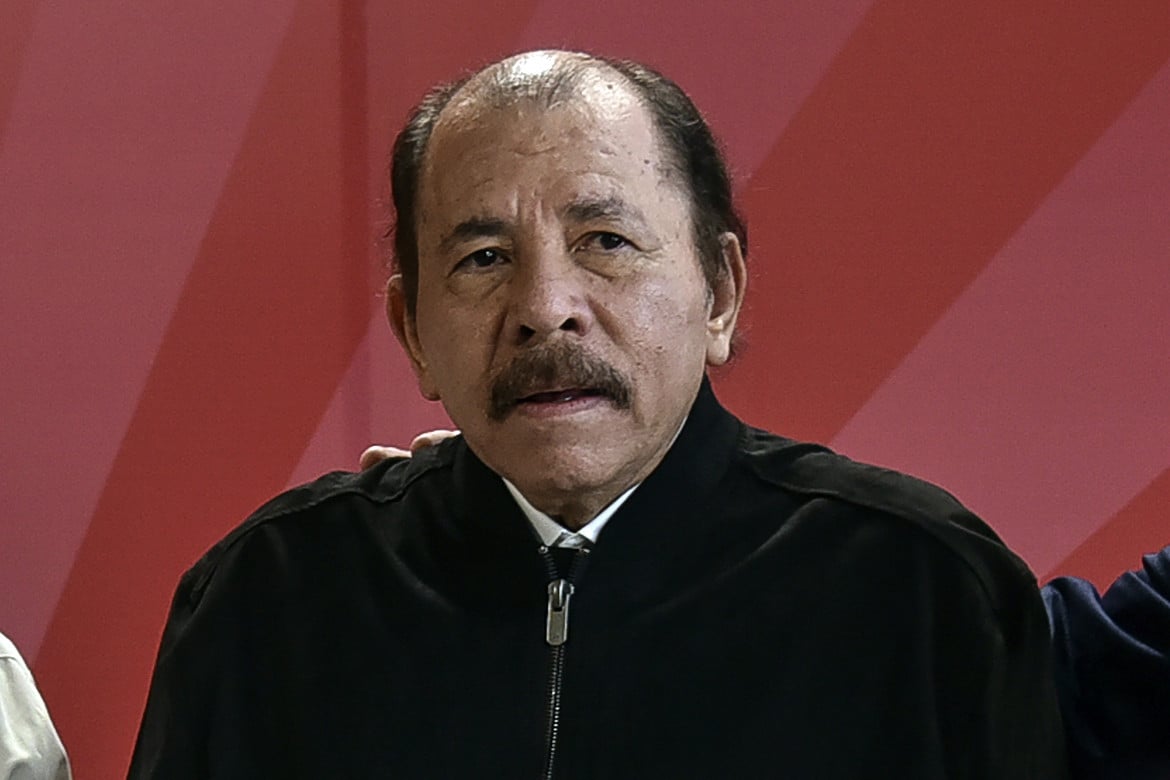Pubblicato 7 mesi faEdizione del 9 febbraio 2024
Com’era ampiamente prevedibile, non appena si è avuta conferma della morte dell’ex presidente Sebastián Piñera, precipitato mercoledì con il suo elicottero ultraleggero nelle acque profonde del lago Ranco, è scattato, tra tutte le forze politiche, il processo di santificazione. E di certo, al di là del giusto cordoglio per la sua scomparsa, gli elogi che gli sono stati tributati – e «tutti gli onori e i riconoscimenti repubblicani che merita», secondo le parole della ministra dell’Interno Carolina Toha – sono davvero un po’ duri da digerire. COME «DEMOCRATICO della prima ora» lo ha, per esempio, descritto Gabriel Boric, parlando di...