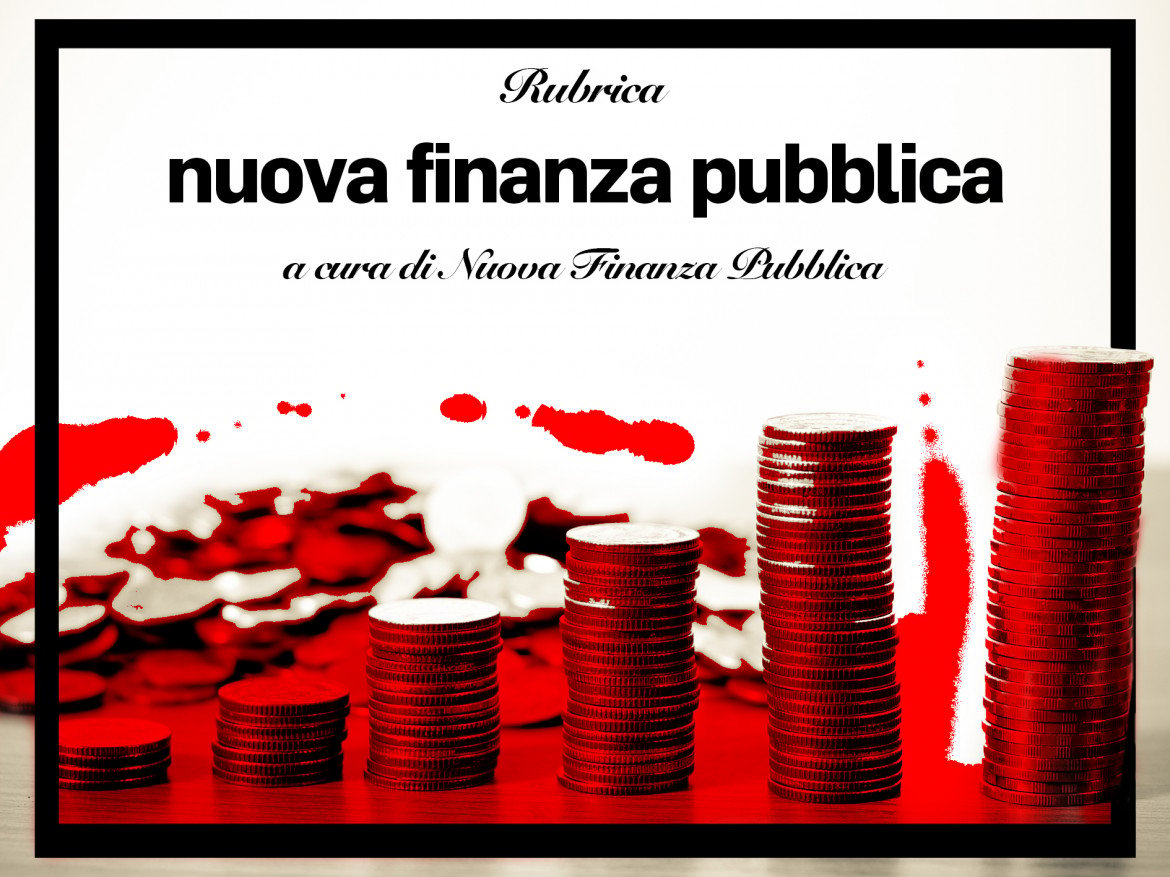L’Italia è, da decenni, fra i paesi con il debito pubblico più elevato, oggi prossimo al 140% del Pil. L’alto debito è fonte di iniquità, oneroso non solo per le generazioni future. È altresì fonte di instabilità dell’economia e ne frena la crescita. Venuta meno la sospensione imposta dal Covid, per i paesi europei con bilancio e debito problematici tornano le vecchie regole di Maastricht.
Anche se graduate secondo piani pluriennali per ciascuna economia imposti dalla Commissione europea.
Permarrà il rischio che, sia dal lato della domanda globale sia da quello della produttività, la finanza pubblica abbia effetti negativi sulla crescita, come è avvenuto dal 2000 nell’intera area euro, il principale fallimento della nostra comunità a moneta unica, preziosa anche perché faticosamente raggiunta.
I nuovi criteri non sono affatto nuovi nel principale difetto: la riduzione del debito è affidata al contenimento del disavanzo complessivo del bilancio pubblico, con limitate eccezioni – fra cui gli armamenti – prescindendo dalla composizione delle spese.
Ci si ostina a ignorare la soluzione indicata dall’ultimo Keynes: mantenere in pareggio la parte corrente del bilancio, mentre se vi è capacità produttiva utilizzata poco e male gli investimenti possono inizialmente e temporaneamente eccedere le entrate. Deve trattarsi di investimenti in infrastrutture, materiali o immateriali, utili ai cittadini e capaci di moltiplicare l’occupazione e la produttività, quindi il Pil, così da generare nel medio periodo un gettito fiscale pari alla spesa d’investimento originaria. Se questa così si autofinanzia, l’intero bilancio – parte corrente e parte in conto capitale – sarà in tendenziale equilibrio, senza nuovo debito.
L’assunto è che l’effetto moltiplicatore del Pil innescato dagli investimenti sia ragionevolmente elevato. Allora, il bilancio essendo in equilibrio, il debito, invariato, scenderà in rapporto a un Pil in aumento.
Secondo stime econometriche accreditate, l’assunto è realistico Tanto da fondare su di esso la strategia di finanza pubblica in economie che, come quella italiana, ristagnano da anni con risorse sottoutilizzate, bassi investimenti privati, inadeguata produttività. Buoni investimenti pubblici sarebbero di decisivo ausilio.
Nel bilancio pubblico italiano, senza incidere sulla spesa sociale (sanità, assistenza, pensioni, stipendi), sussistono spazi di riequilibrio strutturale di un saldo corrente che altrimenti tende a distruggere risparmio. Sono da ridurre i trasferimenti e le forniture per decine di miliardi favorevoli a imprese e autonomi, come pure l’evasione di imposte e contributi per altrettante decine di miliardi da parte di imprese e autonomi.
Desumendo facili profitti da tali fonti oltre che da salari «moderati», imprese e autonomi non hanno convenienza né a investire né a innovare. Si innesca così il circolo vizioso che da vent’anni inchioda l’economia alla crescita annua dello «zero virgola», con i poveri saliti a sei milioni, sfiducia nella politica, rischi per la democrazia costituzionale.
Gli investimenti pubblici vanno quindi potenziati. Almeno dal 2009 li hanno invece improvvidamente tagliati le maggioranze di ogni colore, governi «tecnici» compresi, sotto gli occhi appannati di Bruxelles. E questo è avvenuto persino nella sanità in un paese in cui oltre alle strutture sanitarie richiedono con urgenza cospicue risorse e chiarezza di intenti la messa in sicurezza del territorio, l’ambiente, il Mezzogiorno, l’istruzione, la ricerca. Tutto ciò sembra oggi affidato al Pnrr, che tuttavia non vede i tanti danari concessi dall’Europa – circa il 10 % del Pil! – accentrati in pochi grandi progetti, ma dispersi in mille opachi rivoli e finora spesi al blando ritmo annuo di non più dell’1% del Pil.
Non si può non essere preoccupati, se l’Europa dovesse continuare a non leggere o a non capire Keynes.