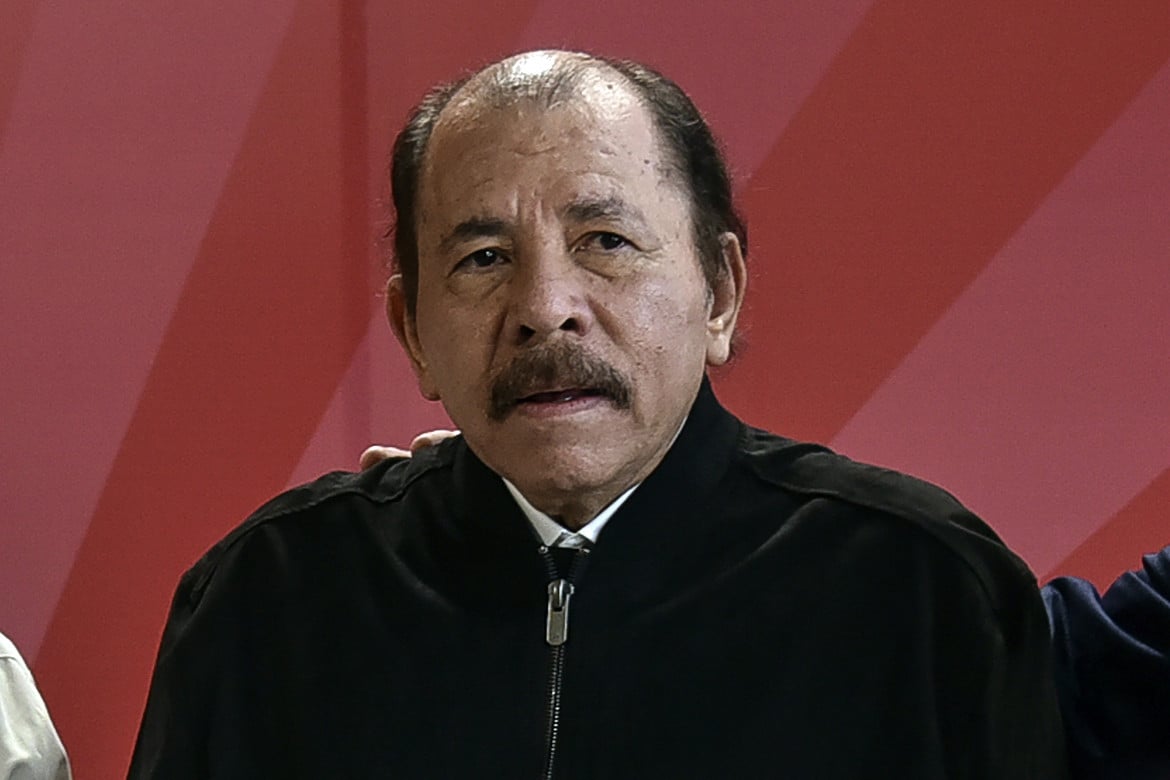Pubblicato 2 anni faEdizione del 19 gennaio 2023
È probabile che la prima e più compiuta rappresentazione del mondo e delle sue dinamiche, delle sue contraddizioni ma anche dei suoi paradossi, Eduardo Galeano (1940-2015) l’abbia avuta o anzi immaginata ascoltando la radio, in casa sua, il 16 luglio del 1950. Quel giorno, quasi duemila km più a nord, nell’appena costruito Maracanà di Rio de Janeiro, il più grande stadio del mondo, si affrontavano nella partita conclusiva della Coppa Rimet la squadra di casa, un Brasile fortissimo, strafavorito dal pronostico, e appunto l’Uruguay, un paese con meno abitanti di Roma e però dedito al calcio con tale capillare devozione...