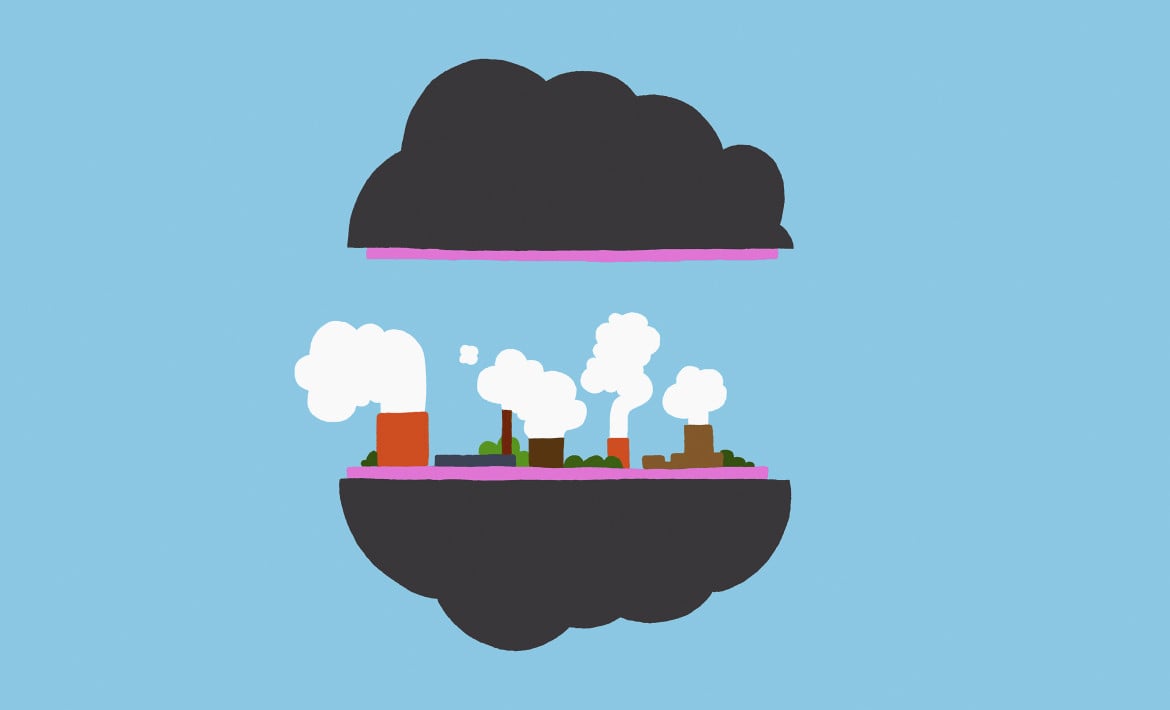Il decreto dignità non è la svolta che ci si attendeva sul mercato del lavoro, ma segna certamente una inversione di tendenza sul fronte della limitazione al reiterato utilizzo dei contratti a tempo determinato, cresciuti enormemente nell’ultimo periodo.
Non mancano però vistose contraddizioni: da un lato si interviene sul lavoro a termine, dall’altro sia riapre all’introduzione dei voucher, non limitati a specifici ambiti (ad esempio il lavoro domestico o alcune attività di cura in famiglia) ma soggetti di nuovo ad ampio sventagliamento, con il rischio di annullare, se non peggiorare, gli effetti della stretta sul tempo determinato e anche di scardinare la contrattazione collettiva. Qui sta la principale criticità di un decreto cui si aggiungono adesso gli incentivi per la stabilizzazione del lavoro temporaneo.
Di fronte al problema dell’occupazione a termine si torna dunque di nuovo a puntare sugli incentivi. Il costo di questi interventi nell’ultima legislatura è stato ingente, circa 20 miliardi di euro concessi a tutte le imprese, sia a chi ha assunto solo perché c’erano gli incentivi, sia a chi avrebbe comunque assunto anche senza incentivi. Bisognerebbe chiedersi che cosa hanno prodotto incentivi di questo tipo, che impatto hanno avuto sull’occupazione, soprattutto se e quanto hanno inciso sulla produttività del lavoro o contribuito al riassorbimento dei molti giovani high-skilled esclusi dal mercato del lavoro, costretti spesso ad andarsene all’estero per le scarse opportunità di impiego, oppure a rimanere ma al di sotto delle professionalità acquisite e con contratti a bassi salari. I dati ci dicono che dopo la fine degli incentivi è cresciuta soprattutto l’occupazione a tempo determinato e che il flusso verso l’esterno dei giovani qualificati non si è affatto arrestato.
Possibile non si possano immaginare soluzioni diverse? Ad esempio, perché non collegare l’incentivazione a scelte di politica industriale? Perché non scegliere di condizionare la loro erogazione all’assunzione di personale qualificato, magari nei settori produttivi a più alto tasso di valore aggiunto, o a investimenti e innovazioni, da contrattate con le parti sociali in azienda, in grado di incidere sulla crescita della produttività e qualità del lavoro? L’Italia è uno dei paesi europei con il più basso numero di laureati. E però i laureati, pur essendo relativamente pochi, fanno molta fatica a entrare nel mercato del lavoro, almeno rispetto ad altri paesi europei. Alcuni sostengono sia un problema riguardante le scelte sbagliate dei giovani rispetto all’università, o peggio ancora rispetto ai lavori e lavoretti che vengono rifiutati perché ritenuti al di sotto delle proprie aspettative. Altri, e tra questi chi scrive, pensano che sia oggi soprattutto un problema relativo alla struttura produttiva del paese, andata negli anni schiacciandosi su produzioni di basso manifatturiero. Certo non mancano nel nostro paese le eccellenze, medie imprese che hanno fatto un salto dimensionale e che riescono a stare sui mercati internazionali. Ma queste eccellenze, sia pure significative in alcuni casi, non bastano a trainare il mercato del lavoro verso l’alto, soprattutto quello dei servizi e al loro interno del terziario avanzato. La visione consolatoria della seconda manifattura d’Europa si scontra con la realtà di produzioni poco qualificate in molti casi, imprese troppo piccole che non crescono, e un terziario avanzato che non solo è di piccole dimensioni rispetto ai principali paesi europei, ma che è addirittura andato fortemente restringendosi negli anni della crisi, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto nel resto d’Europa.
Se a questo si aggiunge il crollo drammatico degli investimenti pubblici – nel 2017 hanno raggiunto il punto più basso dall’inizio della crisi – si capisce bene come i problemi che il nostro paese ha di fronte non riguardano semplicemente le regole che governano il mercato del lavoro ma la sua collocazione produttiva nello scenario internazionale. In realtà troppo si è discusso di regole e molto poco di politica industriale, di scelte strategiche, di settori core sui quali investire risorse, pubbliche e private, al fine di incidere sulla qualità dell’occupazione creata e sulle leve della crescita.
Gli investimenti sono l’anello debole del sistema produttivo italiano, con il riflesso di una persistente bassa produttività, tutt’altro che da addebitare al costo del lavoro o alle rigidità dei contratti, ormai in Italia assai poco rigidi. Come uscire dai vincoli del basso manifatturiero in cui è andato incagliandosi il sistema produttivo italiano è una questione troppo poco dibattuta e troppo spesso solo addebitata ai vincoli esterni, senza una pari considerazione dei limiti del capitalismo italiano. Le regole sono importanti ma non possono esaurire lo spettro delle questioni da affrontare, perché altrimenti diventano un alibi, dietro cui nascondere l’assenza di regia pubblica.