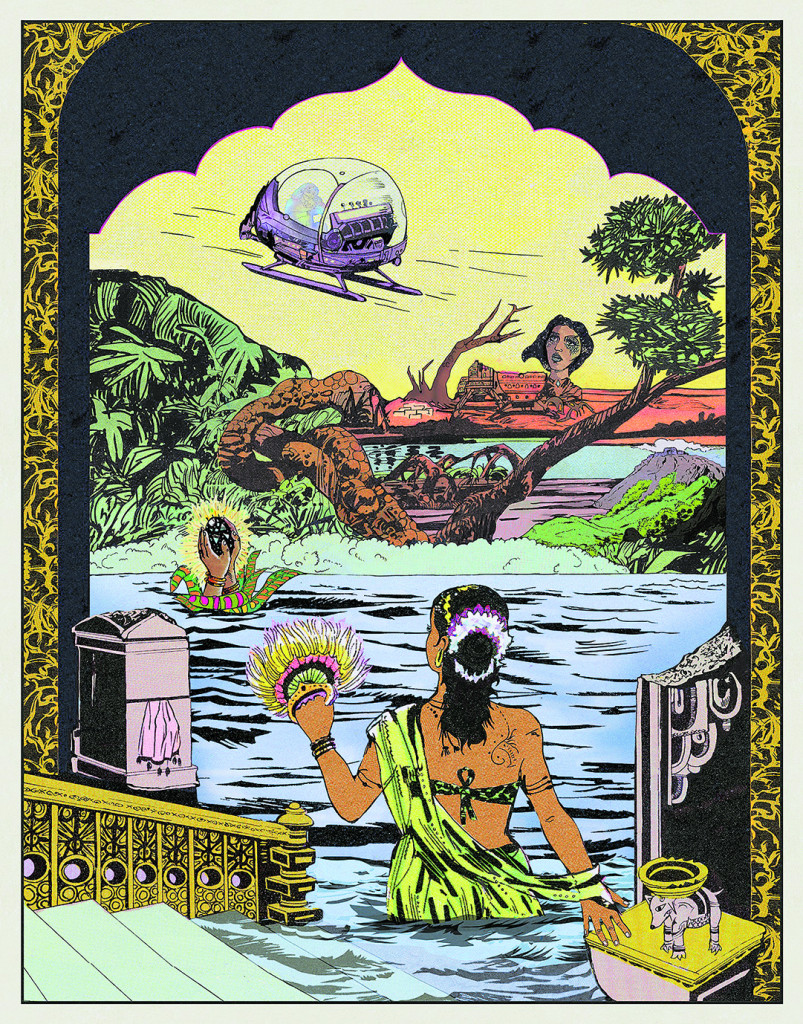Daniel Mendelsohn e gli dèi
Interviste letterarie Incontro con il romanziere e critico americano, approdato in Italia, del quale è uscita una raccolta di vagabondaggi tra generi, fatti e suggestioni: «Estasi e terrore», da Einaudi
 Daniel Arsham, «Moving Basketball»
Daniel Arsham, «Moving Basketball»Interviste letterarie Incontro con il romanziere e critico americano, approdato in Italia, del quale è uscita una raccolta di vagabondaggi tra generi, fatti e suggestioni: «Estasi e terrore», da Einaudi
Un filo rosso, di natura etica e sentimentale, lega l’erranza fra i diversi interessi di Daniel Mendelsohn, romanziere di successo, saggista, critico, traduttore: è la sfida ai propri limiti di scrittore, ma anche – e molto di più – all’inabissamento di ciò che per lui ha valore. Nelle critiche letterarie come nei romanzi cerca con ostinazione di richiamare alla vita frammenti polverosi o dimenticati collegandoli a qualche contingenza. L’inseguimento di un passato da consegnare al presente è il tema che struttura i suoi tre romanzi «maggiori»: Una Odissea descrive un doppio recupero, quello del legame tra un padre e un figlio e quello della vicenda omerica che, nel viaggio letterario e emotivo verso Itaca, diventa elemento vitale della loro relazione e della esistenza di ognuno.
Negli Scomparsi cerca di trovare le tracce di parenti perduti durante il nazismo, tracciando le vicende e i luoghi del cordoglio, ma anche cercando di rivivere e far rivivere la concretezza delle loro esperienze. Dall’esilio richiama infine alcune figure di intellettuali costretti, per motivi e in momenti diversi, a lasciare il loro paese: Fénelon, Auerbach e Sebald, i protagonisti di Tre anelli, dei quali descrive le avventure e i molti turbamenti per accoglierli infine insieme in una ‘casa’ letteraria allestita con grande abilità combinatoria proprio per loro.
Anche nelle raccolte di saggi, nei vagabondaggi tra generi, eventi, suggestioni colte e vibrazioni psicologiche della sua intensa attività di critico, torna l’evocazione imperiosa a presenze ormai disperse, perché la loro consistenza non vada smarrita. Mendelsohn attualizza gli dei della Grecia e, insieme ai miti classici, li rielabora come fossero nostri contemporanei: sa bene che la modernità li ha ormai banditi, eppure hanno ancora in sé – direbbe Hölderlin – il caos e la legge di cui lo scrittore americano sembra aver bisogno. Ed è questo è il legame più forte tra la vita universitaria – è professore di letteratura greca – e quella sua origine ebraica che salvaguarda nella memoria la catena delle generazioni, proiettando tutto ciò che si riesce a salvare verso un accettabile futuro.
Di una gentilezza composta e senza vezzi, ironica e accogliente, Mendelsohn è a Roma per presentare il suo ultimo libro «italiano», Estasi e terrore Dai greci a Mad Men, una raccolta di interventi su miti vecchi e nuovi, tradotta da Norman Gobetti (Einaudi, pp.398, € 22,00).
La letteratura del Novecento è andata decisamente contro la musealizzazione del classico: ha tradotto, scompaginato, attualizzato personaggi e vicende perché dessero senso al presente. Anche in questi saggi lei fa entrare con decisione personaggi ‘classici’ nella vita del lettore, ma preferisce farlo senza la mediazione dei molti filosofi che sulla sopravvivenza dell’antico si sono interrogati. Evitare il richiamo a chi l’ha preceduta è funzionale a una sua strategia di impossessamento del mito o serve solo a rendere più immediato il confronto?
In realtà non credo che un confronto più o meno esplicito con i molti che hanno interpretato i classici sia ciò che ci si aspetta da me. Ho cercato di spazzar via tutte le ragnatele delle precedenti letture nel tentativo di aiutare il lettore a entrare in contatto nel modo più diretto possibile con le profonde ramificazioni delle vicende che descrivo. Se avessi inserito anche solo brandelli di riflessione critica non sarebbe stato di nessuna utilità, anzi, sarebbe risultato solo ingombrante e inutile.
L’ebraismo è un tema che spesso affiora nei suoi scritti: le origini, il lavoro della memoria, le tracce della Shoah e la riflessione sull’esilio definiscono una spessa tessitura narrativa in cui storia e identità finiscono a volte per sovrapporsi. Più incerte le definizioni nelle sue pagine di cosa l’ebraismo sia (o cosa sia per lei): ne parla a volte come della religione del commento, che induce a interrogare e interrogarsi inglobando in ogni vicenda le sue interpretazioni; altre volte, avvicinandosi ad altri autori della letteratura ebraico-americana (da Roth a Malamud a Bellow), vede l’ebraismo come religione patriarcale che si arrovella sui diritti e sulla natura del padre. Come è possibile combinare queste prospettive?
L’elemento che lega queste due prospettive è la sempiterna, onnipresente questione dell’autorità. Come tutte le religioni abramitiche, l’ebraismo è espressione di un contesto fortemente patriarcale in cui il padre rappresenta un potere con cui confrontarsi e, a tratti, da combattere. A me sembra che tutto il Genesi non sia altro che un grande discorso sulla crisi dell’autorità, sulla ribellione nei confronti di una personificazione della legge in figure paterne. Adesso che mi ci fa pensare, direi che il cristianesimo, dal canto suo, risolve il problema facendo tutt’uno del padre e del figlio ed elimina così il problema di dover avere sempre a che fare con un’autorità paterna alla quale necessariamente contrapporsi: l’effetto è un continuo argomentare e discutere e dibattere e criticare e litigare e quindi articolare commenti e poi commenti su commenti e poi i commenti sui commenti dei commenti. Una lunga e ricca tradizione.
Con il suo libro dal titolo euripideo, Estasi e terrore, propone in questi giorni ai lettori italiani alcuni degli articoli scritti tra il 2003 e il 2019 per due riviste di taglio molto diverso come il «New York Review of Books» e il «New Yorker». Mi chiedo quali criteri abbia scelto un maestro nell’arte della digressione e della combinazione, come lei è, per articolare questa raccolta di interventi che spaziano dalla lirica di Saffo ai film di Pedro Almodóvar, dalla mito del Titanic a Mad Men.
Per quanto riguarda la mia produzione saggistica, devo molto all’allora editor della «New York Review of Books», Robert B. Silvers al quale mi legava una profonda amicizia. La scelta dei temi delle mie recensioni dipendeva soprattutto da lui. Ma faccio un passo indietro: quando ho iniziato a scrivere per la «New York Review of Books», Silvers mi ha proposto per prima cosa di occuparmi di Alcesti. A questa richiesta, giustificata in qualche modo dai miei studi classici, sono seguite le indicazioni più disparate: ho scritto allora di televisione, cinema, teatro, letteratura e mi è sembrato di avere qualcosa di interessante da dire anche su argomenti modernissimi, partendo da consapevolezze antiche o da suggestioni contemporanee. Questa idea ha guidato anche gli interventi raccolti in Estasi e terrore in cui si alternano, si integrano o dialogano tempi e contesti solo apparentemente lontani, da Antigone, al Titanic alla cultura pop, raccontati seguendo associazioni a volte casuali o dettate dalla contingenza, a volte profondamente radicate nella mia storia personale e nella mia formazione.
In Italia è stata pubblicata nel 2009 da Neri Pozza un’altra raccolta dei suoi interventi saggistici – Bellezza e fragilità – in cui già faceva dialogare generi e epoche diverse. Cosa distingue secondo lei e cosa accomuna i due volumi?
Con Grazia Giua, editor della Einaudi, abbiamo molto discusso sulla struttura che avrebbe dovuto avere il volume, perché scegliendo tra le recensioni che avevo scritto in oltre 15 anni, non solo cercavamo un equilibrio tra temi diversi, ma volevamo proporre qualcosa che parlasse davvero a un pubblico italiano, con lettori che hanno spesso competenze e interessi diversi da quelli americani. Il saggio sull’Eneide ad esempio poteva essere poco interessante per chi avesse frequentato il liceo classico da voi, mentre il mio intervento sul libro di Hanya Yanagihara Una vita come tante sarebbe risultato, nella edizione Einaudi, meno critico e divisivo di come era stato considerato in America. Quanto alle differenze, in Bellezza e fragilità è molto presente il mio interesse di allora per il teatro e, inoltre, i molti testi di carattere personale o decisamente autobiografico di allora segnalano, nella prospettiva dell’oggi, un mutamento sia nei mei pensieri, sia nei temi della mia narrativa.
Nel saggio più direttamente «teorico» del volume, Manifesto di un critico, afferma che un interprete più che dare giudizi dovrebbe fornire al lettore gli strumenti per formulare un parere personale, condividendo con lui conoscenze e interrogativi e cercando di far dialogare, in modo anche violento e provocatorio, passato e presente. Non c’è anche una intenzione pedagogica in questo progetto di condivisione?
Sì, penso di muovermi anche in una prospettiva pedagogica, nella sua accezione migliore, spero. Non intendo certo parlare al lettore ex cathedra, desidero piuttosto essere inclusivo ed esercito il ruolo del critico non per dare lezioni, ma per coinvolgere chi legge in una conversazione in cui, più o meno implicitamente suggerisco che, anche se a me è capitato di sapere di più su quello di cui parliamo, siamo tutti sostanzialmente sullo stesso piano. Ricordo che un editor molto famoso negli Stati Uniti mi invitò a più riprese a scrivere recensioni o saggi mentre insegnavo in un piccolo college americano; ma, sebbene gli dicessi ogni volta che scrivere e insegnare era per me troppo gravoso, lui sosteneva che, comunque, anche quando scrivevo restavo un insegnante. Se ripenso a lui, allora, certo, devo ammettere che nei miei scritti c’è un qualche tratto pedagogico, ma non ho certo l’intenzione di dire come si debba giudicare un’opera. Bisogna fare quel lavoro – diceva sempre Bob Gottlieb – che il lettore non ha il tempo di fare. Il mio compito è mettermi a sua disposizione, non certo fargli la predica.
In Estasi e terrore i suoi testi sono ordinati in costellazioni che rimandano al mito: sono tre capitoli, Miti di ieri, Miti in technicolor, Miti d’oggi, che raccolgono interventi su opere antiche, spettacoli, film, o anche su autori e vicende contemporanei – e tra gli autori compare anche Mendelsohn…
L’idea di organizzare il libro secondo alcune declinazioni del mito è stata in realtà della editor, che intendeva valorizzare l’insistenza con cui rimando alle antiche narrazioni per mostrare quanto continuino a influenzare non solo ciò che pensiamo e di cui scriviamo, ma soprattutto il modo in cui facciamo esperienza del mondo. Il mito può sia aiutare a comprendere la realtà che offrire una chiave per osservarlo. Nel saggio in cui rievoco l’affondamento del Titanic e rifletto sull’emozione che ancora oggi suscita quella lontana tragedia, metto in luce i legami tra la vicenda del transatlantico, con la sua pretesa inaffondabilità e l’esito infausto, e i miti che parlano di hybris e di nemesi: secondo me è proprio questo nesso che rende il naufragio del Titanic diverso da ogni altro. Così, anche la commossa popolarità della principessa Diana, una ragazza inglese non particolarmente interessante, si deve all’innesto nella sua biografia di riferimenti a figure che giungono potenti dalla antichità: è una moglie arrabbiata che, come Medea, è stata resa madre da colui che tradisce, ma anche la fanciulla manipolata da uomini di potere, come Ifigenia.
Nel suo discorso per il premio Malaparte, lei ricorda di aver imparato l’italiano leggendo i libretti di Da Ponte. È un legame suggestivo: la sua attrazione era dovuta al fatto che Da Ponte fosse un transfugo, un avventuriero, un apolide, un amante dei classici che si ribella al classicismo, o solo al fatto che era un magnifico scrittore?
Nella mia adolescenza, ascoltavo molto l’opera lirica e di conseguenza mi interessava imparare l’italiano. Ero amico, al liceo, di una cantante di talento, che ho seguito mentre provava la parte di Despina in Così fan tutte, un ‘opera che adoro, perché dietro la sua apparente leggerezza è presente un lato molto oscuro e coinvolgente. Ho imparato con lei i recitativi e il mio italiano ha acquistato una patina nobile e antica, che disorientava gli insegnanti. Solo dopo, tra approfondimenti e lezioni universitarie, ho cercato di capire chi fosse Da Ponte raccogliendo notizie sulla sua vita avventurosa e la sua personalità.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento