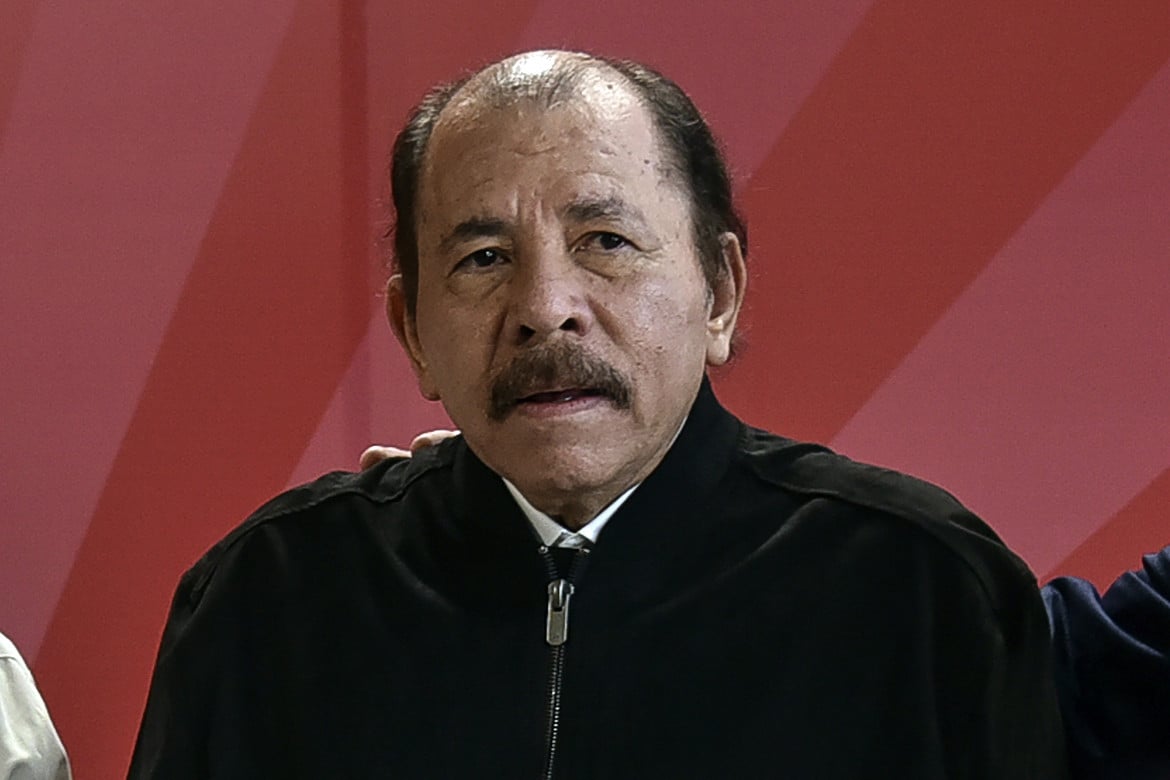Pubblicato 2 anni faEdizione del 19 agosto 2022
Claudia Fanti, ROMA
Se non avesse lasciato il Brasile, l’avvocato Ricardo Rao sarebbe andato incontro allo stesso destino di Bruno Pereira, il popolare indigenista assassinato il 5 giugno scorso in Amazzonia insieme al giornalista Dom Phillips. Amico di Bruno, e come lui dipendente della Funai, l’agenzia statale brasiliana che si occupa di popoli indigeni, Ricardo è a Roma, dove è arrivato a marzo, dopo aver ottenuto un asilo temporaneo in Norvegia. Grazie alla nazionalità italiana si è potuto stabilire nel nostro paese, dove sta cercando «disperatamente» un lavoro, ma ora teme per sua moglie e per il suo figlio di quattro anni, che...