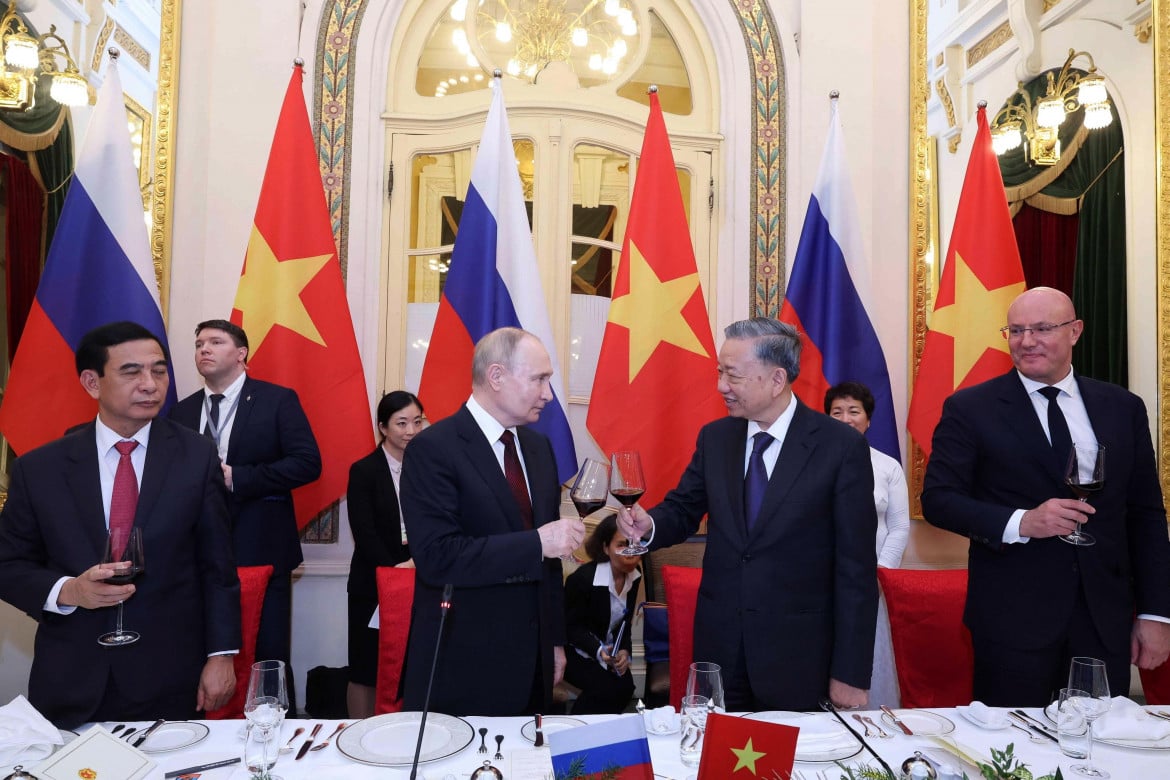L’attuale conflitto russo-ucraino inizia nel 2014 con la decisione della Russia di Putin di impossessarsi della Crimea. Il destino di questa terra cruciale continua a determinare l’esito della guerra che da un anno e mezzo ormai insanguina il continente europeo. Per comprendere l’importanza della Crimea è fondamentale ripercorrere le tappe della sua eccezionale storia, un compito efficacemente affrontato dallo storico Aldo Ferrari, docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, nella sua Storia della Crimea. Dall’antichità ad oggi (il Mulino, pp. 220, euro 20).
NONOSTANTE IL TAGLIO conciso, l’opera fornisce un quadro esaustivo dell’affascinante complessità etnica e culturale che da sempre caratterizza questa penisola proiettata nel Mar Nero. In virtù della propria posizione, sin dalla più remota antichità la Crimea ha rappresentato un ponte naturale fra le culture mediterranee e quelle eurasiatiche. A partire dalle interazioni fra i nomadi sciiti e le civiltà greca e poi romana, si sono sedimentati nella Tauride molteplici strati culturali (unni, goti, armeni, ebrei, genovesi, veneziani, mongoli per non citare che i principali) che ancora segnano il profilo unico di questa terra, ben illustrato dall’apparato cartografico in appendice al volume.
Specialista del mondo russo, Ferrari descrive in particolare l’importanza della Crimea per la Russia quale spazio dall’elevato valore simbolico, destinato a plasmare l’autocoscienza nazionale del grande paese. Proprio qui infatti avviene nel X secolo il contatto fra la Rus’ di Kiev ed il mondo bizantino con la conseguente conversione al Cristianesimo del gran principe Vladimir, da cui la nascita del mito di Mosca quale «terza Roma». Ma, prima di divenire parte dell’impero russo, la Crimea si venne ancora a trovare al centro dei commerci fra Europa ed Oriente gestiti dalle repubbliche marinare italiane (da cui si origina una piccola comunità latina le cui tracce permangono fino ad oggi) e poi, dal 1441, sede del Khanato (regno) turco-mongolo che la legò alla Turchia ed al mondo dell’Islam.
Riconquistata dalla Russia nel 1783, la penisola assunse da subito un ruolo d’eccezione per l’Impero degli Zar. In primo luogo in termini strategici e geopolitici, quale base principale per la potenza navale russa. Soprattutto, con la sua piacevole e mite natura mediterranea, «perla» fra lande fredde e difficili, la penisola divenne luogo di residenza preferito dall’élite politica ed intellettuale dell’Impero.
IN TERMINI CULTURALI, oltre a venir considerata «fonte del cristianesimo», poiché intrisa tanto di vestigia dell’antichità classica quanto del recente colorito orientale musulmano, la Crimea esercitò un potente stimolo intellettuale sugli esponenti delle arti russe che la visitarono. Il padre della letteratura russa, Alexander Puškin, creò addirittura un genere di «testo crimeano» ripercorso dai principali letterati del paese.
Un altro passaggio decisivo della storia crimeana è quello che la vide teatro della devastante guerra che oppose Pietroburgo alla coalizione degli ottomani e delle potenze dell’Occidente europeo nel 1853-55. Allora, la penisola si impregnò di sangue russo, radicandosi così ancor di più nell’immaginario collettivo quale elemento consustanziale all’identità nazionale. Il periodo sovietico porterà nuovi stravolgimenti, soprattutto completando l’esodo della popolazione musulmana tatara iniziato nel secolo precedente e decretando arbitrariamente il passaggio alla Repubblica federale ucraina nel 1954. Tale atto, considerato da Krusciov una formalità amministrativa, divenne con la scomparsa dell’Urss causa di tensioni fra Kiev e Mosca, fino alla decisione di quest’ultima di riannettere la penisola nel 2014.
In conclusione di questi tortuosi passaggi storici, Ferrari conclude che l’odierna Crimea rimane una terra maggiormente identificata dalla propria «russità». Se è certo che il regime di Putin ha strumentalizzato le vicende locali, del pari indubbia è la volontà della maggioranza dei residenti di non voler vivere sotto Kiev. Sorretta dall’Occidente, quest’ultima giura invece che la guerra non avrà fine fino al giorno in cui la sua bandiera non tornerà a sventolare su Sebastopoli. Oltre al contrasto con Kiev, permane quello interno con la popolazione tatara (tornata a rappresentare oltre il 10% dei cittadini), strumentalizzato dagli ucraini in funzione antirussa.
La Crimea rimane un nodo decisivo della politica internazionale, luogo dove continuano a definirsi equilibri e convivenze fra civiltà solo in apparenza irriducibili.