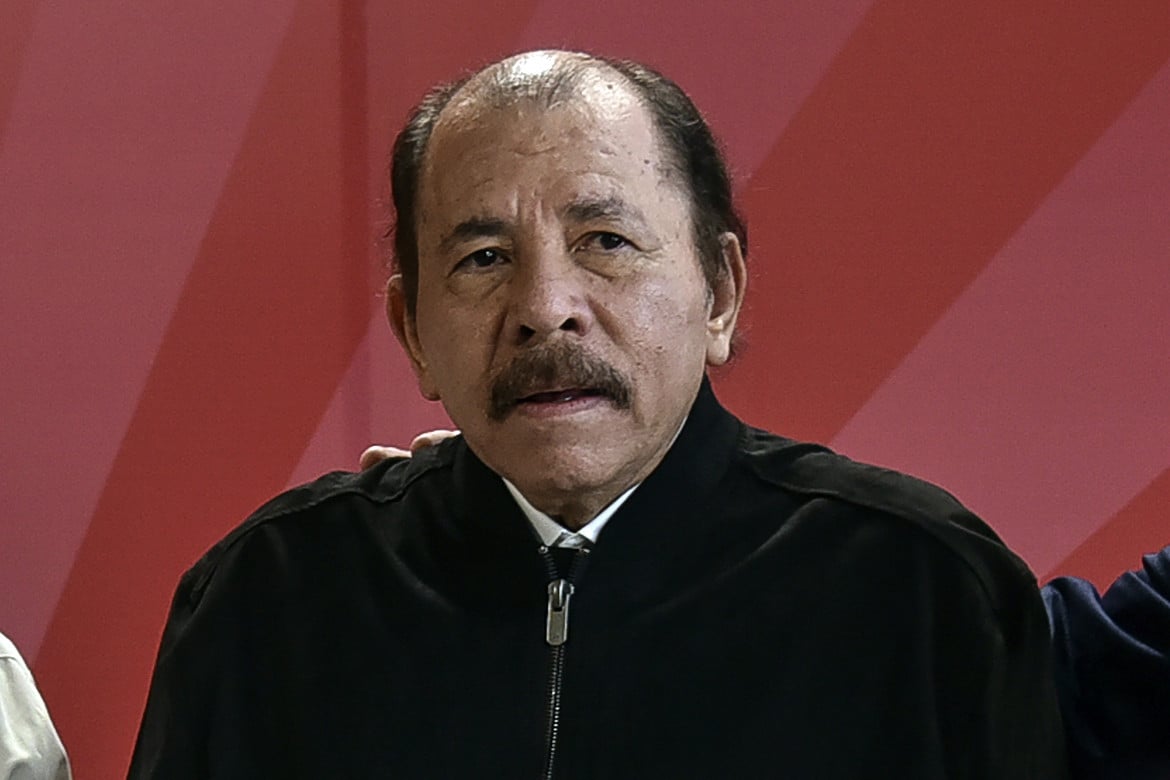Pubblicato 3 mesi faEdizione del 18 maggio 2024
Fin dall’avvento della sua presidenza, il presidente colombiano Gustavo Petro sapeva benissimo che l’oligarchia non lo avrebbe lasciato respirare. Dopotutto, la storia recente dell’America latina dimostra in abbondanza come la conquista del governo non coincida affatto con la conquista del potere. Tuttavia, quello che sta subendo il presidente in Colombia è davvero un assedio implacabile, tra il Congresso che affossa una dopo l’altra tutte le riforme chiave del suo governo, i mezzi di comunicazione che fanno a gara a criticare ogni sua mossa e il potere giudiziario che mette in scena l’ennesimo caso di lawfare. Con la formulazione di un...