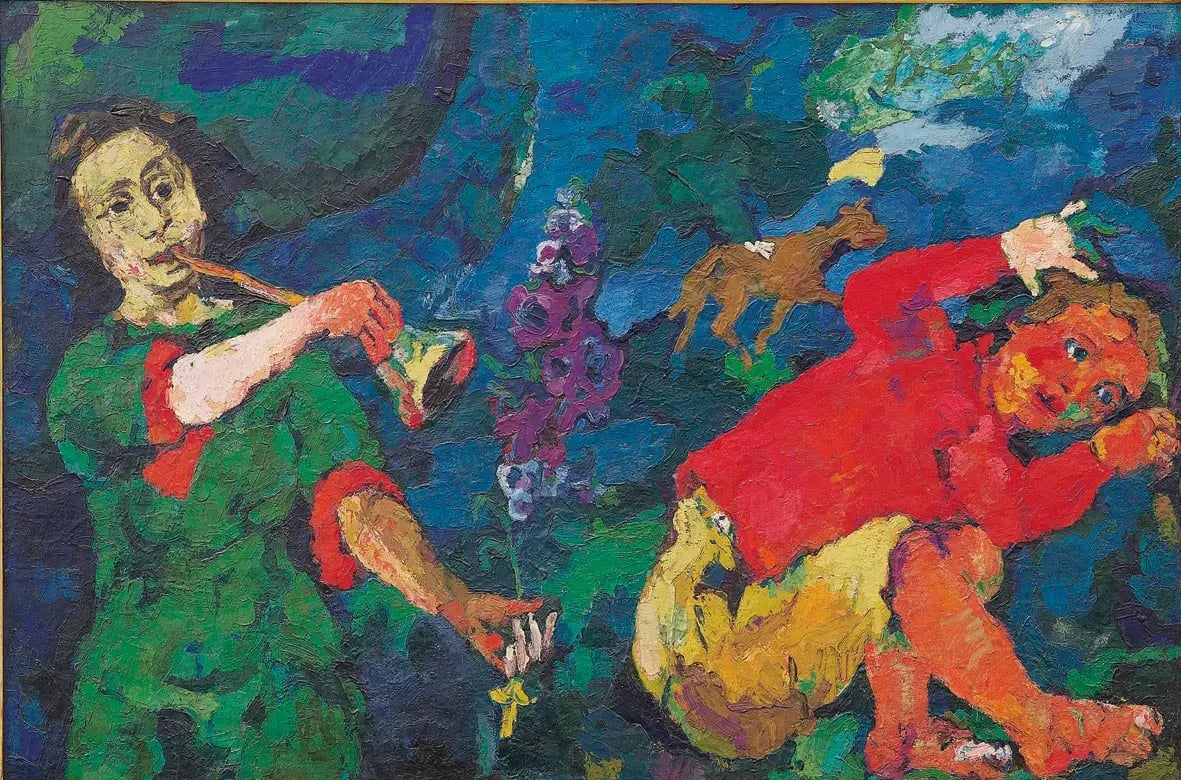Christoph Ransmayr, lo spazio romanzesco invaso dalle acque
Scrittori austriaci Umiliato dall’essersi ridotto a rotella di un ingranaggio per turisti «Il maestro della cascata» cerca riscatto nella tragedia: da Feltrinelli
Quale che sia la via percorsa, il fuoco delle storie di Christoph Ransmayr si concentra sempre sul rapporto tra uomo, civiltà e natura, dove personaggi storici ed epoche trascorse entrano in contatto, in cortocircuito o in collisione con l’attualità. Di solito in deroga alla coerenza – come nel Mondo estremo o nel Morbo Kitahara, entrambi deliberatamente indifferenti a una rappresentazione storica senza pecche – Ransmayr dà precedenza assoluta all’evocazione estetico-linguistica di una condizione umana e di strutture sociali (ma anche pre- o post-sociali), tutte in ultima analisi al di sopra del tempo. Alcuni romanzi dello scrittore austriaco seguono un filo narrativo coerente e lineare, come il recente Cox o il corso del tempo e altri, soprattutto ai suoi esordi, sfidano e disturbano il lettore con anacronismi, rappresentazioni ucroniche, interferenze mitiche, alterazioni sulla linea del tempo.
Non sono poche le opere dove a dominare è la cupezza crepuscolare di uno scenario apocalittico, post-atomico o surreale, presentato con un linguaggio denso e raffinato che, in fondo, profila sempre e di nuovo il carattere caduco e transitorio, fondamentalmente tragico, delle azioni umane. È il caso, anche, del nuovo romanzo Il maestro della cascata (traduzione accurata di Margherita Carbonaro, Feltrinelli, pp. 158, € 16,00) dove una voce narrante, senza nome, racconta in prima persona il suo lavoro di ingegnere idraulico in un mondo climaticamente inospitale, dentro un futuro fittizio ma non troppo, distante da noi non più di qualche centinaio di anni. A fare da sfondo alla storia – non un fondale muto ma la premessa maggiore da cui ogni azione si dirama – è il cambiamento climatico, ormai compiuto e irreversibile. Al centro di questo scenario globale, l’acqua è onnipresente e pervasiva.
Strabordante per l’innalzamento dei mari, ha allagato l’intero continente europeo, inabissando chilometri e chilometri di terra, costringendo gli uomini a nuove, avveniristiche costruzioni al di sopra degli edifici sprofondati, in un reticolo di canali, argini, chiuse, alzaie, esigua terraferma sempre sul punto di essere sommersa. Elemento quasi paradossale, sempre necessario alla vita ma allo stesso tempo latore di morte, innesco di ogni belligeranza per il possesso di falde potabili, epitome di un mondo che insieme affonda e si dissecca, l’acqua pervade tutto lo spazio romanzesco, rendendo indistinta, caliginosa, quasi infigurabile ogni azione descritta, e trasformando la concretezza in un opaco, stillante ologramma.
Una precisa filosofia della storia
Sarebbe assai sbrigativo ridurre Il maestro della cascata a romanzo a tesi, di impianto ecologista, o a mera climate fiction: se la prospettiva evocata sia uno scenario futuribile, l’enfatizzazione di qualcosa che c’è già o un quadro da day after importa poco. Muovendosi in uno spazio iconico che chiama alla mente importanti avantesti, dal «Water, water everywhere» nella Ballata del vecchio marinaio di Coleridge a Waterland di Graham Swift, passando attraverso le eliotiane morti per acqua, il romanzo di Ransmayr traccia una precisa filosofia della storia, non certo indirizzata verso un radioso avvenire.
La proiezione futura di Ransmayr, che ha tutti i tratti di una fosca distopia, finisce infatti per ristagnare nel passato più oscuro e retrivo, con l’Europa lacerata da ininterrotte guerre, civili e intercontinentali, per la conquista dell’acqua, dove la gestione della rete idrica è affidata a un cartello monopolistico più simile a un occhiuto sistema totalitario, ai cui dipendenti, e solo a loro, è concesso spostarsi attraverso il pianeta, superando le mille frontiere che lo frammentano e le tentacolari reti di sorveglianza che ne punteggiano l’estensione palmo a palmo.
Il continente europeo prefigurato da Ransmayr ripiomba così nell’incubo di un’ipertecnologica e tribale Guerra dei Trent’anni; l’unità che lo caratterizzava è ormai degradata ad arrugginita chimera, buona solo a rabberciare una scialba età dell’oro alla cui solarità nessuno più crede. La sua geografia è nuovamente frantumata in un pulviscolo di contee, città-stato, reami in sedicesimo, frazioni di territori refrattari al dialogo, graniticamente ripiegati in un angusto nazionalismo, impegnati a preservare la propria superiorità etnica, a impedire ogni meticciato. In questo futuro retrogrado, della vecchia Europa rimane a malapena il rimando a una principessa fenicia e al suo eterno mitologema, non certo il ricordo di un tessuto uniforme, politico e fisico, che, un tempo, connetteva i frammenti. Il risultato è «un puzzle di microstati fanatici, schegge di un continente con i loro inni e insegne araldiche, bandiere e monete e sbarre di confine multicolori che cambiano ogni venti o trenta miglia».
È lo stesso titolo del romanzo a evocare cupe profondità e un antico, indiscutibile arbitrio; più ancora il sottotitolo, che la versione italiana non traduce: «Una breve storia dell’uccidere». Padre del narratore, il maestro della cascata è il guardiano di una chiusa in un’ombrosa località della Mitteleuropa, la contea di Bandon, bagnata dal Fiume Bianco, dietro cui è facile intravedere l’Austria e il Danubio. Ancorato al passato, di cui vagheggia il ritorno, l’uomo sorveglia e governa un sistema di canali un tempo utilizzato dagli zattieri del sale per evitare i precipizi della cascata, ora ridotto ad attrazione museale. È lui, il guardiano, il primo attore di questo luna park della storia, umiliato dall’essersi ridotto a rotella di un ingranaggio per turisti. Si attribuisce il titolo frusto e altisonante di «maestro della cascata» e un giorno – questa la ricostruzione del figlio – in una distorta riappropriazione di dignità e di arbitrio, manovrando come un dio corrucciato le paratie della chiusa, provoca volontariamente la morte di cinque persone, precipitate nella grande cascata del Fiume Bianco.
Topografia dei primordi
Nella cornice soverchiante di una natura pluviale che non è bella, semmai sublime – un sublime solcato di bacini collettori, tubazioni e canali – e che spesso, nell’indistinzione delle sue brume, richiama una topografia dei primordi, preludio a ogni conferimento di forma, Ransmayr accosta i tratti dell’utopia negativa a sopravvivenze arcaiche e forme archetipiche. La collera, la sensualità, la spregiudicatezza, la gioia e il suo contrario, l’erotismo incestuoso, il candore, la timidezza, la generosità dividono lo spazio con geometrie ultramoderne à la Escher, denunciando la loro lunga durata fianco a fianco alla più avanguardistica ingegneria. In questo canto del cigno dell’umanità, che è insieme una dialettica dell’illuminismo due punto zero, ma anche uno specimen di surrealismo magico, Ransmayr si conferma un seguace di Hobbes, privo tuttavia di fiducia nello Stato, uno Zukunftsskeptiker, nella solida e nobile tradizione degli apocalittici austriaci, da Kraus a Bernhard e – per certi versi – inclusivo anche di Musil e Broch. La forza visionaria di Ransmayr e la sua presa, a tratti furiosa, sulle parole travasano in una lingua turgida e stracarica, con alzate di pathos che possono trascorrere nel kitsch, mandando fuori fuoco la trama, che in certi punti risulta troppo costruita e, nel ricorso a immagini da Armageddon snocciolate con tono profetico, persino innaturale. E tuttavia lo stile prezioso non compromette la creaturalità di una storia che, proprio nella sua cellula primaria di vicenda familiare, mantiene la delicatezza degli affetti primi e ultimi.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento