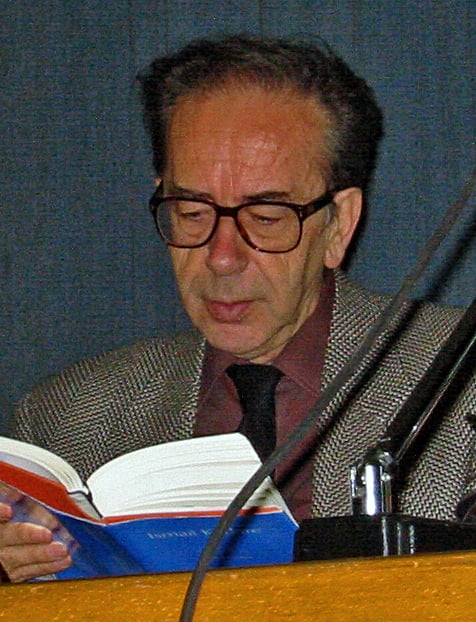Scrivendo su queste pagine per il decennale della guerra in Kosovo (2009) avevo evidenziato alcuni punti fondamentali della politica di guerra che aveva insanguinato i Balcani e in particolare le aree della ex-Jugoslavia.
Notavo come la catastrofe umanitaria non fosse più una conseguenza della guerra ma una sua causa ed un suo pretesto: se si vuole la guerra si aspetta o addirittura provoca una emergenza umanitaria; il resto viene da sé. In quel primo decennio il Kosovo era stato costruito come un «non stato» su base monoetnica sottratto ad una legittima e giuridicamente corretta sovranità nazionale. Il Kosovo era anche diventato il paradigma della guerra che non finisce mai che si maschera da operazione di pace o che viene definita «guerra civile» quasi a dimostrare che si tratti di questioni locali e che altre forze interne politiche, economiche e miitari non c’entrino per niente. Esprimevo anche il rammarico nel vedere che chi si adoperava per un dialogo interetnico, per la creazione di una entità indipendente con il consenso di tutti gli aventi causa (e di tutti coloro che avevano causato la guerra) e che chi voleva la fine delle ostilità fra etnie veniva osteggiato e persino minacciato mentre coloro che si adoperavano per la divisione, l’inasprimento delle relazioni interetniche e l’isolamento venivano premiati e osannati. In questo secondo decennio si è confermato tutto e oggi fa persino ribrezzo assistere alla celebrazione di una guerra infinita e una missione politica, diplomatica e militare incompiuta.
Nonostante l’estemporanea dichiarazione unilaterale d’indipendenza (2008), il Kosovo è ancora un «non stato». Le iniziative per la creazione di uno Stato multietnico si sono arenate. La forza militare internazionale (Kfor) è ancora presente e la tutela politico diplomatica della Nato e dell’Unione europea sono ancora necessarie. La spinta verso la divisione e lo smembramento del Kosovo, che per un certo periodo sembrava sopita di fronte alla prospettiva di guadagnare la protezione e i soldi internazionali, è più forte di prima.
Lo scorso anno a Belgrado ci sono state proteste per un incontro segreto avvenuto a Roma (a presunta insaputa del nostro governo) il 4 novembre tra il Presidente kosovaro Hashim Thaqi e quello serbo Aleksandar Vucic. I serbi accusarono il proprio presidente di voler svendere le regioni con popolazione e retaggio culturale serbo al Kosovo e d’altra parte molti kosovari non videro con favore le manovre per una spartizione del Kosovo. Se gli incontri segreti continuano con la facilitazione e le promesse di lauti vantaggi di alcuni paesi, fra cui l’Italia, in pubblico i due ostentano i contrasti. Lo scorso febbraio 2019 a Monaco, Vucic ha ribadito che il Kosovo non mantiene gli impegni assunti ed ha ammesso che la situazione del dialogo è in stallo e una normalizzazione dei rapporti «molto difficile» e ancora «molto lontana». Thaqi ha perfino detto che con la Serbia esiste un «conflitto congelato». I due hanno anche dichiarato che le basi di un accordo «contrastano» con le rispettive Costituzioni e se il Kosovo ignora la Costituzione serba, che per il Kosovo prevede il solo status di Provincia Autonoma nell’ambito dello stato serbo, non c’è motivo di riconoscere la Costituzione kosovara che prevede uno stato indipendente unitario e multietnico, ma solo a parole. Come si vede la strada verso una soluzione concordata non solo è lunga, ma anche sbarrata e minata. Le speranze vagheggiate da politici e diplomatici immersi nella retorica e nel mondo onirico non trovano nessun riscontro nella realtà.
Le uniche pallide buone notizie vengono dal fronte militare. Grazie alla leadership di Kfor assegnata ai comandanti italiani, la Nato ha dovuto accettare quello che nel primo decennio era invece fortemente osteggiato. Innanzitutto Kfor deve e può continuare a dialogare con tutti partendo proprio dalle realtà locali. La politica della chiusura nei confronti della Serbia è sostanzialmente caduta. Così come è caduta la protezione internazionale dei K-albanesi «a prescindere» che ha caratterizzato i primi dieci anni. Il Kosovo non è stato ammesso all’Interpol e questo la dice lunga sulle sue prospettive d’integrazione internazionale. La Nato che ostacolava ogni apertura di dialogo ed ha sostenuto le avventure unilaterali ha dovuto cambiare politica. Almeno a parole. Di fatto, oggi Kfor è l’unico elemento veramente attento al multilateralismo e all’equibrio interno. E questo è stato sufficiente a liberare Kfor dalla condizione di ostaggio internazionale. Infine, questo secondo decennio ha chiarito sul piano concettuale che chi ha fatto la guerra, «con razon o sin ella», non è in grado di gestire la pace. Permane la mentalità del conflitto che non permette alcuna soluzione ragionevole. La retorica della guerra, e soprattutto la retorica della guerra umanitaria, esalta la giustificazione e il valore innegabile dei combattenti di ogni parte e contingente, ma poi confonde la capacità di combattere con quella di governare, confonde gli strumenti per distruggere con quelli per ricostruire, gli sforzi per innovare con quelli per trarre profitto, lecito e illecito.
E il disastro continua. C’è bisogno di gente nuova, teste nuove con ideali e riferimenti culturali nuovi per fondare Città (Civiltà) e Nazioni. Questa lezione antica viene riproposta dal Kosovo ma si estende a tutti i casi e le guerre degli ultimi vent’anni. In tutto il mondo.
* generale, comandante delle Forze Internazionali in Kosovo (Kfor) 2002-2003