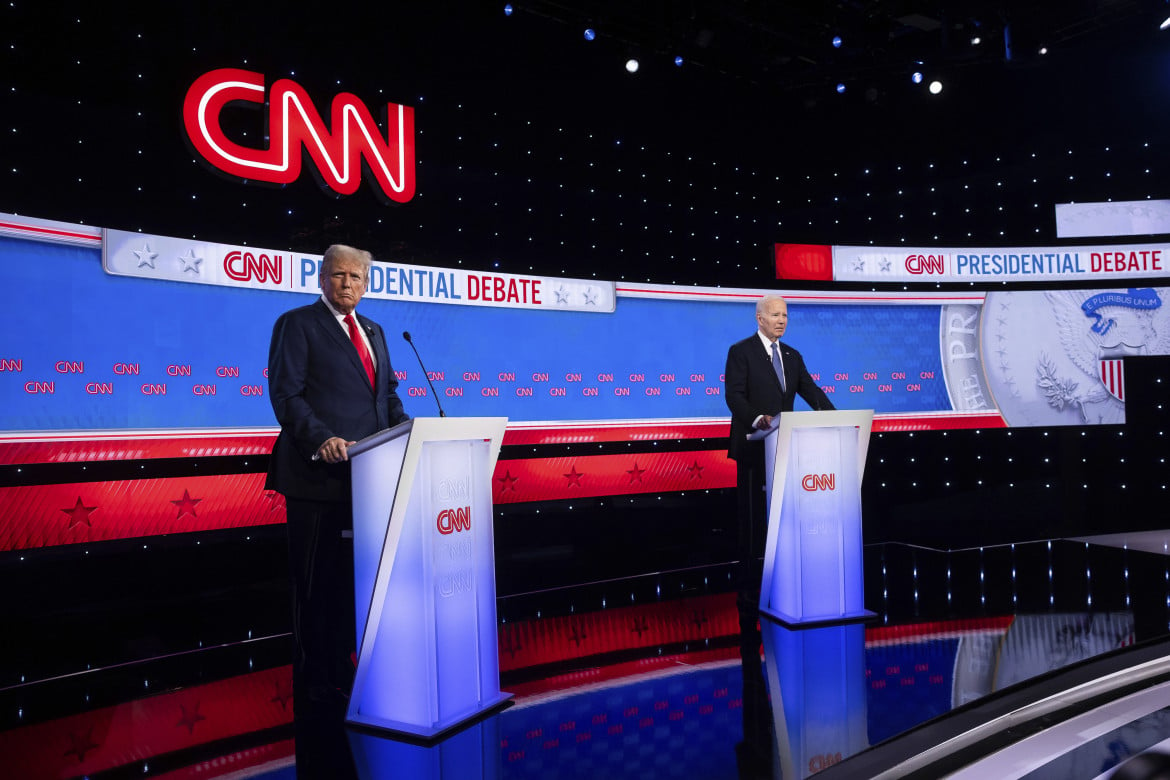Quella che a prima vista può sembrare una vittoria dei diritti delle donne alla Corte suprema Usa è in realtà solo il prolungamento di un’agonia. Ieri i giudici responsabili dell’abolizione del diritto federale all’aborto negli Stati uniti (con una sentenza che ha appena compiuto due anni) hanno accolto la decisione di una corte inferiore che bloccava la legge sull’interruzione di gravidanza in vigore in Idaho, una delle più restrittive del Paese. Contro la normativa – che consente l’aborto solo in caso di pericolo di vita per la madre, stupro e incesto – era intervenuto lo stesso governo.
Sostenendo che la legge federale prevale su quella statale e che per questo i medici dell’Idaho sono obbligati a rispettare la legge nota come Emtala (Emergency Medical Treatment and Labor Act), per la quale devono garantire l’aborto a donne che si trovano in situazioni di emergenza. Come la texana Kelsie Norris-De La Cruz, che racconta al Washington Post di essersi vista rifiutare una procedura d’emergenza anche se la sua gravidanza era extrauterina. Sebbene sulla carta la legge dell’Idaho (così come del Texas) garantisca l’interruzione di gravidanza in caso di pericolo di vita per la madre, i medici nella maggioranza dei casi non intervengono per timore delle conseguenze: rischiano incriminazioni per omicidio.
Nella sua decisione di ieri, la Corte suprema non entra nel merito della questione – se cioè davvero la legge federale abbia precedenza su quella dell’Idaho, che avrebbe stabilito un precedente per tutto il Paese – ma si limita a sospendere il proprio intervento finché la questione non verrà dibattuta nelle corti d’appello. Se dovesse tornare di fronte ai nove giudici costituzionali a supermaggioranza reazionaria non è detto che le donne dell’Idaho, e di tutti gli Usa, possano conservare questa piccola garanzia: di potere, perlomeno, ambire a sopravvivere.