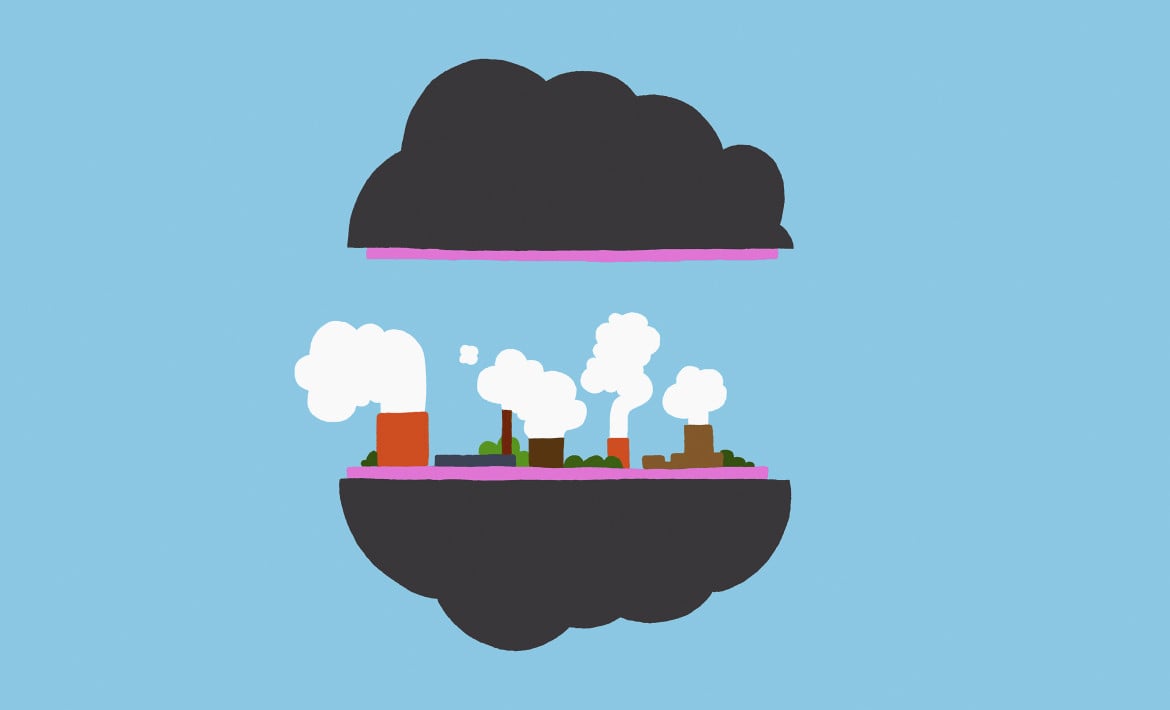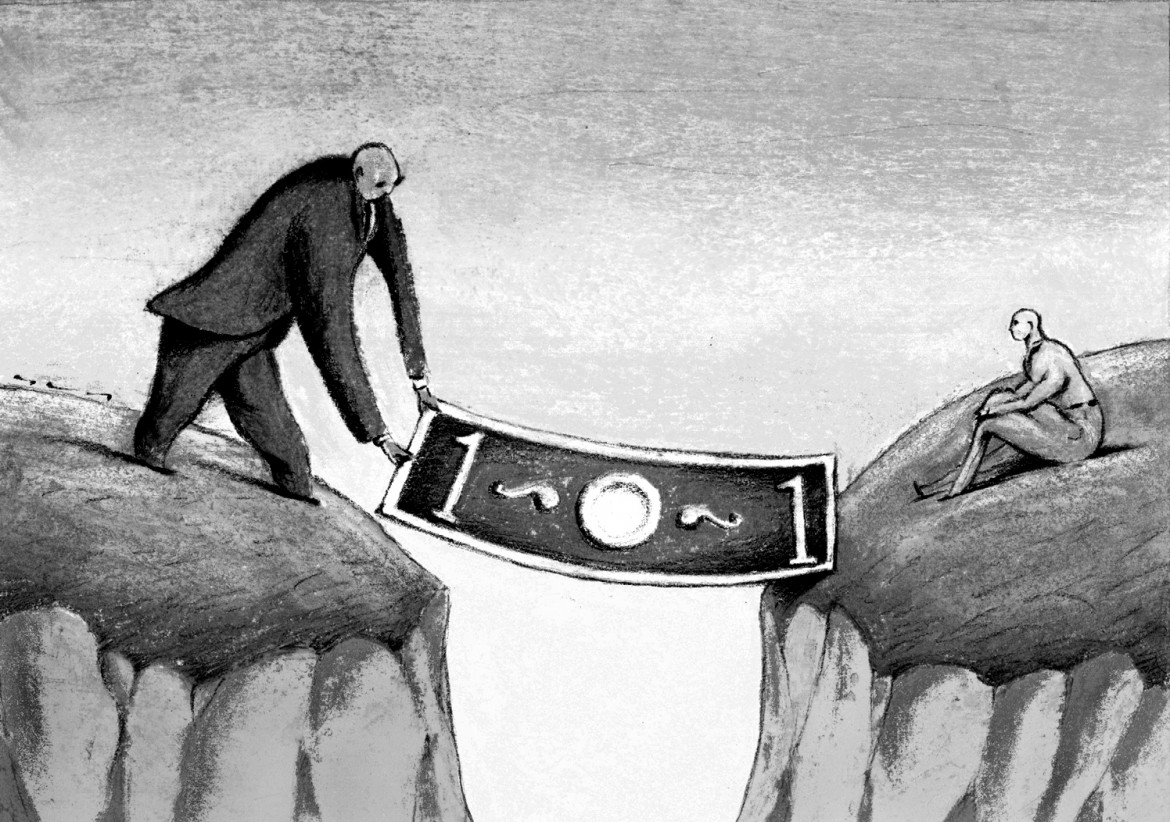La risoluzione presentata da Edoardo Fanucci e da altri renziani – in cui si mette in guardia il governo in carica dal ricorrere a un aumento di tasse su benzina e tabacchi, a copertura della richiesta di manovra aggiuntiva di 3,4 miliardi di euro, e si rivendica la linea della “riduzione delle tasse” come altamente caratterizzante l’azione del precedente governo Renzi – suscita una meritata ironia, visto anche che tale linea non è riuscita a evitare né la cocente sconfitta alle amministrative, né la debacle referendaria. Ma più dell’ironia serve un meditato approfondimento perché qui stanno un discrimine fondamentale della persistente faglia destra/sinistra – e dell’impossibilità di declinarla solo come distinzione “populisti”/”irresponsabili” – e un elemento cruciale della distintività di un Partito Democratico che rimanga tale, senza rifluire verso un indistinta formazione neocentrista. Infatti, il problema principale oggi del Pd è chiarire e approfondire il suo profilo ideale, progettuale e programmatico.
Il Pd, insieme all’intero nuovo Ulivo da costruire, deve innanzitutto reagire a una situazione verso cui per molti anni è stato subalterno e colluso, una situazione nella quale il duplice fondamentalismo (anti-stato e anti-tasse) proprio del neoliberismo – di destra – ha causato la pressoché totale scomparsa dalla scena pubblica di un dibattito meditato (non ideologico) sul ruolo dello Stato e sulla tassazione. In conseguenza di ciò le scelte di politica economica e fiscale spesso non sono sembrate più appartenere alla discriminante destra/sinistra: da entrambi i lati è apparso dominante un unico slogan, contrarre il “perimetro pubblico” e le tasse, senza che venisse posto il problema cruciale del limite sotto il quale la riduzione della tassazione può generare la devastazione dei servizi pubblici e la crisi del welfare e, al tempo stesso, depotenziare l’operatore pubblico nell’esercizio delle sue funzioni strategiche.
Non si tratta di riproporre la vecchia sinistra tax and spent. Si tratta di avere la consapevolezza che l’idea che le tasse siano un furto, un esproprio, un «mettere le mani nelle tasche dei cittadini» – parole che abbondavano e abbondano nel lessico di Berlusconi e oggi di Salvini e in molti esponenti dei 5Stelle – è un’idea, neoliberista, tipicamente di destra, sulla base della quale viene legittimato moralmente chi si sente autorizzato a evaderle. Invece, è di sinistra considerare le tasse un “contributo al bene comune” – parole della nostra Costituzione e di Papa Francesco, il papa che ha definito il neoliberismo «l’economia che uccide» – perché sono il mezzo con cui reperire le risorse necessarie a finanziare da un lato una redistribuzione egualitaria per le famiglie e per i cittadini, dall’altro strade, ferrovie, reti, scuole, ospedali, asili nido, riassetto idrogeologico, riqualificazione dei territori e delle città, Ricerca e Sviluppo e innovazione. Tutte cose per le quali servono l’esercizio di un “ruolo strategico” dello Stato, diretti interventi strutturali e piani straordinari di investimento pubblico per la creazione di “lavoro di cittadinanza”: non bastono trasferimenti monetari indiretti, quali sono i benefici fiscali e anche il “reddito di cittadinanza” (che non “promuove” ex ante lavoro ed eguaglianza ma “compensa” ex post ingiustizie e precarietà, le quali, però, così rischiano, non di essere combattute, ma di essere legittimate e sanzionate come status quo ritenuto immodificabile).
L’instabilità e l’incertezza che dominano l’economia globale, la riflessione in corso sui rischi di “stagnazione secolare”, i dilaganti populismi nazionalisti e xenofobi ci dicono con assoluta chiarezza che è richiesto come non mai uno Stato “strategico”, da coniugare in chiave europea, reclamando una “nuova politica industriale”, “lavoro” e “investimenti”, pubblici in particolare. In Italia – un paese che si conferma in serie difficoltà, avendo perduto più del 25% della propria capacità produttiva industriale, in un’Europa che ha il dovere di ritrovare un proprio progetto di integrazione – non ci si è comportati di conseguenza, perché non è stato attivato il “ruolo strategico” dell’intervento pubblico, esercitabile in special modo mediante “investimenti diretti” (dal 2008 crollati del 28% nell’Unione europea e del 30% in Italia) e assai meno con quell’indiscriminato “taglio delle tasse” e quell’ossessione di flessibilizzazione del mercato del lavoro (leggi Jobs Act) di cui Renzi ha fatto il marchio della sua politica economica, industriale e sociale, fino a ipotizzare una ristrutturazione dell’Irpef su due/tre aliquote, la quale somiglia sinistramente alla flat tax di Salvini e, prima ancora, di Tremonti.
Eppure, sono gli stessi Fmi e Ocse a segnalare che il moltiplicatore della spesa diretta in investimenti (fino a 3 in tre anni) è molto superiore a quello delle entrate (0,5, 0,7 appena). Il punto è che ha operato e opera la sudditanza a una forma di supply side economics (economia dal lato dell’offerta), di cui sono figlie anche una visione distorta delle infrastrutture e delle grandi opere, una declinazione di “Industria 4.0” fatta solo di stimoli fiscali, incentivi indiretti a pioggia, misure per le liberalizzazioni e per la competitività, l’insistenza sulle privatizzazioni (a proposito: è da notare che il sottosegretario Giacomelli ha usato argomenti molto convincenti per dichiararsi contrario all’ulteriore tranche di privatizzazione delle Poste!). A tutto ciò concorre anche un lettura della rivoluzione tecnologica in corso come “guidata dall’offerta”, un’offerta che, lungi dal dover essere sollecitata o tanto meno indirizzata, ha bisogno solo di incontrare il suo consumo, per cui l’unica cosa che conta è dare incentivi indiretti e fiscali alle imprese – richiesti ossessivamente dalla Confindustria – e potere d’acquisto (cioè trasferimenti monetari) ai consumatori.
Bisognerebbe imboccare tutta un’altra strada: di fronte ai rischi della jobless society e a una disoccupazione giovanile oltre il 40%, urge un Progetto di rilancio dell’economia della conoscenza e di rivitalizzazione dell’industria e dei servizi, un Piano di investimenti diretti (pubblici e privati) in aree cruciali e tuttavia in grado di attivare immediatamente nuova occupazione, non solo di stabilizzare quella che già c’è. Come era nel Piano del Lavoro della Cgil di Di Vittorio del 1949 e nel progetto di “Esercito del lavoro” di Ernesto Rossi, uno dei fondatori del Partito d’Azione e tra gli estensori del Manifesto di Ventotene: risanamento dei bellissimi ma fragili e martoriati territori italiani, rigenerazione delle città, riqualificazione ambientale, welfare, beni culturali, reti, scuola e università, formazione e sapere, sanità, bambini e adolescenti.