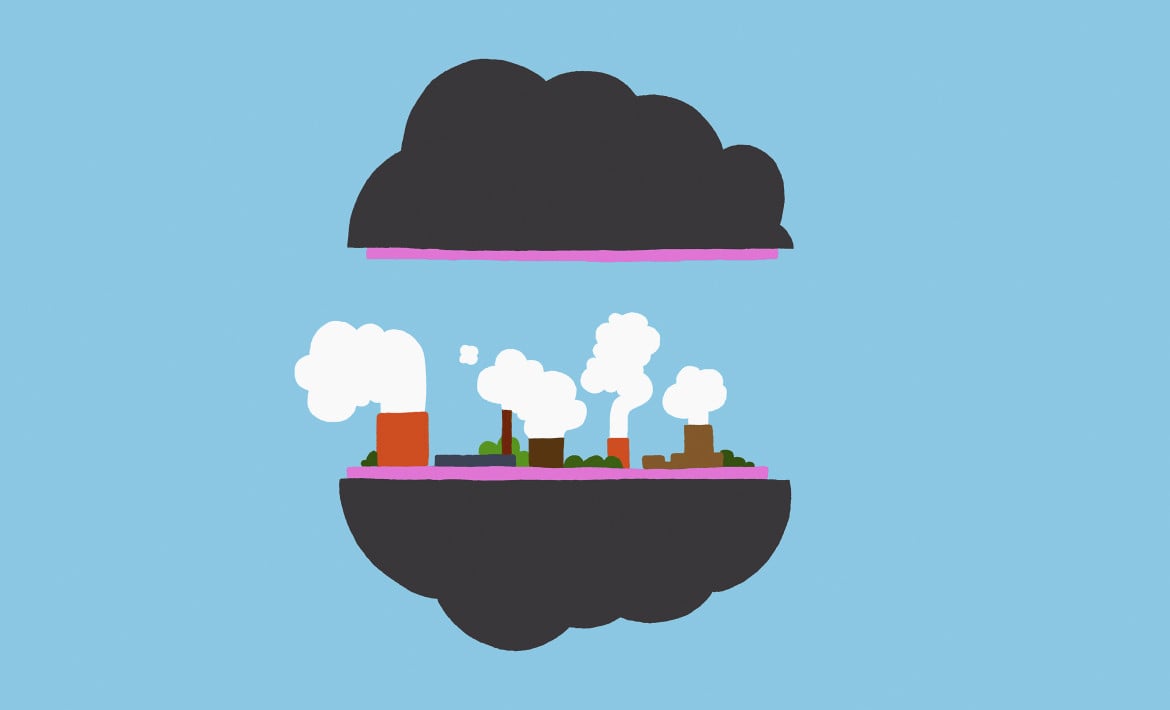L’attuale crisi presenta contrazioni del Pil che non si vedevano dalla prima metà del secolo scorso. Gli effetti di Lehman Brothers e della crisi dei debiti sovrani, in larga parte lievitati per salvare il sistema finanziario, non si erano ancora esauriti che esplode una pandemia con drammatici effetti sull’economia globale.
Gli anni Dieci sono stati spesi ad arginare la «Grande Crisi» attraverso politiche monetarie non convenzionali, ma ad esse non si è affiancata nessuna politica economica in discontinuità. Gli Stati e le loro politiche fiscali non hanno, fino al 2020, mai messo in discussione i dettami dell’«austerity».
Le banche centrali hanno permesso al sistema finanziario di non implodere ma senza mettere in discussione il modello di accumulazione entrato in crisi strutturale.
L’accelerazione delle politiche monetarie espansive, iniziata ben prima della diffusione del Covid-19, era segno di contraddizioni non risolte.
Alla montagna, mai vista prima, di moneta immessa nei circuiti, prevalentemente finanziari, oggi si aggiunge quella che in misura maggiore «sgocciolerà» (come affermano gli economisti) nell’economia reale nel tentativo di ridurre gli effetti di lungo periodo di un blocco produttivo che ha evidenziato fragilità che vanno ben oltre la crisi sanitaria.
La Fed ora compie un ulteriore passo che può apparire simbolico, ma che tale non è. Nel consueto raduno di Jackson Hole, il suo presidente Jerome Powell annuncia che il riferimento per le politiche monetarie statunitensi non sarà più l’inflazione al 2%, ma il suo valore medio.
Può apparire un gioco di parole, ma significa che la banca centrale americana, anche dopo la fine di un periodo prolungato con inflazione inferiore al 2%, potrà continuare a pompare moneta per un periodo equivalente fino a giungere a quel valore medio.
Le politiche monetarie non svolgeranno più un ruolo di raffreddamento dell’economia in prossimità del fatidico 2%, ma semmai interverranno successivamente. Viene così ridimensionata la logica dominante degli ultimi 30 anni.
L’inflazione torna ad essere, seppur in maniera per ora contenuta, un’opzione per arginare la crisi, per sostenere i meccanismi di accumulazione, evitare la deflazione e rendere più semplice il contenimento dell’indebitamento.
Questa decisione presuppone alcune novità rilevanti.
Intanto, come afferma Danilo Taino, un «cambio di approccio intellettuale» destinato ad avere effetti concreti.
Secondariamente si punterà a un certo ritorno dell’inflazione, ma questa avrà bisogno che la domanda, depressa dalla crisi e da quarant’anni di neoliberismo, venga sostenuta. Diversamente, il rischio che l’inflazione si determini solo in campo finanziario, come è accaduto finora, continuerà ad essere reale.
L’inusuale crescita contemporanea dei prezzi di azioni e oro ci dice che questa dinamica è ancora in corso.
Nei prossimi mesi potrebbe essere diverso per la dimensione dell’intervento espansivo, per alcune dinamiche di parziale «deglobalizzazione» e per la direzione di una parte della spesa pubblica.
La decisione della Fed avrà conseguenze sulle politiche monetarie globali.
Il dollaro, già debole, potrebbe ulteriormente svalutarsi favorendo le esportazioni dei prodotti a stelle e strisce.
Contromisure si imporranno anche per la Bce, seppur con le consuete lungaggini dettate dagli assetti istituzionali, e per le altre principali banche.
Si sostiene che la banca centrale giapponese non potrà inseguire la Fed in tali politiche in quanto le sue politiche non convenzionali sono già in corso da decenni con dubbi risultati. Ma la difficoltà giapponese parla proprio al presente.
La stagnazione di questa fase rivela la non autosufficienza delle politiche monetarie, esse hanno permesso di evitare un blocco del credito a livello sovranazionale.
Le banche centrali finiranno per aumentare ulteriormente il loro protagonismo, ma ora la palla passa ai governi e di visioni strategiche non se ne vedono. Però attenzione, il campo da gioco sta mutando rapidamente.