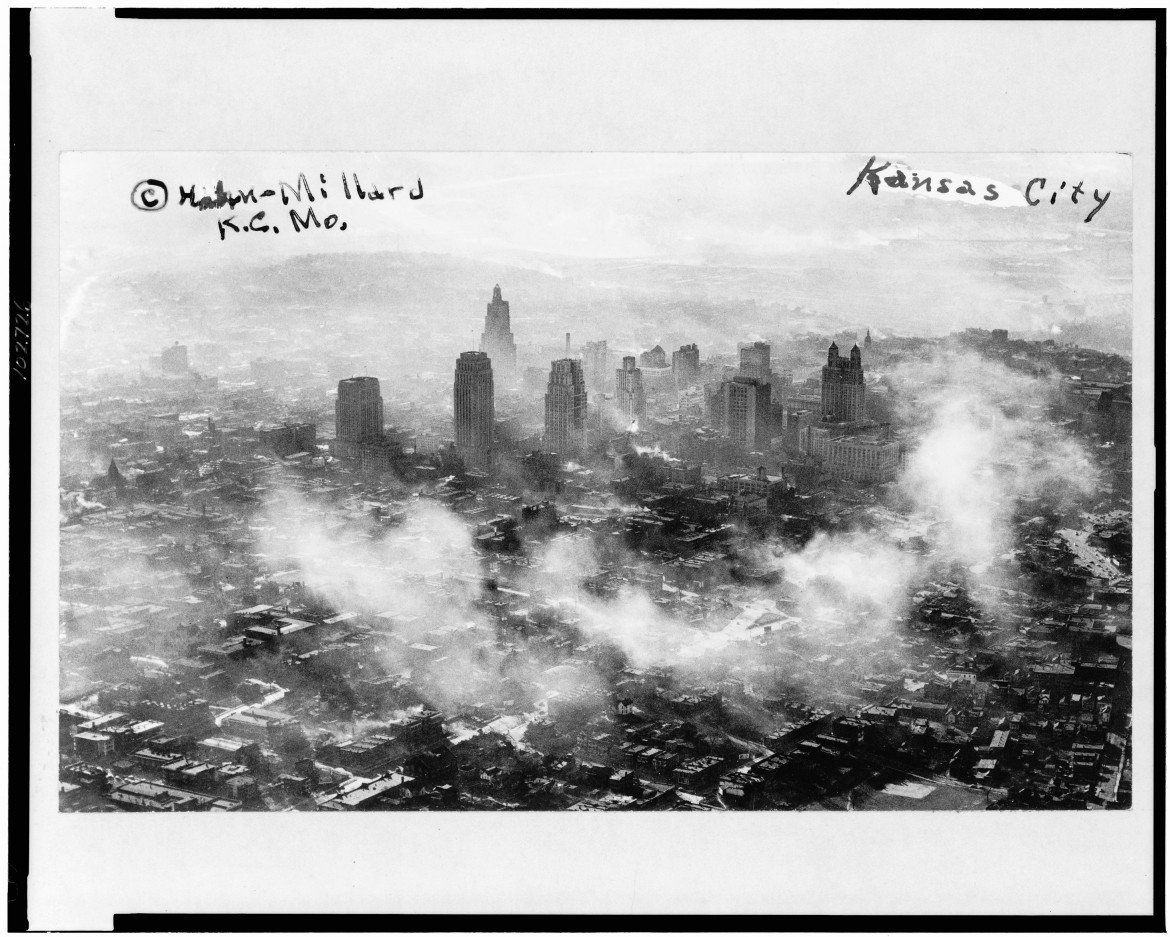Il più dandy tra i grandi giornalisti americani si è spento ieri sera a New York, ucciso da un’infezione a 87 anni. Con i suoi immancabili completi bianchi, mai smessi dal 1962, Tom Wolfe aveva portato nella metropoli del nord il tocco un po’ alla Rhett Butler del sud, della Virginia in cui era nato. Scriveva articoli come fossero romanzi e romanzi con l’occhio attento a registrare ogni sommovimento culturale e sociale del giornalista di gran classe. Nessuno più di lui, neppure Truman Capote che aveva aperto la strada, ha smantellato le tradizionali barriere tra giornalismo e letteratura.
QUELLO STILE, consapevolmente ricercato e adottato, è stato poi definito New Journalism e Tom Wolfe ne è stato il fondatore, il modello, il nume tutelare.
I suoi libri li hanno letti in tanti, ma molti di più, anche in Italia sono quelli che lo citano, spesso senza saperlo e magari a sproposito. Ogni volta che accusiamo qualcuno di essere «radical-chic» adoperiamo il termine da lui coniato in un famosissimo articolo del 1970, la cronaca di una serata organizzata nell’appartamento di lusso di Leonard Bernstein, nel cuore dell’Upper East Side, per raccogliere solidarietà e fondi a favore del Black Panther Party.
Era un articolo, poi raccolto in volume, spietato e affilato come un rasoio, ma realistico. Wolfe era un conservatore, gran sostenitore di George Bush nelle elezioni del 2004, diffidente verso tutti i vezzi e le mode liberal ma assolutamente onesto. A tutt’oggi chi volesse sapere davvero cosa sono stati gli hippies d’America, quali il loro linguaggio, lo stile di vita, la visione del mondo, non troverebbe di meglio che il suo eccezionale L’Acid Test al Rinfresko Elettriko, il racconto scritto nel 1968 dall’avventura di Ken Kesey e dei suoi Merry Pranksters, dai viaggi su e giù per gli States sull’autobus giallo guidato dal reduce beat Neal Cassady ai grandi acid tests in cui venivano servite agli ospiti, senza avvertirli, bibitoni d’aranciata corretta all’Lsd, con sullo sfondo i Grateful Dead che suonavano le prime note psichedeliche, avanguardia di un esercito di band che avrebbe popolato di lì a poco l’intera California.
Qualunque altro giornalista dell’epoca, e anche di quelle successive, si sarebbe accontentato di descrivere una vicenda che, in quel momento, era al centro della scena culturale negli Usa e in mezzo mondo. Wolfe non si accontentò. Sapeva che per restituire la realtà della controcultura hippie non bastava raccontarla ma bisognava ricorrere agli strumenti propri del romanziere, lavorare a fondo sul linguaggio.
MISE A FRUTTO l’esperienza e la sperimentazione già portata avanti in numerosi articoli, già raccolti nel volume del 1965, La baby aerodinamica kolor karamella, ventidue pezzi su argomenti disparati ma tenuti insieme dallo stile rivoluzionario e inimitabile dell’autore. Riuscì a fotografare come nessuno dopo di lui la realtà della controcultura californiana, senza sarcasmo, superiorità o toni sprezzanti, con una partecipazione anche emotiva insospettabile in un uomo così distante dalla cultura psichedelica.
Come aveva immortalato un’epoca, ne registrò anche il declino in un altro articolo destinato a fare storia, nel quale coniava una nuova definizione destinata a diventare di uso comune negli Usa quanto «radical-chic», The Me Decade, quello che noi chiamiamo «Riflusso». L’ultimo centro come giornalista Wolfe lo mise a segno nel 1979 con The Right Stuff, sull’addestramento degli astronuati americani, un best seller diventato poi un film altrettanto fortunato.
MA IL GIORNALISMO ormai gli andava stretto. Per raccontare gli anni ’80, l’epopea grottesca e tragica degli yuppies di Wall Street, scelse di slittare verso il romanzo, ma senza sacrificare le lenti del giornalista. Incrociò la saga degli yuppies con le tensioni razziali, l’impennata delle diseguaglianze sociali, la cronaca delle trasformazioni di New York. Aveva in mente un modello preciso, La fiera delle vanità di Tackeray, e gli rese un omaggio esplicito fin dal titolo del suo primo, fortunatissimo romanzo del 1987, Il falò delle vanità. Il suo capolavoro sia come giornalista che come romanziere.
Wolfe riesce, infatti, non solo a rendere sin nei particolari la mitologia megalomane che animava gli yuppies, il declino di valori che la loro ascesa aveva implicato negli anni ’80 ma anche a coglierne l’intrinseca fragilità, il loro essere usati, premiati ma anche gettati via senza esitare da poteri economici e finanziari ben più solidi e persino più cinici.
Quel risultato magistrale Tom Wolfe non è mai più riuscito a raggiungerlo. Il suo secondo romanzo, Un uomo vero, uscito undici anni dopo, fu un best seller, soprattutto per le attese suscitate dal libro precedente, ma l’equilibrio perfetto tra narrazione romanzesca e cronaca sociale del Falò era già distante e i due romanzi successivi, Io sono Charlotte Simmons del 2004, sul declino delle università americane, e Le ragioni del sangue del 2012 sono stati entrambi dei flop clamorosi.
FORSE PER UN AUTORE già vicino agli ’80 tentare di restituire la realtà dei giovani americani del nuovo millennio, nei costumi, nel modo di parlare e pensare, come aveva fatto quasi quarant’anni prima con gli hippies era davvero una sfida troppo azzardata.
Eppure, nonostante i suoi limiti, Charlotte Simmons resta un quadro d’insieme sui campus del 2000 straordinario almeno dal punto di vista dell’inchiesta se non da quello della maestria narrativa, a conferma del grandissimo talento che il gentiluomo vestito di bianco della Virginia ha dimostrato sempre dai primi articoli, alla fine degli anni ’50, fino all’ultimo romanzo.