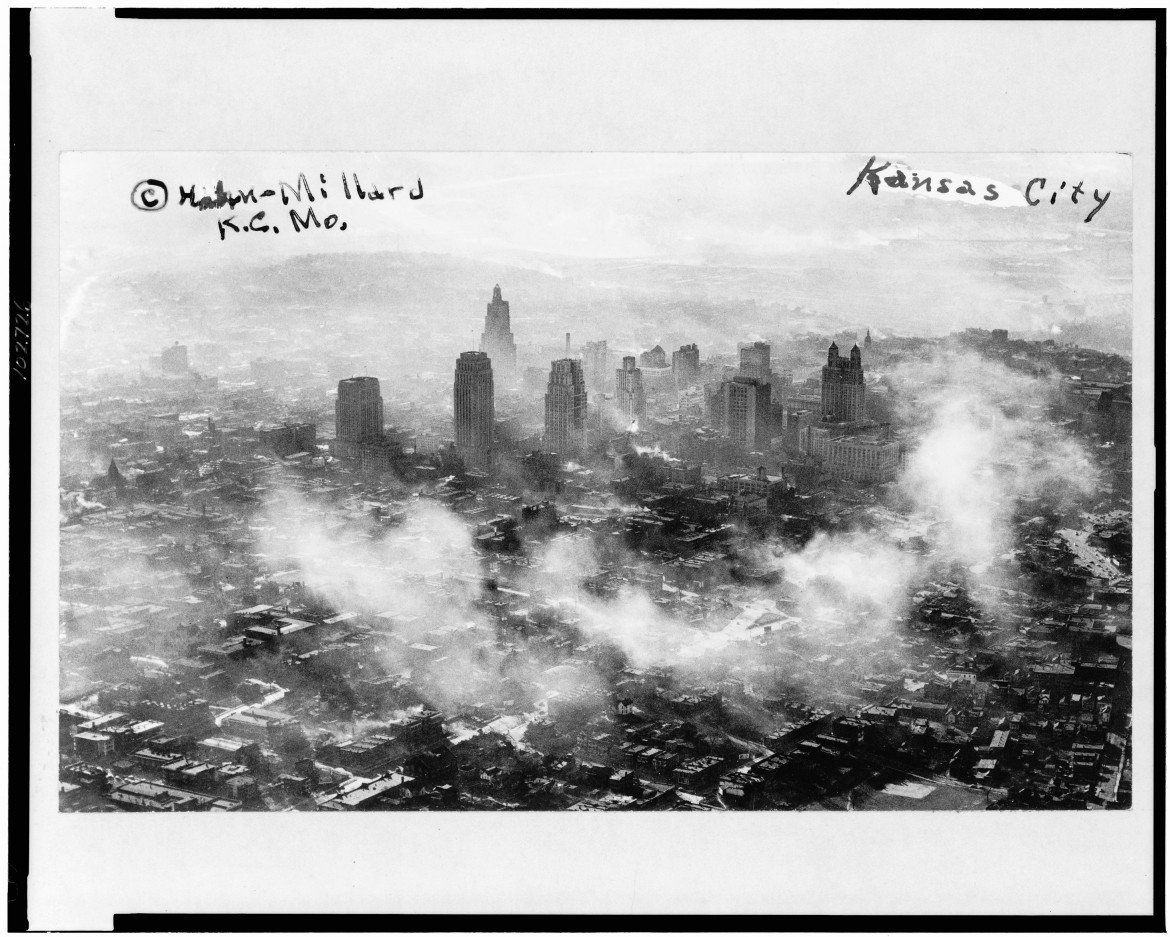In un recente documentario HBO su Steven Spielberg, il grande critico americano Jim Hoberman (non un fan abituale del regista) nota come, con gli anni, l’autore di ET sia diventato «una specie di intellettuale pubblico», il portavoce di un discorso critico sull’ America contemporanea per l’audience di massa.
L’urgenza del presente, e un omaggio al cinema di attivismo politico anni settanta, di cui però Spielberg, figlio della cinefilia, non condivide il Dna, sono sicuramente le forze che animano The Post, l’ultimo lavoro del regista (nei cinema italiani a febbraio), concepito in velocità, la primavera scorsa, tra il fallimento di Il grande gigante gentile e l’uscita, il marzo prossimo, di Ready Player One.
Un film di attori (Meryl Streep e Tom Hanks, più un supporting cast di prestigio), strappato ai titoli di testa dei giornali e (sembra, nella texture) evolutosi con loro in corso di lavorazione, tra due studi di sperimentazione narrativa/tecnologica dedicati a Roald Dahl e al VR.
Sulla carta, The Post ha l’aspetto di un viaggio nel tempo. La giungla verde in cui apre – su note stridenti: i Doors secondo John Williams – è quella del Vietnam. Quella grigio-bianca di mausolei di pietra e palazzi vetrati in cui si sposta subito dopo è la giungla di Washington – primavera 1971.
Il gallese Matthew Rhys, agente Kgb protagonista di The Americans, è un’ottima scelta per il ruolo di Daniel Ellsberg, l’analista militare della RAND Corporation che, dopo aver toccato con mano il disastro nel Sudest asiatico, rivoluzionò l’opinione pubblica rilasciando ai media i Pentagon Papers, lo studio commissionato da McNamara per ricostruire il coinvolgimento politico Usa in Vietnam, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale.
Antesignano di Chelsea Manning ed Edward Snowden, Ellsberg (che oggi ha 86 anni ed ha appena pubblicato un libro sul programma nucleare americano, dai Sixties ai nostri giorni) non è però «la storia» di questo film. Spielberg lo liquida infatti poco dopo aver riassunto in un’unica, efficacissima, inquadratura – un istante in cui Ellsberg, la valigetta piena dei documenti segreti, esita davanti alla guardia, prima di uscire per sempre dall’ufficio – il dilemma interiore dell’analista: sul fatto che sia un patriota non ci sono (più) dubbi. È un dato della Storia.
Il film decolla infatti quando Ellsberg esce di scena e il racconto si sposta tra i vertici del «Washington Post» e la sua redazione, ricostruita per gli spettatori già in All The President Men, e nel cui spazio aperto la macchina di Spielberg scorrazza con la stessa dinamica determinazione di quella di Alan Pakula. Mondo maschile, romanticamente «ingrato», a base di inchiostro, camicie stropicciate, notti solitarie passate alla macchina da scrivere e take out da poco, la newsroom del Post è capitanata come una caravella corsara da Ben Bradlee (Tom Hanks, la cui grisaglia una taglia più stretta del dovuto tradisce un’esuberanza da frontiera western che mal tollera il controllo sartoriale della burocrazia).
Ma il vero padrone è un altro. Anzi, un’altra. Virtualmente invisibile in Tutti gli uomini del presidente, la proprietaria del «Washington Post», Katharine Graham è la protagonista della parabola che vuole raccontare Spielberg, un’avventura di riscossa femminile e di trionfo del free speech attuale nell’America di Donald Trump come in quella di Richard Nixon.
Figlia del finanziere repubblicano Eugene Meyer che, nel 1933, aveva acquistato il quotidiano della capitale a un’asta post bancarotta, Graham era stata sorpassata alla successione del Post a favore di suo marito, Phil Graham. Nella sua autobiografia e in parecchie interviste concesse negli anni, lei ha dichiarato di non aver mai preso la scelta di suo padre come uno sgarro, bensì come una mossa logica.
Fu il destino a riparare l’ingiustizia quando, dopo il suicidio del consorte, Graham si trovò suo malgrado, e improvvisamente, alle redini della testata. Streep, nei panni della prima donna ad entrare nei Fortune 500, e la cui dirigenza rese possibile l’exploit giornalistico del Watergate, ce la presenta inizialmente un po’ esitante. I boys del Cda la trattano con l’indulgenza che si usa per una doyenne dei salotti democratici che, giornalisticamente parlando, può aspirare al massimo a un redesign del supplemento Style.
Quello che Spielberg tesse tra la finto-sprovveduta signora e il suo burbero, rompicollo, direttore Bradlee, è un pas-de-deux raffinato che si movimenta quando, dopo che un’ingiunzione legale impedisce al «New York Times» di continuare la pubblicazione dei Pentagoni Papers, il Post deve decidere se andare avanti o no. In gioco, tuona il coro di Cassandre al Cda, è l’imminente ingresso del Post su Wall Street, l’appoggio delle banche. Ma è a un’altra reputazione che Graham sta pensando. Sarà lei la più lungimirante, anche se sulle scale della Corte Suprema, dopo una vittoria storica del primo emendamento, tutti vogliono parlare solo con il padrone del «NY Times», Arthur Sulzberger.
Spielberg chiude questo suo romanzo di formazione con un’inquadratura sulla Casa bianca. La voce che proviene dall’interno è quella di Nixon, che ordina la messa al bando del «Washington Post». Potrebbe essere una classica tirata anti-media di Trump. E il film si chiude sullo stacco successivo: tre finestre illuminate in un palazzo d’uffici. «Pronto, polizia? Credo sia in corso un break in al Watergate». Un semplice auspicio, o una profezia per il 2018?