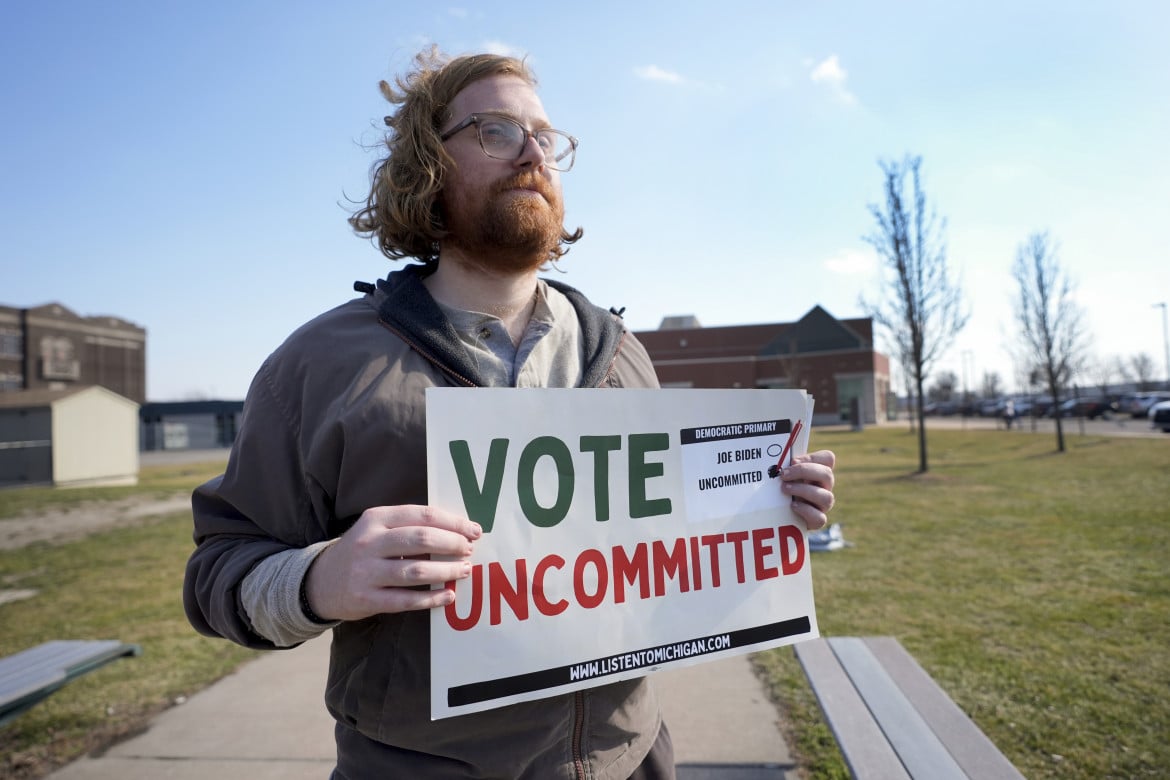Nel terzo dibattito repubblicano (su un totale di 11 in programma) i candidati hanno replicato il copione dei primi due con minime variazioni. Sul palco dell’università del Colorado i pretendenti alla nomination Gop sono saliti in due turni in base alla graduatoria nei sondaggi: prima la squadra “B” composta dal teocon di origini lombarde Rick Santorum, i governatori George Pataki (New York) e Bobby Jindal (Louisiana) e il falco “sudista” Lindsey Graham, tutti con gradimenti attorno all’1%. Dopo il sipario di apertura, nel format vagamente da reality show è toccato ai “big”, disposti, come in una gara di nuoto coi “potenti” (sempre in base ai sondaggi) al centro e i deboli ai lati.
Nel mezzo della formazione quindi Donald Trump e Ben Carson, i due outsider che dominano tuttora la gara, con crescente costernazione degli strateghi di partito. Il miliardario smargiasso Trump, il neurochirurgo afroamericano Carson devoto integralista cristiano (e l’ex manager conservatrice della Hewlett Packard, Carly Fiorina) rappresentano il contingente dei non politici di professione che da mesi ormai raccolgono ampi consensi della destra articolando un populismo d’effetto a base di ricette casarecce come «lo splendido muro sul confine» di Trump («e lo faccio pure pagare ai messicani!») o il codice fiscale modellato sulle decime dell’antico testamento proposto da Carson.
Formule improbabili acclamate tuttavia dall’elettorato delle primarie che selezionano lo zoccolo duro ideologico del partito, nel nome di un diffuso sentimento “antipolitico”. Il paradosso repubblicano è che i “ribelli” sono tuttavia considerati ineleggibili nelle elezioni generali quando le loro esternazioni difficilmente troverebbero il consenso di una maggioranza nazionale che dovrà necessariamente includere componenti di giovani, donne e minoranze etniche. Le speranze repubblicane l’anno prossimo saranno quindi probabilmente affidate ad uno dei candidati attualmente di “secondo rango”.
Nell’ultimo dibattito quello che è emerso più positivamente è stato Marco Rubio, il giovane senatore della diaspora cubana di Miami che ha calcato sulla riconoscenza per i sacrifici della mamma immigrata e il successo di self-made man; una formula collaudata in una fase di campagna in cui contano più le “narrazioni” che i programmi. In Colorado Rubio ha anche avuto la meglio in un paio di scontri diretti col “compatriota” della Florida, Jeb Bush, ad oggi la grande delusione del partito.
Il centrismo moderato dell’ex predestinato alla nomination non trova per ora riscontro e la riduzione del 40% nell’organico del suo staff elettorale annunciate la scorsa settimana getta ombre ancora più lunghe sulle sue effettive prospettive.
Malgrado il coro di lamentele per la mancanza di «elementi concreti», l’obbiettivo dei candidati in questi confronti – soprattutto con 14 aspirati ancora in lizza – è di mettersi in luce con una battuta fortunata e scavalcare qualche posizione con una frecciata ben piazzata. Così Bush ha irriso l’assenteismo di Rubio in parlamento definendolo da «settimana lavorativa francese». Chris Christie, il «bulldog del New Jersey» ha chiesto di essere sguinzagliato contro Hillary, Ted Cruz, agitatore del tea party ha definito le primarie democratiche un confronto fra «bolscevichi e menscevichi».
Tutti d’accordo invece sull’attaccare la «stampa mainstream» e gli stessi moderator del dibattito, accusati di essere venduti ai democratici fra i fragorosi applausi della platea conservatrice. Un raro sprazzo di lucidità è stato espresso dal governatore dell’Ohio John Kasich che riferendosi agli attuali frontrunner ed alle loro astruse proposte ha detto «ragazzi sarà meglio che ci svegliamo. Non è pensabile nominare un dilettante qualunque che ovviamente non è in grado di governare». La frase era calcolata per migliorare l’attuale gradimento del governatore (2,6%) ma esprimeva il dilemma repubblicano, un partito con la maggioranza assoluta in congresso che stenta ad esprimere una voce unitaria.
Uno sbando vieppiù in evidenza ieri con l’insediamento a Washington del nuovo speaker Paul Ryan. La sua nomina è stata resa necessaria dalle dimissioni del predecessore John Boehner, vittima di una fronda della corrente di destra che reclama intransigenza ad oltranza contro Obama.