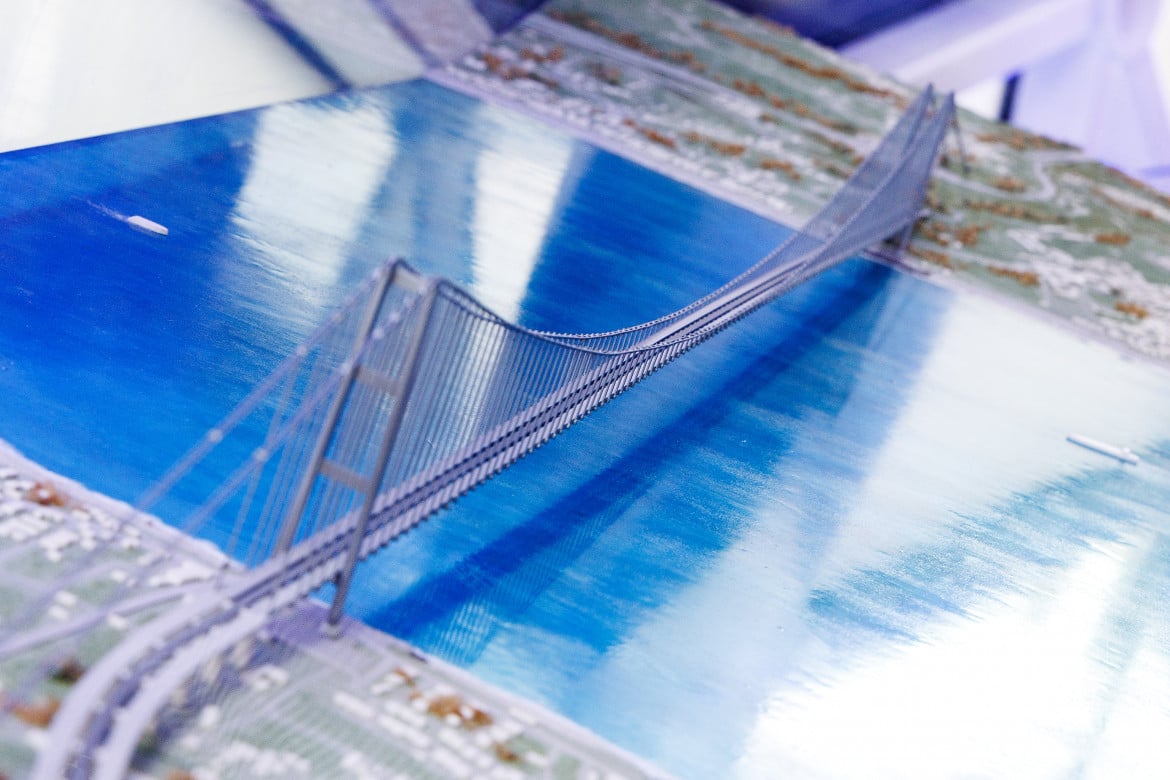La cruda verità sul comparto fossile. Si può sintetizzare così l’esteso data base reso pubblico ieri alla Cop26 di Glasgow dalla Ong tedesca Urgewald, insieme ad altre realtà della società civile internazionale tra cui Greenpeace Italia e ReCommon.
LO STUDIO ANALIZZA 887 società petrolifere e del gas, che rappresentano più del 95% della produzione globale di idrocarburi. Mentre istituzioni insospettabili come l’Agenzia Internazionale per l’Energia chiedono di lasciare gas e petrolio sotto terra, il rapporto dimostra che negli ultimi tre anni le big del settore hanno investito ben 168 miliardi di dollari per esplorare nuovi giacimenti, con le cinesi PetroChina (6 miliardi) e China National Offshore Corporation (2,8 miliardi) a guidare la fila, subito incalzate però dall’anglo-olandese Shell (2,4 miliardi). Una spasmodica ricerca che poi si trasforma in produzione di barili. Sebbene tante aziende difettino in trasparenza, Urgewald ha potuto riscontrare che 506 società stanno per aggiungere almeno 190 miliardi di barili di petrolio in un arco di tempo che va da uno a sette anni. Le più attive sono Qatar Energy (20 miliardi), la russa Gazprom (17 miliardi) e la Saudi Aramco (15 miliardi).
ANCHE SUL FRONTE midstream, delle infrastrutture, lo scenario è allarmante: ci sono attualmente 211.849 chilometri di oleodotti e gasdotti in via di sviluppo. Se i tubi fossero posati senza soluzione di continuità e puntati verso il cielo, arriverebbero a metà strada tra la Terra e la Luna. Le prime cinque società costruttrici di oleodotti e gasdotti sono Gazprom, PipeChina, Sinopec, China National Petroleum Corporation e l’indiana Gail.
IN BASE AL RAPPORTO, l’italiana Eni si colloca nella top-20 dei produttori di petrolio e gas, e attraverso la sua controllata Vår Energi tra le prime dieci società che sfruttano le risorse della Regione artica, soprattutto con le piattaforme petrolifere nel Mare di Barents. Se i rischi connessi alla produzione di idrocarburi presentano caratteristiche comuni a ogni latitudine, nell’Artico aumentano esponenzialmente: le condizioni estreme non fanno che accrescere le possibilità di fuoriuscite e incidenti, minacciando ecosistemi già fragili. A ciò si aggiunge il sempre più rapido scongelamento del permafrost sulla terraferma e, sul fronte marino, quello dei depositi di metano, che rischiano di rilasciare enormi quantità di gas serra nell’atmosfera.
“ENI SI CONFERMA ESSERE la peggior azienda italiana in termini di impatti sul clima del Pianeta”, sottolinea Luca Iacoboni, responsabile Energia e Clima di Greenpeace Italia. “Nei prossimi decenni inoltre intende continuare a cercare, estrarre, vendere e bruciare gas fossile e petrolio, addirittura aumentando la produzione negli anni a venire”, il suo grido d’allarme.
INCROCIANDO I DATI del data base con quelli finanziari in loro possesso, Greenpeace e ReCommon denunciano come Intesa Sanpaolo si confermi la banca nemica del clima n.1 in Italia. Nel solo 2020, l’istituto di credito torinese ha investito in sei delle otto società dei combustibili fossili che figurano nelle tre principali categorie dello studio presentato alla Cop26, ovvero cioè la top-20 dei principali produttori di idrocarburi, la top-20 di chi ha intenzione di espandere il proprio business e la top-20 di chi ha speso più soldi nelle esplorazioni di nuovi idrocarburi.
«EXXONMOBIL, SHELL, TotalEnergies, BP, Chevron ed Equinor hanno beneficiato di investimenti pari a 604 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo», spiega Simone Ogno di ReCommon, aggiungendo che nel solo 2020 la principale banca italiana ha concesso a Eni prestiti per 866 milioni di euro e investimenti pari a 183 milioni di euro. Un connubio che fa tutt’altro che bene al clima.
«Negli ultimi 3 anni investiti 168 miliardi per nuove estrazioni di gas e petrolio»
Cop26. La denuncia delle Ong sui big del fossile. Sono 887 aziende: totalizzano il 95 per cento della produzione globale di idrocarburi

Estrazione di petrolio - Ap
Cop26. La denuncia delle Ong sui big del fossile. Sono 887 aziende: totalizzano il 95 per cento della produzione globale di idrocarburi
Pubblicato 2 anni faEdizione del 5 novembre 2021
Luca Manes, GLASGOW
Pubblicato 2 anni faEdizione del 5 novembre 2021