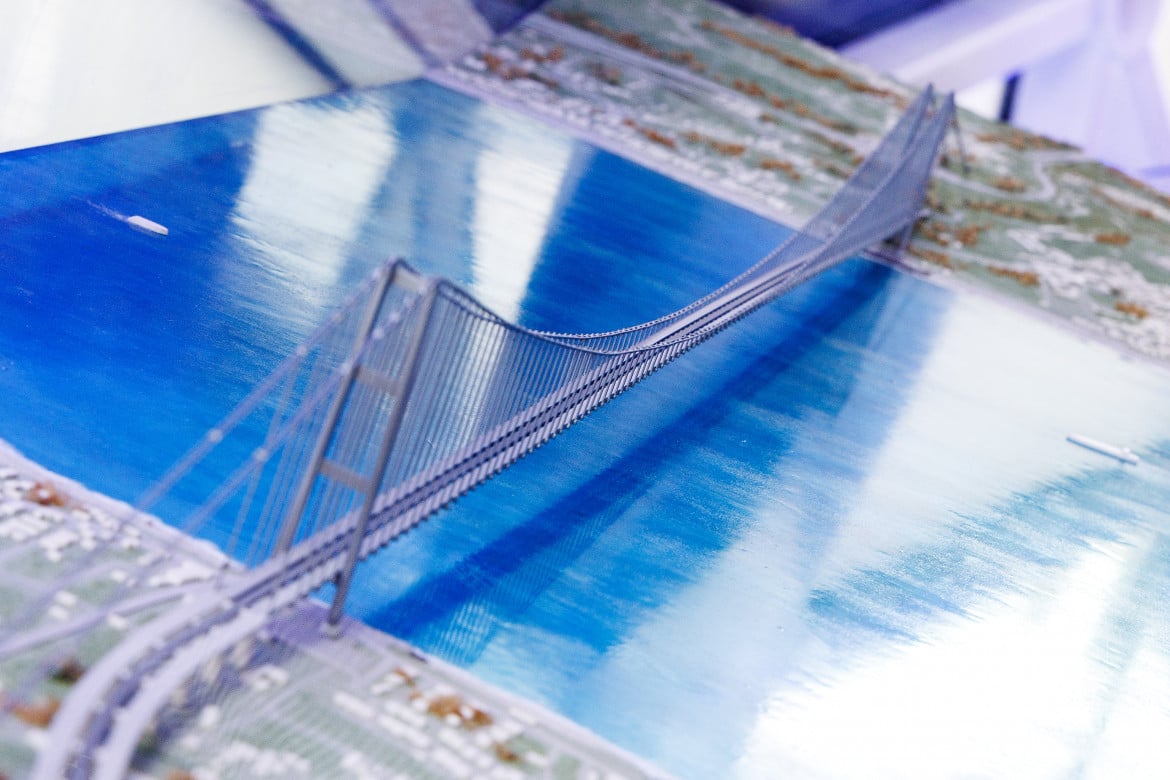Racconta Ann Pettifor che l’idea di un «Green New Deal» nacque a casa sua, a Londra, alla vigilia del crac di Lehman Brothers. Un gruppo di ambientalisti ed economisti inglesi trascorse molte serate a discutere, «dibattendo furiosamente, tra un bicchiere di vino e l’altro», di come cambiare l’economia e proteggere l’ambiente. I dibattiti proseguirono durante la crisi finanziaria e furono alimentati da quest’ultima. Nel luglio del 2018, il piano è finito nell’agenda elettorale della democratica americana Alexandra Ocasio-Cortez, e poi in quelle del candidato della sinistra americana Bernie Sanders e del leader laburista inglese Jeremy Corbin. Sconfitto nelle urne, difficilmente sarà riproposto nella sua versione più radicale dal candidato democratico statunitense Joe Biden e dal neosegretario dei laburisti inglesi Keir Starmer.
Ann Pettifor, che è un’economista di stampo keynesiano, già leader del movimento Jubilee 2000 per la cancellazione del debito, ne ha scritto in un libro ora pubblicato anche in Italia, Il Green new deal, cos’è e come possiamo finanziarlo (Fazi, pp.208, traduzione di Thomas Fazi), ripercorrendone la storia, le differenze con la proposta dei democratici americani e soprattutto delineandone i contenuti.
«Per anni gli ambientalisti hanno trattato l’ecosistema quasi come se questo fosse indipendente dal sistema economico dominante, che si basa su una finanza deregolamentata e globalizzata», esordisce. Invece, è il presupposto di partenza, se si vuole incidere davvero sull’ecosistema bisogna aggredire frontalmente il paradigma neoliberista, cambiare l’economia per trasformare l’ambiente. Non a caso, un capitolo del libro, una sorta di manifesto del Green new deal, si intitola «Cambiare il sistema, non il clima». Come? Controllando la politica monetaria, riportando a casa i capitali nascosti nei paradisi fiscali e più in generale cambiando gli equilibri di potere all’interno del sistema «globalizzato e dollarizzato».
Per far questo, a suo parere, sono necessarie politiche congiunte, mentre «gli ecologisti tendono a concentrarsi sulle azioni individuali o al massimo su quelle di quartiere», scrive. I movimenti ambientalisti da soli non bastano e neppure gli accordi internazionali. «Se vogliamo aiutare davvero gli attivisti dei Fridays for future o di Extinction Rebellion, è necessario un intervento dall’alto, internazionale. È altresì centrale il ruolo dello Stato.
Citando il John Maynard Keynes di Autosufficienza nazionale («le idee, il sapere, la scienza, l’ospitalità, il viaggiare, dovrebbero essere internazionali, ma lasciare che le merci siano fatte in casa ogni qualvolta ciò è ragionevolmente e praticamente possibile e, soprattutto, che la finanza sia eminente nazionale»), Pettifor pensa che un paradigma alternativo dovrebbe essere fondato sulla ri-localizzazione. L’economista inglese guarda a Slow food come esempio di una trasformazione possibile, e virtuosa, dell’economia in senso localistico. Allo stesso tempo, pensa che gli stati debbano avere il controllo del denaro e «proteggere la propria economia» controllando i flussi di capitale.
Più che con la mai citata sinistra europea, il Green new deal di Ann Pettifor interloquisce criticamente con i cugini d’oltreoceano. Se è vero che il suo sguardo è rivolto soprattutto alla Gran Bretagna, che dai tempi di Margaret Thatcher ha sostituito la produzione di beni materiali con la finanza, ciò nondimeno le analisi e il modello che propone abbracciano l’intero globo. È il neoliberismo, in fin dei conti, la gramigna da estirpare alla radice se si vuole salvare il pianeta dal collasso ambientale. Per far questo, Ann Pettifor recupera la matrice più ortodossa della sinistra inglese, quel radical-keynesismo sopravvissuto agli anni della «terza via» blairiana e incarnato negli ultimi anni da Jeremy Corbin. Ne deriva un euroscetticismo di fondo, fondato sulla critica alla cessione di sovranità monetaria che lascia campo libero alle scorribande finanziarie ma, io credo, più profondamente legato a una concezione autarchica, tradizionale, dello Stato.