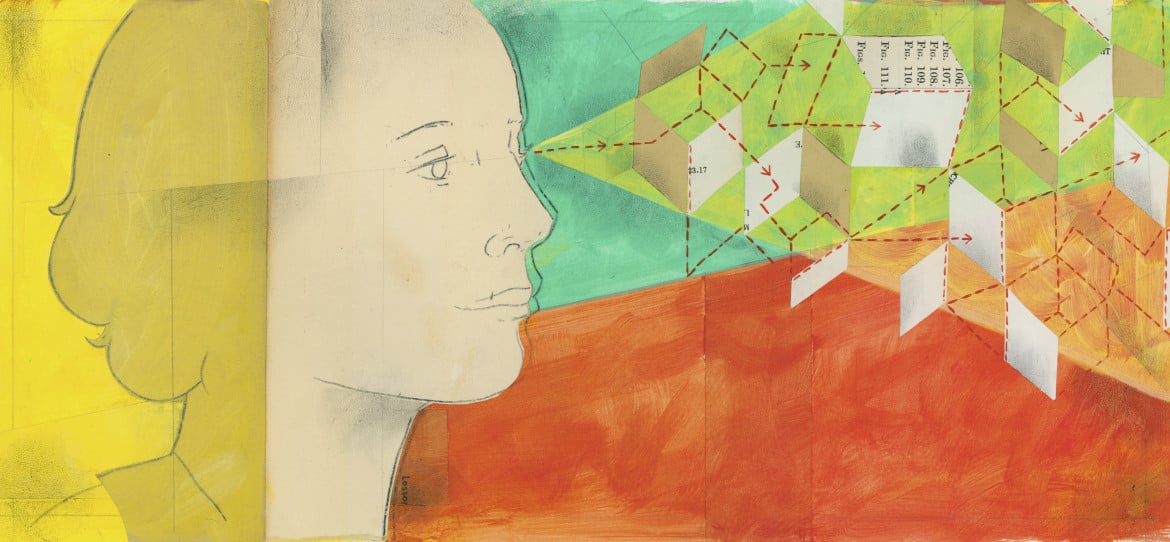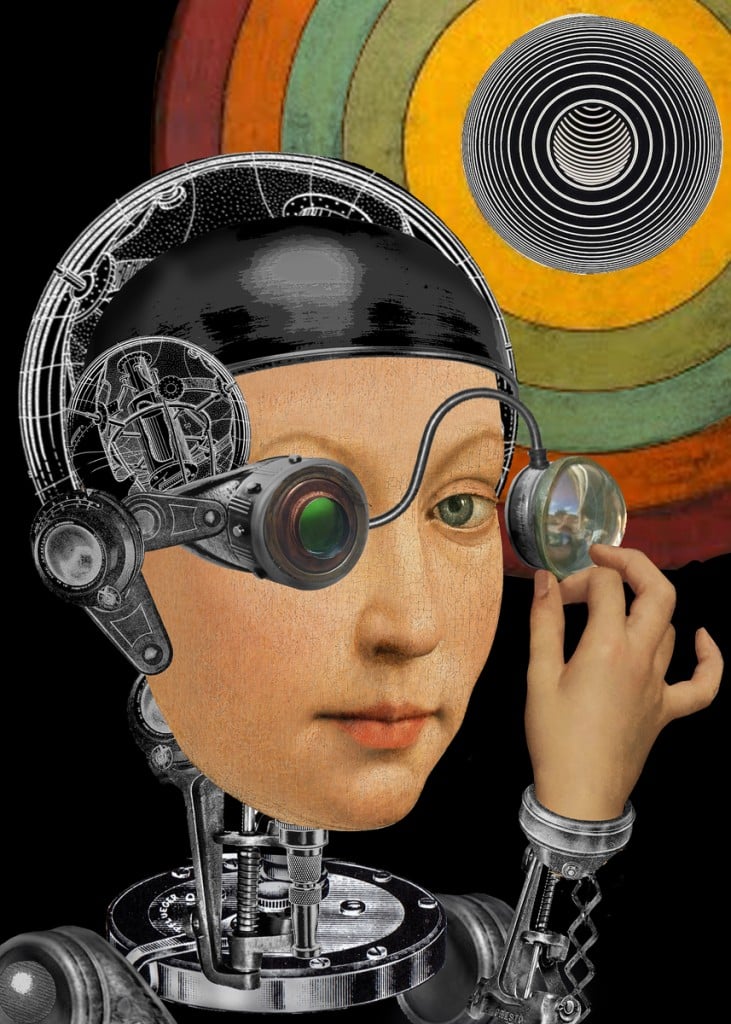In un film del regista Sergio Arau, A Day Without a Mexican, uscito negli Stati uniti nel 2004, una nebbia improvvisa fa sparire dallo stato della California tutti i latino-americani. Musicisti, giornalisti, camerieri, sportivi, cuochi, giardinieri, medici, babysitter scompaiono senza lasciare traccia, dimostrando, con un solo giorno di assenza, come la società e il «sogno americano» si reggano sul lavoro di immigrati e immigrate.
Lo slogan lanciato per lo sciopero globale delle donne dell’8 marzo 2017 («Se le nostre vite non valgono noi non produciamo, allora scioperiamo») è estremamente efficace proprio perché si pone sul filo di un simile, incredibile eppure assolutamente verosimile, paradosso. Non a caso negli Usa la protesta, filiazione della Women’s March contro l’elezione di Donald Trump, ha assunto il nome di A Day Without a Woman.
Una delle ultime stime prodotte sul lavoro di cura non retribuito delle donne a livello mondiale, pubblicata da McKinsey nel 2015, corrisponde alla stratosferica cifra di diecimila miliardi di dollari, una somma equivalente, più o meno, al Prodotto interno lordo della Cina. Ciò che manca oggi è una proxy del valore prodotto dal lavoro delle donne, ma non solo da loro, dentro contesti più larghi ma in un eguale regime di gratuità, nei contesti della riproduzione sociale, dai social media alle varie piattaforme che costellano la vita quotidiana degli abitanti del pianeta. Bisogna partire da qui, dal lavoro non calcolato eppure sfruttato, dall’estendersi esponenziale del paradigma di precarietà che al modello del lavoro femminile si ispira, per capire l’essenza di questo sciopero internazionale delle donne. Un tentativo di risposta alla violenza di un potere che allarga la cattura ai campi del vivente, man mano che assimila i diktat dei mercati finanziari e assume la certezza dell’immunità rispetto a ogni forma di controllo collettivo. L’effetto complessivo che genera sul soggetto questa torsione, tra assenza di diritti, pressione della responsabilità e della colpa, incremento della meccanismo debitorio, mancanza di rappresentanza e negazione di autonomia, obbligo a emergere e a dimostrare di valere, è potentemente depressivo. La necessità di sottrarre la vita a tali precipizi, urgente.
La crisi del welfare contemporaneo, connessa alla crisi economica globale e alla crisi fiscale degli stati-nazione, introduce ulteriori asimmetrie: si può parlare di una inclusione differenziale o di una precarietà differenzialmente distribuita meno direttamente connessa al genere maschile ma che resta assurdamente collegata a una funzione produttiva sempre immaginata come espressione di lavoro standard (tradizionalmente maschile) per il mercato. Il principio dell’inclusione all’interno della cittadinanza è ancora una volta collegato al lavoro produttivo, sulla base di talune caratteristiche di impegno contrattuale e di tempo. Il lavoro femminilizzato (cioè il lavoro non standard, come da sempre il lavoro delle donne, che diventa paradigmatico) dei precari e delle precarie finisce per essere considerato fuori dalla cittadinanza, benché si tratti di una porzione ormai maggioritaria della popolazione e non solo femminile.
D’altro lato, è il concetto stesso di «produzione» e di «lavoro» (modellato sulla produzione materiale fordista, sul lavoro di fabbrica, sul male bradwinner) che va svuotandosi o che va cambiando di segno. Crisi del lavoro salariato ed esplosione del lavoro riproduttivo, del lavoro sociale. La produttività è in calo perché è in calo il lavoro salariato tradizionalmente inteso. Inoltre, le forme di «misura» sono ritagliate su un modello ben preciso, solo apparentemente «universalistico», mentre trasversale a questi processi è la precarizzazione e la dequalificazione del lavoro.
Necessitiamo dunque di nuovi strumenti di welfare che rispondano a un insoluto atavico in grado di contrastare una diseguaglianza di diritti di cui le donne per prime hanno fatto le spese, nonostante l’apparente universalità. Il reddito di base può rappresentare anche questo possibile antidoto, a patto che venga inteso come variabile direttamente remunerativa della riproduzione sociale oggi gratuitamente erogata, quindi a patto che sia incondizionato. Non a caso, una delle parole d’ordine all’interno dello sciopero globale dell’8 marzo è quella del reddito di autodeterminazione: un reddito per scegliere e vivere secondo le inclinazioni di ciascuna e ciascuno. Una premessa necessaria (ancorché non sufficiente) per sviluppare una vera cooperazione sociale, al di fuori dei meccanismi di cooptazione e di mercificazione a tutti i livelli (il corpo e la mente) che l’odierno capitalismo ci impone.
Il neoliberismo spinge le donne a introiettare la logica economica, a soggiacere a un meccanismo che trae profitto dalla differenza e contemporaneamente la deprime perché la integra. Il punto nodale diventa allora quello di avvertire le inquietudini in cui siamo testimoni. Attivare un processo di soggettivazione che consenta un processo di cura di sé, ovvero il distacco da ciò che è codificato, che consenta di disimparare, di disfarsi di cattive abitudini, di false opinioni ricevute, di immaginari mendaci. Di identità che non ci appartengono. Questa economia, questo lavoro che pretendono di prendersi tutto il senso all’interno della nostra vita non ci appartengono. Dunque oggi, 8 marzo 2017, noi scioperiamo.