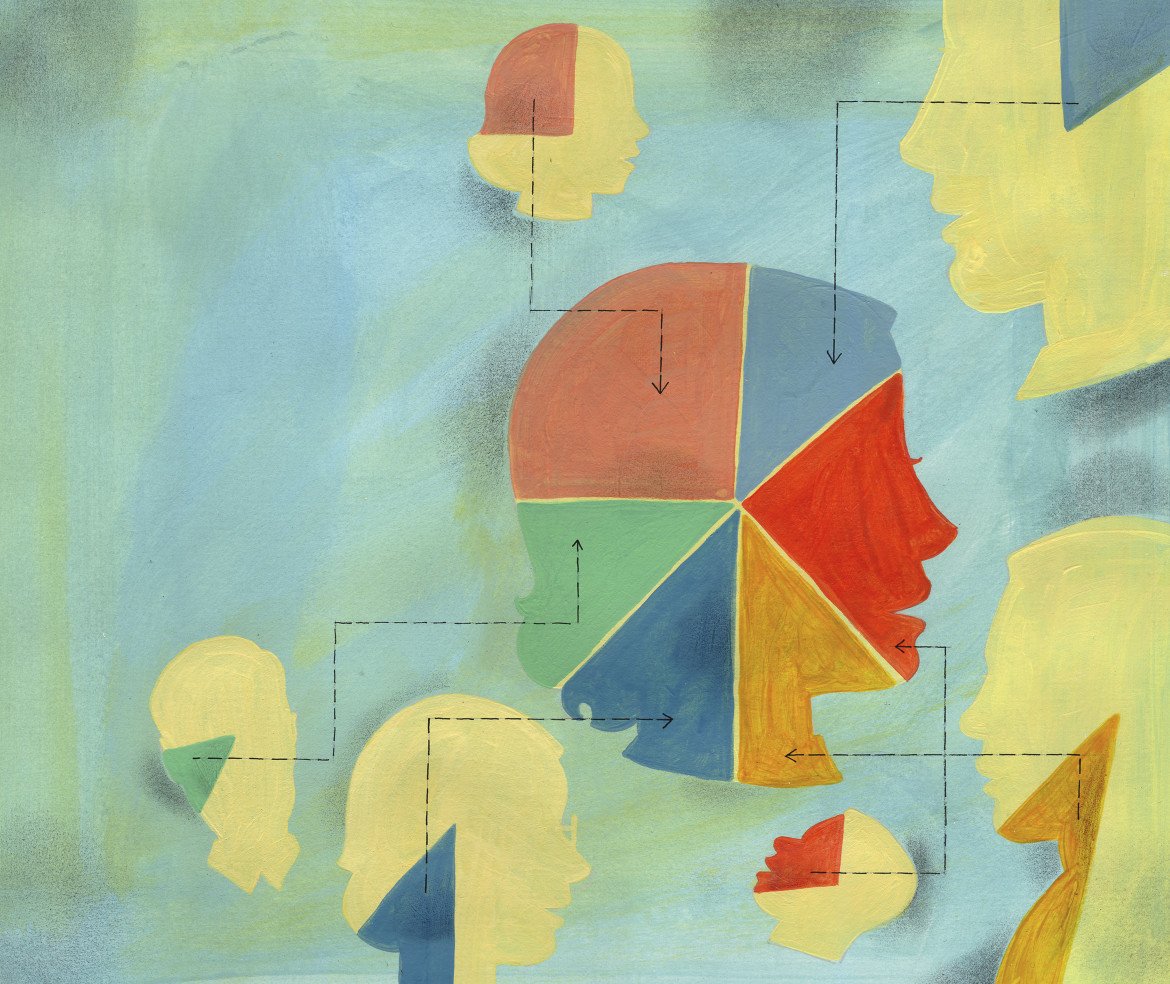Pubblicato 4 mesi faEdizione del 26 aprile 2024
Per me la giustizia non è un’idea astratta che si impara sui libri, ma tutto il contrario. È un dolore in corpo che comincia a farsi sentire nello stomaco e che deve uscire fuori, dal quale si può guarire solo agendo, urlando, lottando e opponendosi con tutta la forza possibile. Sì, un senso di Giustizia che non mi ha più lasciata, neanche nei momenti più bui. Avevo la convinzione di essere dal lato giusto della storia. Mi dicevo: «Ada sei solo una piccola operaia, ma stai partecipando a qualcosa di grande, e per questa Idea vale la pena combattere, a...